|
Due chiacchiere con… Paolo Fresu
Palermo, 5 giugno 2003
di
Antonio Terzo

A margine della rassegna "Musiche del nostro tempo" organizzata la scorsa estate dal Brass Group di Palermo, abbiamo intervistato Paolo Fresu, impegnato nella riproposizione del
Porgy & Bess trascritto da Gunther Schuller secondo la versione di Gil Evans e Miles Davis del 1958.
Antonio Terzo:
Partiamo dalle tue collaborazioni, davvero tantissime e tutte prestigiose:
dai maggiori musicisti italiani come Franco D'Andrea, Furio Di Castri, forse i primi a credere in te, Bruno Tommaso, uno dei primi a dirigerti, Giorgio Gaslini, Enrico Rava,
Antonello Salis, Massimo Urbani, Enrico Pieranunzi e tanti altri, a quelli europei ed americani come Aldo Romano, Kenny Wheeler, John Taylor, Dave Liebman,
Dave Holland, Phil Woods, Pierre Favre, Gerry Mulligan,
John Zorn, Palle Danielsson, John Abercrombie, Jerry Bergonzi,
Richard Galliano, Ralph Towner, Gunther Schüller, Mal Waldron, Paul McCandless, Jim Hall, Lew Soloff. Di tutti questi grandi, chi ti ha lasciato un ricordo particolare?
Paolo Fresu:
Le collaborazioni naturalmente sono tutte importanti. Mi piace ricordare quella con Dave Liebman, nell'86, ero agli inizi. Dave è un personaggio fantastico, era già conosciutissimo, un grandissimo musicista. E' venuto in Sardegna per registrare
 Inner Voices
(Splasch Records), il mio secondo disco, noi eravamo giovanissimi, lui un musicista così prestigioso, grande disponibilità, grande didatta, un'umanità straordinaria. Poi ci siamo rivisti, siamo diventati amici. Mi piace pure ricordare l'incontro con Kenny Wheeler e con John Taylor, con cui poi ho stabilito dei rapporti di lavoro. Con John abbiamo suonato un periodo con Furio Di Castri, la settimana scorsa ci siamo incontrati a Vicenza con Maria Pia De Vito e Ralph Towner… Inner Voices
(Splasch Records), il mio secondo disco, noi eravamo giovanissimi, lui un musicista così prestigioso, grande disponibilità, grande didatta, un'umanità straordinaria. Poi ci siamo rivisti, siamo diventati amici. Mi piace pure ricordare l'incontro con Kenny Wheeler e con John Taylor, con cui poi ho stabilito dei rapporti di lavoro. Con John abbiamo suonato un periodo con Furio Di Castri, la settimana scorsa ci siamo incontrati a Vicenza con Maria Pia De Vito e Ralph Towner…
A.T.:
C'è un disco che testimonia questa combinazione…
P.F.:
Sì, si chiama
Contos
[Fresu-DiCastri-Taylor, Egea Records, n.d.r.]… John è stato anche invitato a Nuoro, a tenere un master ai Seminari che dirigo. Con Kenny c'è più un rapporto di lavoro, ci si vede prevalentemente per i concerti… Mi piace ricordare l'esperienza con Gerry Mulligan, nell'Orchestra della Pace che ho costituito al Festival di Sanremo, [nel 1986, n.d.r.]. Poi con Mulligan ci siamo rivisti poco prima che se ne andasse, per un disco con
Ornella Vanoni di qualche anno fa. Poi tante altre, Jon Hassel, con il quale abbiamo suonato assieme a Milano proprio la settimana scorsa, Paul McCandless, Aldo Romano che è stato parte del mio percorso…
A.T.:
Tra questi a chi devi tanto, professionalmente ed anche umanamente?
P.F.:
Devo molto a quelli con i quali ho avuto un rapporto non fugace, perché tutti quelli con cui ho avuto un rapporto continuo, con cui ho fatto una tournée o ho fatto diversi concerti mi hanno lasciato un segno importantissimo… E poi amo stare con dei musicisti che siano anche persone con le quali si può parlare d'altro al di là della musica. E nella maggior parte dei casi – o forse sono stato fortunato io – la caratura artistica coincide con una grande capacità umana. Non farei dei nomi perché tutto sommato un po' tutti mi hanno lasciato un segno profondo, anche se in modo diverso.
A.T.:
Chi ti ha mai fatto il più bel complimento, e chi invece ti ha "bacchettato"?
P.F.:
Uno dei più bei complimenti me lo ha fatto Chet [Baker, n.d.r.] nell'84-'85. Suonai al Festival di Sanremo, un quartetto con Andrea Pozza ed altri, e lì suonava anche lui. Ero molto timido, avevo iniziato a suonare da poco, e ricordo che eseguii
'Round Midnight, e alla fine del concerto comparve Chet, quasi dal nulla, e mi disse: «Complimenti, hai suonato una bella versione di 'Round Midnight». Naturalmente son rimasto sconvolto da questa cosa… Circa le "bacchettate", devo dire che di vere e proprie non ne ho ricevuto, perché più che di bacchettate parlerei di consigli, suggerimenti che possono servire per migliorare, e che normalmente vengono da quelle persone che per esperienza possono permettersi di dare un consiglio.
A.T.:
Parliamo di premi. Ne hai ricevuti tantissimi: ma ricordi quale è stato il primo?
P.F.:
Fu quello di RadioUnoJazz, nell'84. Subito dopo venne quello di Musica Jazz come "miglior talento". Però RadioUno lo ricordo in particolare perché abitavo ancora in Sardegna, uscivo poco, cominciavo appena a suonare in giro, avevo già le collaborazioni con Bruno Tommaso, Paolo Damiani, ma ero agli inizi. Ricordo che mi arrivò questa telefonata a casa in cui mi annunciavano questo premio e rimasi molto colpito, perché suonavo da poco, ritenevo che in Italia ci fossero musicisti ben più capaci. Poi un premio che mi ha fatto molto piacere è stato quello di Musica Jazz, nel '90, quando vinsi in tutte e tre le categorie, come "miglior musicista", "miglior disco" con
Live in Montpellier, e "miglior gruppo" [Paolo Fresu Quintet, n.d.r.]. E poi il primo Django D'Or in Francia nel '96,
 probabilmente la mia consacrazione internazionale. Ne ho avuto tanti altri, ma mi piace ricordarne uno in particolare che non è un premio, piuttosto una sorta di onorificenza: la Cittadinanza Onoraria della città di Nuoro. Mi ha fatto molto piacere perché sono molto legato alla Sardegna, Nuoro è una città che vivo molto perché lì dirigo i Seminari di Jazz dal 1989. Trovo che Nuoro sia un po' la capitale della cultura sarda, per cui questo avermi insignito di una onorificenza così prestigiosa, che poche volte è stata data in città, è stato per me un segno di affetto molto importante. Ognuno vale molto, ma questo di Nuoro ha un'altra valenza, perché mi è stato conferito non solamente in quanto musicista, ma un po' come ambasciatore della musica ed anche amante e continuatore di un percorso legato alla tradizione, alla lingua, cose nelle quali credo molto. probabilmente la mia consacrazione internazionale. Ne ho avuto tanti altri, ma mi piace ricordarne uno in particolare che non è un premio, piuttosto una sorta di onorificenza: la Cittadinanza Onoraria della città di Nuoro. Mi ha fatto molto piacere perché sono molto legato alla Sardegna, Nuoro è una città che vivo molto perché lì dirigo i Seminari di Jazz dal 1989. Trovo che Nuoro sia un po' la capitale della cultura sarda, per cui questo avermi insignito di una onorificenza così prestigiosa, che poche volte è stata data in città, è stato per me un segno di affetto molto importante. Ognuno vale molto, ma questo di Nuoro ha un'altra valenza, perché mi è stato conferito non solamente in quanto musicista, ma un po' come ambasciatore della musica ed anche amante e continuatore di un percorso legato alla tradizione, alla lingua, cose nelle quali credo molto.
A.T.:
Forse un emergente senza passato alle spalle prende bene tutto ciò che gli arriva. Ma tu ti trovi oggi, non più emergente né promessa – semmai affermazione –, a fare i conti con quanto sei andato seminando in questi 20 anni: come ci si sente a fare i conti con il proprio passato, le attese e le aspettative suscitate?
P.F.:
Per me è stato molto facile entrare nel cuore del mondo del jazz, cosa abbastanza rara. Vengo da un paese isolato, da un'isola, da una tradizione familiare assolutamente non di musicisti. Rispetto ad altri per me è stato molto più facile diventare musicista professionista, quasi un gioco: a un certo punto mi sono ritrovato a vivere di musica senza neppure averlo deciso. Chiaramente il mio caso non rappresenta quello della maggior parte dei musicisti italiani, la mia carriera non è esplicativa, né in quegli anni né in questi. Partendo da questo, ritengo che sia stato facile per me trovarmi in una dimensione professionistica come musicista: trovo che sia molto più difficile ora. Se non è stato difficile entrare, raggiungere un certo status, però è molto più difficile restarci dentro, perché implica, come dici, delle responsabilità: ci sono una serie di onorificenze, di premi, tanto lavoro svolto. Per cui la difficoltà oggi è di vivere la musica cercando di scegliere quelle cose che credo siano importanti, quindi vedere il musicista non dal punto di vista di un mestiere, ma come qualcosa in cui la giustificazione delle scelte viene perché credi che quello che stai facendo possa avere un valore, un senso, e non viene da motivazioni economiche. E' difficile gestire tutte queste cose. Anche perché il mio modo di essere musicista non riguarda solamente il jazz: mi muovo molto a 360 gradi, non solamente con la musica ma anche con le arti in genere, per cui amo molto l'arte contemporanea, mi piacciono tutti i discorsi artistici. Quindi, ritenendomi comunque un musicista di jazz, cerco non solamente di suonare musica al di là degli stili, ma anche di mettere in relazione con la musica tutte quelle forme d'arte che secondo me possono convivere. Questo mi ha portato ad organizzare un festival internazionale di jazz nel mio piccolo paese, ad organizzare dei seminari. Sono un artista investito di più funzioni, e ciò può essere rischioso nel momento in cui si confondono i ruoli. E' molto importante allora cercare di tenere ben distanti ruoli ed obiettivi dell'essere operatore culturale, direttore di un festival, dell'essere musicista che gira. Nonostante questo, spero di riuscire a portare avanti la mia missione in modo possibilmente obiettivo.
A.T.:
In Italia, un tempo non c'erano tutte le scuole che invece esistono oggi: eppure il jazz di casa nostra, fatte le dovute eccezioni, resta piuttosto "provinciale", ossia relegato ad una dimensione marginale o comunque ad una realtà in prevalenza nazionale. Secondo te, cosa manca al jazz italiano, e soprattutto ai jazzisti italiani, per riuscire ad affermare le proprie note, pur pregevoli, anche all'estero?
P.F.:
Direi che oggi la situazione è molto più interessante di prima, anzi direi che in questo momento il jazz italiano goda di buona salute: jazz italiano è sinonimo di qualità, anche all'estero. Nonostante questo, è pur vero che i musicisti italiani conosciuti sono davvero pochi, siamo pochi quelli che lavoriamo veramente, mentre invece vedo che ci sono dei musicisti straordinari, giovani che suonano benissimo e meriterebbero di più, avrebbero diritto ad entrare nel mondo internazionale della musica. Certamente in Italia c'è una sorta di scollamento tra i musicisti, c'è sempre stato, l'artista è un po' solitario.
 Manca forse la fiducia in noi stessi, e credo che questo sia purtroppo un difetto degli artisti, ma anche un difetto pilotato da una realtà di politica culturale italiana poco attenta a quello che succede in casa nostra, per cui i musicisti hanno maturato una sorta di "negatività cronica" – anche se il termine è un po' grosso – che deriva dal fatto che si sentano poco considerati… Credo che in Italia manchi fare del jazz, e le Istituzioni dovrebbero rendersi conto che il jazz è la musica di oggi, è la musica del '900 per antonomasia, la musica che rappresenta tutte le musiche del '900, e in quanto tale, nel momento in cui racconta un momento storico ben preciso è una musica nazionale. Quindi, in quanto musica nazionale, così come l'opera o altri generi, avrebbe bisogno di un'attenzione – anche in vista di finanziamenti, festival, eccetera – che permetterebbe al musicista di avere un attimo di respiro. Tutte queste cose in Italia mancano, nonostante oggi ci siano in effetti una miriade di festival, una miriade di scuole, etichette discografiche, ma, per esempio, poca gente compra dischi italiani. Il mercato francese di dischi di jazz è quattro volte superiore a quello in Italia. Io sono uno dei musicisti che vende di più, ma qui vendo tre-quattromila copie, che in Italia sono tantissime: in Francia ne vendo quindicimila o ventimila… Diciamo che il jazz italiano avrebbe bisogno di quella spinta, di quello scatto che faccia sì che questa musica divenga più apprezzata e più popolare. Manca forse la fiducia in noi stessi, e credo che questo sia purtroppo un difetto degli artisti, ma anche un difetto pilotato da una realtà di politica culturale italiana poco attenta a quello che succede in casa nostra, per cui i musicisti hanno maturato una sorta di "negatività cronica" – anche se il termine è un po' grosso – che deriva dal fatto che si sentano poco considerati… Credo che in Italia manchi fare del jazz, e le Istituzioni dovrebbero rendersi conto che il jazz è la musica di oggi, è la musica del '900 per antonomasia, la musica che rappresenta tutte le musiche del '900, e in quanto tale, nel momento in cui racconta un momento storico ben preciso è una musica nazionale. Quindi, in quanto musica nazionale, così come l'opera o altri generi, avrebbe bisogno di un'attenzione – anche in vista di finanziamenti, festival, eccetera – che permetterebbe al musicista di avere un attimo di respiro. Tutte queste cose in Italia mancano, nonostante oggi ci siano in effetti una miriade di festival, una miriade di scuole, etichette discografiche, ma, per esempio, poca gente compra dischi italiani. Il mercato francese di dischi di jazz è quattro volte superiore a quello in Italia. Io sono uno dei musicisti che vende di più, ma qui vendo tre-quattromila copie, che in Italia sono tantissime: in Francia ne vendo quindicimila o ventimila… Diciamo che il jazz italiano avrebbe bisogno di quella spinta, di quello scatto che faccia sì che questa musica divenga più apprezzata e più popolare.
A.T.:
Quindi in Francia questo tipo di aiuti, di promozione da parte delle Istituzioni c'è…
P.F.:
Beh, sì. Innanzitutto in Francia c'è uno status del lavoratore della musica molto diverso da quello italiano. I musicisti vengono aiutati, quando non lavorano hanno degli aiuti, c'è un meccanismo complesso che funziona, e questo è già importante. E poi si vendono più dischi perché c'è un sistema di vendita e distribuzione che funziona di più, c'è la FNAC [Fédération Nationale d'Achat des Cadres, n.d.r.], che finalmente sta arrivando anche in Italia. Ci sono festival (ma quelli ci sono anche in Italia), e soprattutto in Francia c'è un pubblico più ampio che poi compra i dischi di jazz, che sono il miglior veicolo per i musicisti di jazz. Non intendo affatto dire che in Francia ci siano musicisti più bravi che in Italia: al contrario, secondo me, in Italia in questo momento c'è una grandissima qualità. Ma questa grande qualità non va di pari passo con la possibilità che tutti questi musicisti abbiano l'opportunità di farsi sentire, sia in Italia sia fuori dall'Italia. Per raggiungere quest'obiettivo occorrerebbe un sistema che, in una sinergia di tutti i diversi ruoli, renda il jazz una forma artistica da esportare, come l'opera, la moda, la cucina. Perché trovo che il jazz italiano in questo momento rappresenti bene anche un mondo tipicamente italiano, diverso da quello del jazz francese, del jazz spagnolo, del jazz tedesco.
A.T.:
Ma cosa è il jazz per Paolo Fresu?
P.F.:
Secondo me il jazz oggi è una parola vuota. Sì, esiste il jazz, esiste il jazz degli anni '30, però esistono anche varie forme di jazz… Oggi nei festival passa di tutto, eppure si chiamano festival di jazz. Il jazz è la musica del '900, secondo me, ed è una musica in cui l'aspetto improvvisativo è estremamente presente. Però non si può neanche dire che il jazz è lo swing, perché se prendiamo Ornette Coleman o
Albert Ayler, che sono musicisti di jazz, sicuramente un disco come Free Jazz
di Ornette, niente avrebbe a che fare con lo swing. Quindi direi che quando si parla di jazz si parla di swing, quando si parla di swing si parla di tempo, ma ci sono delle forme di jazz che non hanno né swing né tempo! Allora secondo me il jazz è un termine che è stato mutuato a suo tempo e che ci siamo portato appresso, però indubbiamente oggi jazz è una parola che ci sta stretta, perché pure quando suono con un musicista tunisino questo viene presentato come un concerto di jazz; io stesso sono musicista di jazz e mi sento tale a tutti gli effetti, ma mi rendo conto che alcune volte ci sono forme e suoni che con il jazz possono avere poco a che fare. Direi che il jazz oggi dovrebbe indicare una musica che ha un alto grado di improvvisazione e grande rispetto verso il suono acustico che in qualche modo fa sì che resti una forma artigianale che si muove attraverso un vocabolario espressivo, quello che proviene dagli anni
'40
e
'50
e che bisogna assolutamente conoscere.
 E' importante che oggi ci si ponga il problema di cosa sia il jazz, è importante che un musicista possa andare dove vuole, ma con una coscienza precisa: è importante che si conosca la storia. Quando si conosce la storia si può andare anche lontano, ma anche in quel luogo lontano si può riconoscere qualcosa che appartiene al passato. Non sono d'accordo con quelli che affermano «io suono musica improvvisata»: c'è differenza tra colui che sceglie di suonare musica
free conoscendo la tradizione del jazz e chi si ritrova a suonare free perché tanto nel free va bene qualsiasi cosa. Questo è stato un po' il dubbio degli anni '70: infatti, quei musicisti che sono entrati nel free conoscendo la tradizione ne sono usciti vincitori e certamente arricchiti, quelli che sono arrivati al free semplicemente perché sono stati paracadutati in quel mondo, sono rimasti impelagati lì dentro. Attenzione: non si può continuare a suonare facendo la copia di
Davis o di Coltrane, perché vorrebbe dire che questa musica non va avanti, come quelli che copiano i quadri nei musei. Bisogna però porsi il problema di rivitalizzarla, innestando nella tradizione qualcosa di nuovo: non so se stiamo creando qualcosa di nuovo, qualcuno ci sta provando, ma è comunque importante farlo, altrimenti il jazz diverrebbe una musica morta, non esisterebbe. Di certo il termine jazz oggi ha poco significato, perché ci si è mossi in direzioni talmente diverse che definire il jazz attraverso un tipo di musica è molto limitante. E' importante che oggi ci si ponga il problema di cosa sia il jazz, è importante che un musicista possa andare dove vuole, ma con una coscienza precisa: è importante che si conosca la storia. Quando si conosce la storia si può andare anche lontano, ma anche in quel luogo lontano si può riconoscere qualcosa che appartiene al passato. Non sono d'accordo con quelli che affermano «io suono musica improvvisata»: c'è differenza tra colui che sceglie di suonare musica
free conoscendo la tradizione del jazz e chi si ritrova a suonare free perché tanto nel free va bene qualsiasi cosa. Questo è stato un po' il dubbio degli anni '70: infatti, quei musicisti che sono entrati nel free conoscendo la tradizione ne sono usciti vincitori e certamente arricchiti, quelli che sono arrivati al free semplicemente perché sono stati paracadutati in quel mondo, sono rimasti impelagati lì dentro. Attenzione: non si può continuare a suonare facendo la copia di
Davis o di Coltrane, perché vorrebbe dire che questa musica non va avanti, come quelli che copiano i quadri nei musei. Bisogna però porsi il problema di rivitalizzarla, innestando nella tradizione qualcosa di nuovo: non so se stiamo creando qualcosa di nuovo, qualcuno ci sta provando, ma è comunque importante farlo, altrimenti il jazz diverrebbe una musica morta, non esisterebbe. Di certo il termine jazz oggi ha poco significato, perché ci si è mossi in direzioni talmente diverse che definire il jazz attraverso un tipo di musica è molto limitante.
A.T.:
Si parlava prima dei masters e dei seminari: cosa cerchi di trasmettere ai tuoi allievi, al di là di misure, durata, impostazione, emissione e quant'altro?
P.F.:
Credo che certe cose siano un po' tutte sui libri. Quello che cerco di insegnare agli allievi è ciò che in realtà non si trova scritto: rispetto a quando ho iniziato io, oggi di fatto lì c'è tutto. Però nei libri sicuramente non trovi come rispettare il silenzio nella musica, come lavorare su una progressione, come costruire una frase musicale dal punto di vista architettonico, come impostare un discorso, come essere sul palcoscenico e sentire gli altri musicisti che suonano. Cioè nella musica ci sono degli aspetti diversi e c'è un qualcosa che fa la differenza tra il mestiere e l'arte: il mestiere significa conoscere le cose anche molto bene, l'arte significa usare queste cose dandogli una forma estetica e creare quella magia, quel senso del racconto che pochi musicisti hanno ed è ciò che fa la differenza per gli artisti che toccano il cuore più di altri. Ecco, quello che cerco di dare agli allievi è questa possibilità: va bene la teoria, l'armonia, le scale, ma è poi necessaria la capacità di metabolizzare tutte queste cose per renderle da un punto di vista che poco ha a che fare con la tecnica e con la teoria. Questo è un mio pensiero personale, ognuno, come giustamente deve essere, ha un suo modo di vedere l'arte. Il mio è quello di dare più importanza all'aspetto espressivo, alla nota singola, piuttosto che fare tante note assieme, l'aspetto tecnico mi interessa poco. Nonostante questo, naturalmente penso che la tecnica sia importante. Bisogna che ognuno abbia la possibilità di pensare e di rendere quello che pensa: nel momento in cui questo avviene, allora quella è la tecnica. Si possono pensare anche poche cose belle e rendere quelle ed è straordinario; si possono pensare molte cose e poi non riuscire a renderle! Ecco, ciò che cerco di insegnare agli allievi è dunque la filosofia di questa musica, naturalmente la mia filosofia, mutuata da Miles Davis, Chet Baker, dalle mie esperienze di tutti questi anni.
A.T.:
Tra le giovani leve di oggi, chi segui con interesse?
P.F.:
Come si diceva prima, in Italia in questo momento c'è una grande vitalità. Fabrizio Bosso nel campo della tromba è uno di questi, un musicista straordinario: credo che sia quello della nuova generazione che si sta facendo valere di più e dal quale ci aspettiamo grandi cose. Ma credo che fare nomi sia un po' ingiusto perché in effetti trovo che mai come oggi il jazz italiano abbia prodotto delle figure,
 anche giovani, così forti e preparate sotto il profilo strumentale, professionale e soprattutto creativo. Noto una grande qualità di musica che viene probabilmente dalle scuole, da un insieme di sviluppi creatisi in questi anni. Ci sono straordinari pianisti, batteristi, bassisti, sassofonisti, per cui i nomi da citare sarebbero davvero tanti. anche giovani, così forti e preparate sotto il profilo strumentale, professionale e soprattutto creativo. Noto una grande qualità di musica che viene probabilmente dalle scuole, da un insieme di sviluppi creatisi in questi anni. Ci sono straordinari pianisti, batteristi, bassisti, sassofonisti, per cui i nomi da citare sarebbero davvero tanti.
A.T.:
Chi senti più vicino a te all'epoca in cui eri emergente?
P.F.:
Ma credo che la maggior parte dei trombettisti vengano più da una scuola "freddie-hubbardiana" o "clifford-browniana" piuttosto che "davisiana". Mi sembra che la scuola di Miles sia stata in questi anni poco seguita…
A.T.:
Forse perché è stata seguita molto prima…
P.F.:
… o forse perché Davis non è uno che insegna. Tutto il discorso di Miles è fatto di piccoli aspetti, di silenzio, di suono. Per cui io mi sono molto concentrato sulla sua realtà, l'ho presa molto "di petto" e poi ho scoperto anche altri grandi trombettisti… Per esempio in Francia c'è un musicista che io ed Enrico Rava abbiamo avuto allievo a Siena, Erik Truffaz: e per quanto io non sia molto d'accordo sulle sue scelte musicali, che comunque non discuto, trovo che il suo modo di suonare la tromba sia per certi versi quello più vicino al mio. Altri musicisti che apprezzo molto sono Nils Petter Molvaer, che conosco bene, già molto affermato, svedese, molto bravo, poi Palle Mikkelborg, Jon Hassel, tutti musicisti del mondo davisiano… Non che non mi piacciano gli altri, ma cerco di trovare un paragone con il mio mondo espressivo e con quei musicisti che toccano un po' lo stesso tipo di corde.
A.T.:
Parlando del progetto di questa sera, esso nasce grazie alla trascrizione dell'esecuzione Davis-Evans del '58 ad opera di Gunther Schuller: cosa hai pensato quando nel '95-'96 questi ti ha proposto di suonare la tromba di Miles ed essere co-protagonista di una così "storica" iniziativa?
P.F.:
Da una parte ero molto onorato, dall'altra ero molto preoccupato: un ruolo importantissimo, conoscevo quell'opera benissimo, ma c'era un problema di tipo filologico, etico rispetto al rifare un'opera in cui mi veniva chiesto non di re-interpretare, ma di fare più o meno quello che
Davis aveva fatto in quelle sedute. Tant'è che poi, per una serie di vicissitudini, come abbiamo già raccontato nel disco uscito per "Il Manifesto" dopo un po' di anni, l'esecuzione è stata disastrosa. Io avevo un herpes terribile che mi aveva distrutto il labbro, non si trovavano le parti, poi si scoprì che erano scritte male… Anche il concerto di Palermo allora fu decisamente difficile. Io poi ho volutamente dimenticato quell'opera per due-tre anni, poi l'ho ripresa in Sardegna, con un'orchestra tutta sarda, che poi è quella che ha registrato con David Linx il disco proprio filologico. Il risultato è stato decisamente interessante, proprio perché quei due anni di tempo erano serviti per prendere distanza da quell'opera e vederla da un altro punto di vista… Tant'è che ho deciso di andare in studio, di registrare e farne una versione coraggiosa…
A.T.:
Quindi la versione del '99 recupera il discorso filologico?
P.F.:
Assolutamente sì. In quella che abbiamo registrato in studio nel '99, uscita poi con "Il Manifesto", suono all'ottanta per cento le stesse note che suona Miles Davis. Ma il punto non era tanto suonare le stesse note, ma suonare con la stessa intenzione, perché quella musica lì funzionava perché dietro c'era un musicista che aveva un determinato tipo di peso sonoro, di rapporto con il tempo, per cui non era affatto facile. Poi l'Orchestra di Sassari ha lavorato molto su questo progetto, per cui il risultato è stato decisamente buono. Da allora abbiamo iniziato ad eseguirla, pur sapendo che non è mai facile, perché sono tredici movimenti di fila, non c'è mai un attimo di riposo per la tromba, perché è il solista, quando la registrò Miles in studio già la seduta di registrazione fu molto complessa,
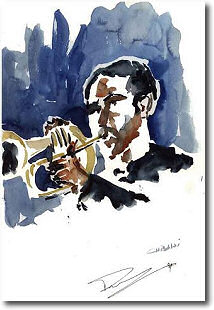 ma fu fatta pezzo per pezzo, quindi l'idea di poterla eseguire tutta interamente è difficile perché bisogna far sì che il labbro non si stanchi mai, altrimenti perdi quella leggerezza di suono che è fondamentale, tutto è talmente misurato che la parte del solista deve essere di una misura incredibile per poter avere quel tipo di effetto. Dopo l'allontanamento dalla partitura davisiana per rivederla da un altro punto di vista c'è poi stato questo avvicinamento che mi ha portato quasi a voler indagare ancora in modo più approfondito in quest'opera, tant'è che il mio ultimo disco, che si chiama
Kind of Porgy & Bess, in realtà è la naturale prosecuzione di questo progetto qui. Quindi un'opera filologica prima e un'opera invece metabolizzata, e rivista da un punto di vista completamente diverso, molto più mediterraneo, molo più aperto, molto più libero, con un musicista tunisino, con Antonello Salis, un chitarrista vietnamita, in cui si suona una Porgy & Bess che è mutuata da questa opera filologica di Miles Davis e Gil Evans ma che mi ha dato la possibilità di indagare anche nell'opera originale di Gershwin, cercando di trovare anche degli altri temi che non erano stati ancora utilizzati nel repertorio jazzistico, e anche in quell'altra straordinaria opera di Louis Armstrong ed Ella Fitzgerald che forse oggi è un po' dimenticata e che io ho riscoperto con gran piacere, con degli arrangiamenti di archi straordinari… Per cui questa gestazione complessa di Porgy & Bess con Gunther Schuller mi ha offerto l'opportunità di avvicinarmi a quest'opera bellissima da un punto di vista completamente nuovo… Quasi una sfida, il voler trovare qualcosa di nuovo. Poi la sfida è tutti i giorni, anche stasera, quella del giostrare tutto in questa musica bellissima, semplice e difficilissima allo stesso tempo. Per cui per me è una sorta di tributo, una sorta di dazio da pagare alla storia del jazz perché trovo che Porgy & Bess sia una delle più belle pagine che siano state scritte e registrate, non solo nella discografia di Davis, che è tutta piena di perle preziosissime, ma proprio nella discografia del jazz, trovo che Porgy & Bess sia, nella sua imperfezione esecutiva, uno dei dischi più belli che siano stati registrati. ma fu fatta pezzo per pezzo, quindi l'idea di poterla eseguire tutta interamente è difficile perché bisogna far sì che il labbro non si stanchi mai, altrimenti perdi quella leggerezza di suono che è fondamentale, tutto è talmente misurato che la parte del solista deve essere di una misura incredibile per poter avere quel tipo di effetto. Dopo l'allontanamento dalla partitura davisiana per rivederla da un altro punto di vista c'è poi stato questo avvicinamento che mi ha portato quasi a voler indagare ancora in modo più approfondito in quest'opera, tant'è che il mio ultimo disco, che si chiama
Kind of Porgy & Bess, in realtà è la naturale prosecuzione di questo progetto qui. Quindi un'opera filologica prima e un'opera invece metabolizzata, e rivista da un punto di vista completamente diverso, molto più mediterraneo, molo più aperto, molto più libero, con un musicista tunisino, con Antonello Salis, un chitarrista vietnamita, in cui si suona una Porgy & Bess che è mutuata da questa opera filologica di Miles Davis e Gil Evans ma che mi ha dato la possibilità di indagare anche nell'opera originale di Gershwin, cercando di trovare anche degli altri temi che non erano stati ancora utilizzati nel repertorio jazzistico, e anche in quell'altra straordinaria opera di Louis Armstrong ed Ella Fitzgerald che forse oggi è un po' dimenticata e che io ho riscoperto con gran piacere, con degli arrangiamenti di archi straordinari… Per cui questa gestazione complessa di Porgy & Bess con Gunther Schuller mi ha offerto l'opportunità di avvicinarmi a quest'opera bellissima da un punto di vista completamente nuovo… Quasi una sfida, il voler trovare qualcosa di nuovo. Poi la sfida è tutti i giorni, anche stasera, quella del giostrare tutto in questa musica bellissima, semplice e difficilissima allo stesso tempo. Per cui per me è una sorta di tributo, una sorta di dazio da pagare alla storia del jazz perché trovo che Porgy & Bess sia una delle più belle pagine che siano state scritte e registrate, non solo nella discografia di Davis, che è tutta piena di perle preziosissime, ma proprio nella discografia del jazz, trovo che Porgy & Bess sia, nella sua imperfezione esecutiva, uno dei dischi più belli che siano stati registrati.
A.T.:
Appunto musicista a 360 gradi, scrivi anche per il teatro, il cinema, etc.,: un modo di essere, un modo di esprimerti, un ulteriore canale di lavoro, una valvola di sfogo, un modo di divulgare il jazz attraverso mezzi supplementari?
P.F.:
E' un po' tutto. L'unica cosa che posso dire è che non ho mai vissuto la musica vedendola come un fatto di lavoro, perché ho avuto la fortuna di vivere bene con questa musica, suonando il jazz, facendo la musica che mi è sempre piaciuta. Anche in quei casi di progetti particolari che ho fatto perché ho ritenuto proprio i progetti interessanti, come quando ho prodotto il disco
Argilla
con
Ornella Vanoni, o le collaborazioni con Alice, o altre cose con
Vinicio Capossela… Mi son sempre lasciato guidare dall'istinto, senza mai valutare sotto il profilo del mestiere, e mi ritengo molto fortunato, da questo punto di vista. Per il resto non mi sono mai andato a cercare nulla, ho incontrato tutto molto casualmente, anche i musicisti. E quindi ogni volta che mi sono imbattuto in qualcosa di nuovo, un linguaggio nuovo, una forma nuova, la proposta di scrivere per un film, ho sempre accettato questi impegni quando sentivo che bisognava farli… Così trovo che scrivere per il cinema sia straordinario e che sia una evoluzione di un discorso legato all'arte, non vedo mai le dimensioni separate: le colonne sonore che ho scritto, quella per il film su
Ilaria Alpi [Il più crudele dei giorni, regia di Ferdinando Vicentini Orgnani, n.d.r.], o quest'ultima che è andata a Cannes, di una regista palermitana,
Costanza Quatriglio [per il film "L'Isola", n.d.r.] sono tutte colonne sonore in cui il rapporto con il jazz è molto marcato. Non mi ritengo un compositore di musiche da film, quando mi dicono di scrivere per film, do un'impronta perché la mia musica è quella, porto dei musicisti che non sono dei mestieranti, sono degli artisti, e scrivo pensando a quei musicisti in particolare, quindi il risultato è sempre qualcosa di estremamente personale. Per cui questi mondi, tutti diversi fra di loro, in realtà hanno tutti un denominatore comune: denominatore comune è l'improvvisazione, denominatore comune è il jazz, denominatore comune è mettere insieme una famiglia di musicisti che si conosce molto bene e che assicurano un risultato che va molto al di là di quello quanto è scritto. Ho la fortuna di avere dei collaboratori preziosi, con i quali c'è un rapporto di stima e di comunione tale per cui nello momenti in cui chiedo qualcosa sono capaci di dare molto di più di quello che ho chiesto.
A.T.:
A proposito di dischi: qualcosa in arrivo?
P.F.:
Nuovi progetti discografici, che non voglio precisare per scaramanzia. Spero di poter registrare finalmente in trio con Furio Di Castri e Antonello Salis, con cui lavoro ormai da più di dieci anni e poche volte abbiamo registrato in studio, perché è difficile riportare l'atmosfera che si crea tra noi. Ho due grossi progetti per la testa che vorrei registrare: uno si chiama
Etnografie, un progetto commissionato dall'Istituto Etnografico Regionale della Sardegna, una partitura che muove dalla musica della Sardegna interpretata da musicisti di tutte le parti del mondo; ed un altro progetto sulla musica antica, che mi è sempre piaciuta, vedi
Metamorfosi, dove ho registrato un madrigale di Monteverdi: c'è questa empatia con le musiche del '600 che trovo abbiano molte affinità con il mondo del jazz.
| 05/09/2010 | Roccella Jazz Festival 30a Edizione: "Trent'anni e non sentirli. Rumori Mediterranei oggi è patrimonio di una intera comunit? che aspetta i giorni del festival con tale entusiasmo e partecipazione, da far pensare a pochi altri riscontri". La soave e leggera Nicole Mitchell con il suo Indigo Trio, l'anteprima del film di Maresco su Tony Scott, la brillantezza del duo Pieranunzi & Baron, il flamenco di Diego Amador, il travolgente Roy Hargrove, il circo di Mirko Guerini, la classe di Steve Khun con Ravi Coltrane, il grande incontro di Salvatore Bonafede con Eddie Gomez e Billy Hart, l'avvincente Quartetto Trionfale di Fresu e Trovesi...il tutto sotto l'attenta, non convenzionale ma vincente direzione artistica di Paolo Damiani (Gianluca Diana, Vittorio Pio) |
| 01/10/2007 | Intervista a Paolo Fresu: "Credo che Miles sia stato un grandissimo esempio, ad di là del fatto che piaccia o non piaccia a tutti, per cui per me questo pensiero, questa sorta di insegnamento è stato illuminante, quindi molte delle cose che metto in pratica tutti i giorni magari non me ne rendo conto ma se ci penso bene so che vengono da quel tipo di scuola. Ancora oggi se ascolto "Kind Of Blue" continuo a ritrovare in esso una attualità sconvolgente in quanto a pesi, misure, silenzi, capacità improvvisativi, sviluppo dei solisti, interplay, è un disco di allora che però oggi continua ad essere una delle cose più belle che si siano mai sentite, un'opera fondamentale." (Giuseppe Mavilla) |
|
Invia un commento
©
2000 - 2003 Jazzitalia.net - Antonio Terzo - Tutti i diritti riservati
|
© 2000 - 2026 Tutto il materiale pubblicato su Jazzitalia è di esclusiva proprietà dell'autore ed è coperto da Copyright internazionale, pertanto non è consentito alcun utilizzo che non sia preventivamente concordato con chi ne detiene i diritti.
|
| COMMENTI | Inserito il 17/1/2011 alle 17.04.33 da "sarafresu"
Commento:
Bravissimo Paolo, ci vorrebberò più talenti come Fresu
Sara | | |
Questa pagina è stata visitata 35.628 volte
Data pubblicazione: 24/11/2003

|
|

