|
Intervista con Aldo Bagnoni
maggio 2020
a cura di Marco Losavio
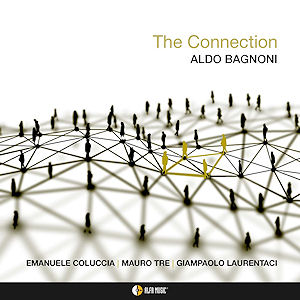
Alfa Music
1. Clarabella 5.20
2. Cappello eolico 7.12
3. This is my place 6.24
4. Eternal returns 7.15
5. The dolmen and the sea 11.34
6. Heart on a mountain 9.53
7. Oral culture 6.55
8. Lipompo's just arrived 6.01
9. What was I looking for 5.52
10. Clarabella (Epilogo) 1.23
Aldo Bagnoni - drums,
reciting voice on 10
Emanuele Coluccia - tenor and soprano sax,piano on 10
Mauro Tre - piano, Fender Rhodes, synth
Giampaolo Laurentaci - double bass
Produced by Aldo Bagnoni for AlfaMusic Label&Publishing
Production coordination Fabrizio Salvatore
Photos Pia Sciandivasci
Graphic project Nerina Fernandez

Emanuele Coluccia, Aldo Bagnoni, Mauro tre, Giampaolo Laurentaci
(foto di Pia Sciandivasci)
In occasione della pubblicazione del nuovo album "The Connection"
con proprie composizioni, abbiamo incontrato il batterista pugliese Aldo Bagnoni
che ci racconta come una mentalità sempre pronta all'accoglienza delle arti e delle
culture, senza steccati, riesca a fornire poi l'energia giusta per un proprio naturale
ambito sonoro.
Cosa ha generato l'idea di questo nuovo album?
Dopo oltre quarant'anni di attività musicale in pressoché tutte le forme, dalla
concertistica jazz alla performance multimediale, dal dixieland all'improvvisazione
totale, dal solo all'orchestra, avevo da tempo l'esigenza di iniziare a fissare
la mia idea personale di musica. Questo disco è la testimonianza di un mio lavoro
compositivo che dura da quasi vent'anni, e che è nato in un momento in cui - per
motivi non tutti dipendenti dalla mia volontà – non ho potuto più suonare dal vivo
(che è sempre stata e resterà la mia dimensione preferita, come per gran parte dei
jazzisti), ma dovevo comunque continuare ad esprimermi in termini artistici, a prescindere
da tutto e da tutti. Sono riuscito a trasformare, classicamente, quello che per
me era un momento di crisi e di difficoltà, determinato da incomprensioni più che
artistiche presumo umane con una certa parte dell'ambiente musicale di cui avevo
sino a quel momento fatto parte, in un'appassionante opportunità per la mia vita.
Insomma, direi che quasi quasi c'è da ringraziare coloro che hanno voluto ostacolarmi…!
Amo comporre: ho scritto decine di brani, tra composizioni originali e arrangiamenti
di materiale altrui, e sono curioso di vedere quanto di questo materiale riuscirò
ad utilizzare nei miei futuri lavori. Non ho alle spalle studi canonici in questo
senso, nella mia produzione c'è molto istinto, nonostante tenda ad articolare parecchio
e ad utilizzare strutture anche non usuali (chorus con armonie e durate anomale,
magari differenti per ciascun solista, politematicità etc.). Probabilmente è questo
il motivo che mi ha portato a sviluppare una via che non è davvero assimilabile
alla produzione soprattutto jazzistica né passata né odierna, ma le attraversa trasversalmente,
alla ricerca di un pensiero e di un'espressione che siano sincere ed oneste intellettualmente,
non volendo – e del resto non sapendo davvero – copiare formule precotte. Se il
risultato alla fine sia convincente e "piacevole" (qualunque cosa significhi questo
termine), non sta certo a me dirlo.
L'ensemble viaggia su sonorità spesso "aperte" nelle quali
il quartetto di base si ritrova sempre con agilità e coesione. Vuoi dirci qualcosa
della scelta dei musicisti?
Il percorso finale è iniziato tra il 2017 e
il 2018, anche se in passato avevo già suonato
e registrato qualche mia composizione, senza però pubblicarne i risultati, che non
erano esattamente rispondenti alle mie esigenze di sonorità e narrazione poetica,
per così dire. Ho meditato a lungo e ricercato con molta attenzione i musicisti
che dovessero far parte di questo progetto, per le loro caratteristiche sia artistiche
che umane. Un aspetto, quest'ultimo per me mai stato secondario: se non condivido
eticamente una serie di valori ad ampio spettro con le persone con cui suono, mi
sento a disagio. Ho potuto suonare parte della mia musica con ottimi musicisti come,
tra gli altri,
Gaetano Partipilo, Michel Godard,
Furio Di Castri
etc. Poi ho iniziato a mettere meglio a fuoco il lavoro, e per un certo periodo
ho sperimentato alcune soluzioni con cari amici – che ringrazio ancora - come
Francesco Defelice, vibrafonista e percussionista, Giuseppe D'abramo,
contrabbassista, ed Emanuele Coluccia, sassofonista (ma anche polistrumentista,
arrangiatore, compositore egli stesso). Alla fine confermando la presenza di
Emanuele Coluccia, ho aggiunto Mauro Tre, pianista e tastierista, e
Giampaolo Laurentaci, contrabbassista. Musicisti preparatissimi, tutti e
tre di origine salentina, ciascuno con un proprio background variegato, non monodimensionale
– cosa che rifuggo, non amo i puristi e i fanatici di un singolo genere – e in grado
di esprimere come interpreti e solisti un livello artistico davvero notevole. Insomma,
adatti a comprendere e interpretare una musica poco convenzionale come la mia, che
non fa riferimento a stili o mode con tecniche di marketing, cosa che si è regolarmente
verificata, dopo un breve periodo di chiarimento ed assestamento – necessario, data
la mole di materiale da suonare e la modalità da esso richieste -, come del resto
avevo previsto scegliendo questi collaboratori. Ah, infine ci sono anch'io, che
mi sono assunto come batterista con la consegna tassativa di pensare soprattutto
al risultato complessivo, piuttosto che a mettere in luce il mio strumento. Questo
è l'album più di un musicista che ha a cuore il risultato finale, che del batterista
più veloce del West. Quello, magari la prossima volta…
Da quanto tempo lavorate insieme
e come avete raggiunto questo affiatamento?
Il lavoro preliminare alla registrazione del disco è durato poco più di tre mesi,
all'inizio del 2019. Grazie ad un'opera di messa
a punto delle mie composizioni, in cui la collaborazione di Emanuele è stata assolutamente
preziosa, e di affinamento del sound complessivo, dati i presupposti linguistici
e artistici comuni a tutti e quattro di cui accennavo prima, abbiamo potuto raggiungere
un'intesa ed un'unità di intenti che è testimoniata dal lavoro che si può ascoltare
sul disco pubblicato da Alfa Music, etichetta che ringrazio davvero per aver
puntato su questa mia idea. Tra l'altro, prima dell'incisione, credo sia il caso
di precisare che non abbiamo avuto modo di esibirci live. Successivamente, abbiamo
sinora tenuto solo un concerto al festival di Roccella Jonica. Spero che potrò portare
finalmente in giro questo gruppo e questo repertorio, con l'aggiunta di altro mio
materiale inedito, non appena le circostanze ben note consentiranno nuovamente le
esibizioni dal vivo.
Dal punto di vista di chi ascolta la connessione si avverte
in aspetti culturali, stilistici, esecutivi, qual è esattamente la "Connection"
a cui l'album si riferisce?
Come scrivo nelle note di copertina, la "connessione" da ricercare è un termine
molteplice, di cui oggi più che mai avverto al tempo stesso una necessità personale
forte quanto la contraddizione che è sottesa ad essa. Intendo dire che per essere
realmente connessi, gli uni agli altri - perché gli uomini hanno questa esigenza
insopprimibile in essi -, ognuno deve andare a fondo di sé stesso, quindi essere
connesso con la propria reale indole, non assumere modelli esterni posticci ma ricercare
appunto la propria interiorità, quale che sia. E per fare tutto questo, e quindi
trasmettere la propria realtà, connettersi con gli altri, dovrà saper "connettere",
ragionare su di sé e sugli altri con onestà, consapevolezza, coraggio. Insomma,
non si tratta di un gioco di parole (nonostante io li ami alla follia): o almeno,
non soltanto. E la connessione, traslandola su di un piano musicale, è il presupposto
che porta delle persone a comunicare tra loro anche in termini esecutivi, e di intenzione
espressiva. Non si può suonare meccanicamente, eseguendo ciascuno un suo compitino
lungamente messo a punto nella propria cameretta, ma avere unità di intenti: parlare
tra noi comunicando cose vere, non frasi fatte e di circostanza. Improvvisare, soprattutto,
come momento di emersione della propria verità dal profondo, come interrogazione
dell'inconscio, di cui infine si ottiene piena cognizione, e la si trasmette agli
altri. E farei anche un piccolo, rispettoso riferimento all'attualità, in cui abbiamo
visto la nostra (presunta) libertà messa in discussione da circostanze tragiche:
questa riflessione profonda dovrebbe servire a tutti, spero, per riconsiderare come
noi singoli possiamo e dobbiamo essere connessi correttamente, in una rinata idea
di vicinanza e convivenza, con il nostro prossimo. Senza più deliri di onnipotenza,
che hanno caratterizzato la nostra storia sociale e tecnologica degli ultimi decenni,
ma con consapevolezza e capacità di convivere. Come avviene del resto nel jazz,
dove l'individualità si connette e convive creativamente e positivamente nel collettivo.
Ecco la mia idea, forse un po' utopica, di "connessione".
Ogni brano ha una dedica, ce ne è una in particolare per
cui vorresti riservare qualche parola?
Qui la risposta mi sembra al tempo stesso facile ed obbligata. La dedica fondante
è quella complessiva, quella che riguarda il titolo del mio disco e del mio progetto,
The Connection, e che ti riporto testualmente: "per tutti coloro che, in questo
mondo logorato dalla paura e dall'odio dell'Altro, non lavorano a dividere, ma appunto
a connettere". Credo che dovrebbe bastare questo.
Un percorso professionale lungo e pieno di esperienze.
Vuoi indicarci la "connection" che vedi con l'Aldo Bagnoni di oggi voltandoti indietro?
Sì, oltre quarant'anni, inevitabilmente di alti e bassi, di slanci e dubbi, di illusioni
e disillusioni, di risultati concreti e di progetti ancora sognati, non sono pochi,
ma mi sembrano passati in un attimo, ma non ho neppure troppa voglia di voltarmi
indietro. "Come eravamo" è una frase che non mi sentirai mai pronunciare: ero come
sono, magari oggi con qualche pelo bianco in più e qualche chilo in meno. Come dice
Ornette
Coleman, "tomorrow is the question!". Guardo avanti come sempre,
sono molto impegnato a progettare, penso al futuro con speranza e curiosità, ma
oggi anche con un minimo di distacco, necessario per la sanità mentale, credo di
chiunque. Ecco, diciamo che conservo questa attitudine dai miei primi tempi, quando
magari non avevo ancora piena consapevolezza di cosa fosse realmente questo mondo,
quello musicale, ma alla fine il mondo tout court. È pur vero che sono un batterista,
categoria sempre pericolosa nella musica, ma in fondo "sono rimasto il bravo
ragazzo di sempre" …
Ad oggi quindi ti definisci più leader?
Direi di sì, ma soprattutto sotto un profilo tecnico, gestionale. Dopo una lunga
militanza collaborando con tantissimi colleghi, ho iniziato a dirigere miei progetti
dalla metà degli anni '90, ma prima ancora avevo
già la tendenza ad intervenire attivamente nelle decisioni dei progetti altrui,
specie se impostati più collettivamente, cercando di contribuire con suggerimenti,
idee sugli arrangiamenti, o sulla scelta del repertorio, e così via. Diciamo che
il processo compositivo mi ha finalmente permesso di esprimere pienamente questa
mia vocazione.
Qual è la tua attuale visione del jazz in Italia o, per
meglio dire, del "sistema jazzistico" in Italia?
Che posso dirti… Il jazz, in Italia, ma probabilmente non solo nel nostro Paese,
si è molto trasformato negli ultimi vent'anni, e non del tutto in meglio. Vedo,
senz'altro più di un tempo, molta professionalità, nel bene e nel male: sono cresciute
al fianco dei musicisti, in maniera numericamente significativa, anche altre figure
professionali, che spesso sembrano ancora più fondamentali degli artisti stessi
nel creare occasioni per fare musica. Ma a fronte di questa sorta di crescita non
mi pare che sia sempre corrisposta un'integrità artistica adeguata. E poi avverto
un certo raffreddamento, un inaridimento nei rapporti interpersonali tra musicisti,
gestori, manager, giornalisti. C'è quella famosa canzoncina degli Aristogatti, la
ricorderai, quella che "tutti quanti voglion fare il Jazz". Aspirazione legittima,
ma dico sempre che il jazz è una coperta troppo corta, per bastare a tutti, specie
se il concetto di jazz che pare aver preso piede è quello di musica museale – Adorno
sottolineava l'etimo comune di "museo" e "mausOleo", e credo non sbagliasse -, di
repertorio da riprodurre, senza invece avere maggiormente presente il concetto di
ricerca, che è fondante in questa nostra musica, e alla fine in tutta l'arte che
si rispetti. Non tutti, anche se lo studiano e conseguono ottimi risultati tecnici
e professionali, possono realizzare un risultato che sia jazz nella sua essenza
più intima e reale. Potrà magari averne la forma esteriore, potrà rispettarne dei
canoni, suonare "come se", ma sarà sempre un'operazione tendenzialmente commerciale,
senza una reale urgenza espressiva. E poi, in molti festival e rassegne, spesso
il jazz è un termine-pretesto, per presentare prodotti ibridi, che delle caratteristiche
principali del jazz hanno perso quasi tutto per strada, se non addirittura per presentare
un dj set o Santana in concerto, però usufruendo di spazi e risorse che non
dovrebbero essere sottratti a chi invece si esprime a cuore aperto, senza strategie,
con ostinata intenzione di inventare e non riprodurre.
Hai avuto anche una lunga e proficua atività nell'organizzazione
di manifestazioni che ancora si ricordano. Questo tuo impegno ha in qualche modo
influito su te stessso some artista?
Organizzare manifestazioni per quanto mi riguarda ha sempre voluto dire estendere
la mia attività in proprio come musicista. Intendo dire che il lavoro di operatore
culturale serve quanto quello dell'artista per diffondere determinate idee musicali,
quindi artistiche, culturali, e infine etiche. Ho messo a fuoco questa convinzione,
questa funzione anche divulgativa - e sociale - sulla base anche di una mia ricerca
artistica, dapprima durante una collaborazione con altri colleghi, nata in seno
all'AMJ, l'Associazione dei Musicisti Jazz italiani attiva a cavallo tra gli scorsi
anni Ottanta e Novanta: a metà anni Novanta demmo vita in Puglia all'esperienza
dell'associazione culturale MIA (Musicisti Italiani Associati) ed al festival "Jazz
& altro/Oltre il Jazz", in cui creammo sinergie interne tra gli oltre venti
musicisti pugliesi, noti e meno noti, che facevano parte della MIA e io fui anche
uno dei fondatori di una formazione piuttosto particolare, che credo qualcuno ricordi
ancora, la Dolmen Orchestra, diretta da Nicola Pisani, con cui dal
1996 al 2001
creammo diverse produzioni con ospiti prestigiosi del jazz italiano e internazionale,
tra cui Paolo
Damiani, Cristina Zavalloni, Achille Succi, Nguyên
Lê, Tim Berne, Louis Sclavis,
Gianluigi
Trovesi, Michel Godard, John Surman, Yves Robert,
e altri ancora. Da qualcuna di queste esperienze ricavammo due dischi, uno live
e l'altro in studio, pubblicati dalla londinese Leo Records. Nell'ambito
del nostro festival presentammo anche molti altri artisti italiani (ovviamente parecchi
pugliesi, perché credevamo nel "fare squadra") e internazionali, tra cui voglio
ricordare fuoriclasse come Joe Zawinul, Yellowjackets, Michel Portal,
Daniel Humair. Io ebbi modo di collaborare per alcuni miei progetti, incluso
anche due di "jazz & poetry", con Michel Godard, Nguyên Lê,
Stefano Battaglia, François Corneloup, Claude Tchamitchian...
Dopo un lungo periodo di pausa, fondai l'associazione Phonetica (nel cui nome si
può facilmente identificare una fusione di "phonè", intesa nel senso lato di suono,
ma anche di voce dell'espressione artistica, ed "etica"), e dal
2008 al 2011
mi risolsi ad organizzare in prima persona il "Phonetica Jazz Festival" in
Basilicata, a Maratea, da cui sono passate figure come
Antonello
Salis,
Maria Pia De
Vito,
Furio Di Castri, Dario Deidda, Daniele D'Agaro,
Stefano De Bonis, Boris Savoldelli,
Aldo Vigorito,
e ancora amici come Godard, Zavalloni, Succi e tanti altri,
presentando anche mie produzioni. Sono state per me, e spero non solo per me, esperienze
artistiche e umane molto importanti. Non mi dispiacerebbe riprendere anche questa
attività, ma dovrebbero esserci presupposti ben diversi dal passato, sia economici
(sono attività che mi sono costate molto, non solo in termini di dispendio di energie,
ma anche di risorse personali) ma anche nel senso di collaborazioni con altre persone
che abbiano orizzonti vasti e non siano preda di mitologie, fanatismi, purismi,
settarismi, come rilevo invece in una certa parte dell'ambiente jazzistico odierno.
E non solo in Italia, ovviamente.
"Jazz & Poetry", La poesia,i testi,
hanno quindi un ruolo importante nel tuo spettro culturale. Vuoi parlarcene?
Riguardo questo rapporto tra la jazz e parola scritta, posso dire che la poesia
è una forma musicale di scrittura: se partiamo da questa considerazione, il ponte
tra parola e nota è evidente. Non a caso, il titolo di un mio lavoro del
2016 sulla poesia di Pasolini era "Rosa
in forma di musica", alludendo appunto a quella sua magnifica raccolta "Poesia
in forma di rosa". Attualmente sto rimettendo in piedi in una edizione completamente
rivista uno spettacolo già presentato in passato, "Love is a dangerous necessity"
(titolo mutuato da Mingus), basato su miei testi poetici che portano tutti i titoli
di celebri brani del jazz, standard di Berlin, Romberg, Porter
quanto composizioni di autori come Coltrane, Grolnick,
Ornette
Coleman, Rava, lo stesso Mingus, e altri ancora, con la
presenza e la regia di un ottimo attore che ama fortemente il Jazz. Ma siamo solo
agli inizi, questa crisi mondiale ha bloccato anche questo lavoro, e per il momento
è prematuro anticipare altro. Mi ha sempre appassionato questo incontro, svolto
sul terreno comune del ritmo e della sonorità, in prima battuta più istintivo che
intellettuale, e l'ho perseguito con diversi assetti: testi altrui, testi miei,
musica altrui, musica mia, musica improvvisata singolarmente o collettivamente sulla
falsariga emozionale o logica del testo dato, avvalendomi di voci recitanti di attori
o (indegnamente) della mia stessa… Ho rivisitato testi di Boris Vian tratti
da "Non vorrei crepare", tra musica improvvisata e loop elettronici, in "Comotive
ou zoizillon", uno spettacolo nato all'interno del Teatro Kismet di Bari, cui
hanno preso parte in varie edizioni, tra gli altri, uno dei miei musicisti preferiti,
Michel Godard, e il cantante Nabil Ben Salameh, che oggi tutti conoscete
come frontman dei Radioderwish. Ho anche provato a recitare diversi miei
testi in "Comment…?", secondo un concetto più strettamente sonoro, spesso ritmico,
in contemporanea all'esecuzione batteristica, spettacolo replicato più volte in
formazioni variabili, tra cui ricordo la buonanima di
Gianni Lenoci
al piano, tastiere e flautini vari, oppure un sassofonista leccese (che suonava
per l'occasione anche un armonium), Roberto Gagliardi, un ottimo improvvisatore
che meriterebbe davvero più attenzione e riconoscimento. Insomma, le variabili sono
diverse, ma sono tutte appassionanti. Non ho però mai avuto il coraggio (tranne
una sola faticosissima volta) di dar vita ad una sorta di free style poetico, in
un bis proprio al fianco di Lenoci: improvvisare il testo con o piuttosto della
musica. Ma non escludo di ripensarci, prima o poi: suonare o parlare, sempre di
improvvisazione si tratta. Poi ho anche scritto tre atti unici teatrali, una sorta
di "trilogia demoniaca", da coniugarsi con musica improvvisata "a tema", secondo
un canovaccio che non prevede scrittura musicale, ma indicazione di concetti atmosferici
a guida dell'esecuzione: in uno di essi, "Esorcismo ermetico", presentato
a Matera nel 2013, in occasione della sua candidatura
a Capitale della Cultura Europea, mi ha affiancato Giorgio Distante alla
tromba e live electronics. In questa piéce mi sono occupato di una critica dell'approccio
alla Cultura come semplice moda, coinvolgendo da copione alla fine dello spettacolo
anche il pubblico in un momento catartico collettivo, in cui insieme all'officiante,
un bravo attore lucano di cabaret, Dino Paradiso, veniva recitato l'esorcismo che
avrebbe dovuto salvarci dal pressapochismo e dalla superficialità. Non so se il
rito abbia avuto efficacia: ma almeno ci ho provato…
Alla luce di questo terribile lockdown cosa pensi sia da
fare adesso nel mondo dell'arte/cultura e tra i musicisti in particolare?
Come già dicevo prima, tutto deve ripartire da una corretta, più "umana" – in senso
positivo – idea di convivenza, di progressivo riavvicinamento, come avevamo perso
nell'epoca pre-Covid 19. Non possiamo non riflettere, e replicare le cose come erano
prima, ma non so se tanti abbiano tematizzato questi aspetti, e ne abbiano preso
piena consapevolezza. Se qualcosa di positivo possiamo identificare in questa tragedia
- che è ancora lungi dall'essere conclusa, e che invece purtroppo, potrebbe sempre
riaccendersi -, è proprio un ritrovare un senso, una solidarietà che sia feconda
e creativa, una reale connessione, concedimi l'autocitazione. Ritrovare, e ritrovarci.
Le soluzioni tecnologiche sono neutre, al netto dei loro limiti appunto tecnici:
ad esempio, questo fiorire di esibizioni sul web, di esecuzioni create in vitro,
un musicista ad aggiungere un tassello esecutivo dopo l'altro in questi video compositi,
va bene per alcune musiche, e non per altre. La musica classica, il rock, il pop,
la stessa etnica, possono anche prestarsi a questa modalità, è possibile assemblare
le varie parti, che sono prevalentemente scritte, già date, previste, senza che
il risultato finale ne soffra realmente. Il jazz, invece, no: nella sua irriducibile
essenza di invenzione estemporanea, collettiva, in cui il momentum governa le sue
sorti finali, e non mi riferisco solo all'improvvisazione, ma all'agogica complessiva,
al dialogo sottile e continuo tra i suoi componenti, nel mentre dell'esposizione
persino dei temi, delle parti scritte, il jazz non si piega a queste modalità creative,
ha necessità di vicinanza, di interazione, di intuizione condivisa, priva di schematicità.
Neppure una musica come la mia, dove sino ad oggi la scrittura svolge un ruolo fondante,
potrebbe prescindere da tutto questo. Non so negli altri settori, e del resto, dipende
molto anche dalle modalità di svolgimento: la pittura, la scultura, la letteratura,
la poesia, persino per certi versi la danza possono resistere sino ad un certo punto
all'isolamento, che per qualcuno potrebbe essere persino splendido, e creativo.
Noi jazzisti, animali tuttora selvaggi pur nel nostro raziocinio, abbiamo bisogno
di altro: di carne e sangue, di respiro collettivo, non possiamo mascherarci, dobbiamo
mostrarci a viso aperto. Il web serve a trasmettere, a comunicare in digitale, ma
ciò che c'è prima, analogico e bellissimo, necessita di una connection diretta,
artigianale, che nessun assemblaggio industriale potrà mai sostituire, neppure quando
avremo superato problemi banali come la latenza sulla rete. Abbiamo necessità di
guardarci negli occhi, noi musicisti legati all'ora che volge, e testimoniarci cosa
e come vogliamo essere in quel momento, che passerà irripetibile, e che non potrai
mai permetterti di perdere per sempre.

Inserisci un commento
|
© 2000 - 2026 Tutto il materiale pubblicato su Jazzitalia è di esclusiva proprietà dell'autore ed è coperto da Copyright internazionale, pertanto non è consentito alcun utilizzo che non sia preventivamente concordato con chi ne detiene i diritti.
|
Questa pagina è stata visitata 5.544 volte
Data pubblicazione: 06/06/2020

|
|

