 INDICE
LEZIONI INDICE
LEZIONI
|
Lezione 4: Prima della Performance: Monk, Pepper e Baker
di Paolo Ricciardi
|
|
Abbiamo parlato nel paragrafo precedente
di tre diversi tentativi di documentare una performance jazzistica: un cortometraggio,
una trasmissione televisiva e un lungometraggio documentario. Tre prototipi che
affrontano il jazz in maniera differente rispetto al passato e che negli anni successivi
saranno presi ad esempio da altri registi. Abbiamo visto i modi attraverso i quali
Mili, Smight e Stern si siano avvicinati al jazz: con una
jam session ricostruita il primo, in modo da cogliere meglio le relazioni
tra i musicisti; cercando di seguire la struttura dei brani riproponendola attraverso
le inquadrature il secondo, in un ambiente senza scenografia ed esplicitando al
massimo la presenza della macchina produttiva [1];
abbandonando la performance o avvicinandosene quasi fino all'astrattismo
il terzo e privilegiando l'ascolto più che la visione del concerto. Tre diverse
maniere quindi di rendere vive quelle tracce di jazz in fuga dagli strumenti, di
farle apparire concrete, "visibili". Come abbiamo già detto però, documentare l'evento
jazzistico in sé non ha molto senso se non accompagnato da un valore aggiunto da
ricercare nella componente cinematografica: in Jammin'
the Blues la minuziosa costruzione dell'inquadratura e l'uso del bianco
e nero; in Jazz on a summer's day il lavoro
sul colore e sul montaggio; in The Sound of Jazz
la particolare messa in scena.
Qualsiasi registrazione di una performance jazzistica ha un alto
valore documentario, se non altro per la caratteristica di evento unico che appartiene
a questa musica, però, non è l'unico modo di documentare il jazz. Abbiamo già detto
quanto sia forte il legame tra l'assolo del musicista, la musica da lui creata ed
il suo stato d'animo, le sue emozioni, quanto il jazz sia spontaneità ed espressione
diretta dei sentimenti di chi lo suona. Di conseguenza l'arte del jazzman è inscindibile
dalla sua vita. Allora, perché non documentare quello che c'è "dietro" il palco,
prima della performance e quindi affrontare il mondo del jazz "entrando
dal retro", lasciandoci guidare dai suoi protagonisti, attraverso le loro storie,
le loro vite e provare a cogliere lì le motivazioni e le radici della loro musica,
della loro espressione, per capirla e comprenderla, se possibile, più a fondo?
Inoltre penso che questo modo di documentare il jazz permetta al dispositivo
cinematografico di superare il problema della performance (momento in cui
ha più difficoltà nel restituire la realtà che ha di fronte) a favore di una piena
espressione delle sue potenzialità. Questo vuol dire la possibilità di esaltare
le capacità che ha il cinema di narrare, di raccontare delle storie, senza però
attingere all'invenzione, ma attraverso quella che Grierson ha definito "elaborazione
creativa della realtà" [2]: si parte da
un avantesto, dalla realtà, e la si affronta ponendosi davanti ad essa con gli strumenti
del cinema, cercando di comunicarla nel miglior modo possibile, secondo un punto
di vista personale. Presento tre documentari che raccontano altrettanti personaggi
del mondo del jazz: Straight no Chaser
(1988) di Charlotte Zwerin su
Thelonious Monk, Notes from a Jazz Survivor
(1982) di Don McGlynn su Art Pepper
e Let's Get Lost (1989)
di Bruce Weber su
Chet Baker.
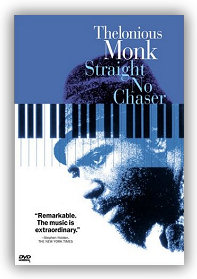
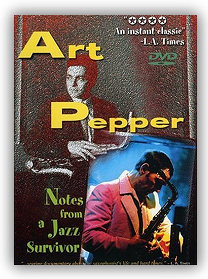
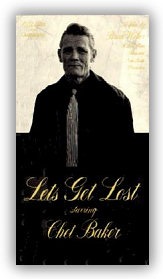
Straight No Chaser
Questo documentario vuole essere una sorta di biografia di Thelonious
"Sphere" Monk: poco dopo l'inizio del film una voce fuori campo racconta brevemente
la sua infanzia e i suoi primi passi nel mondo del jazz, mentre alla fine vediamo
le immagini del suo funerale. Nella parte centrale, però, più che la sua storia
il documentario cerca di comprendere, attraverso interviste ai suoi più stretti
collaboratori e conoscenti (il produttore, il manager, i musicisti che hanno suonato
con lui, il figlio etc.) e immagini di Monk stesso, quale sia il mistero
da cui sembra avvolto il musicista. Quello che ha spinto la regista Charlotte
Zwerin a realizzare il documentario (prodotto da Clint Eastwood sulla
scia di Bird) è stato
il ritrovamento del materiale su Monk girato dai fratelli Michael
e Christian Blackwood, che nel 1968 hanno
raccolto, in stile direct cinema, moltissime immagini dei suoi concerti,
delle registrazioni in studio, dei suoi momenti privati. Sono queste immagini, che
si credevano ormai perdute, ad occupare la maggior parte di Straight no Chaser.
Il merito della Zwerin è stato quello di aver reso attuali le riprese dei
fratelli Blackwood nonostante il contrasto colore/bianco e nero, quello quindi
di aver annullato la distanza storica con il montaggio, che alterna le interviste
al materiale ritrovato e rimontato a sua volta, dove le prime sembrano spiegare
e dare un senso al secondo, attraverso il racconto di episodi, esperienze e sensazioni
che quelle persone provarono vicino a lui. Come la sua musica, Monk era "strano",
apparentemente indifferente al mondo che lo circondava; come la sua musica, di cui
Martin Williams [3] ha esaltato il
virtuosismo ritmico e la capacità di sorprendere evidenziando l'impiego efficace
degli spostamenti d'accento, dei ritardi, degli anticipi e l'uso espressivo degli
spazi, dei silenzi, così Monk sorprendeva nella vita, alternando momenti
di mutismo innaturale, in cui sembrava fuori dal mondo, a periodi di grande euforia
e agitazione. Fu considerato da molti un folle e subì gli inconvenienti che questa
sua reputazione di uomo e di musicista gli procurava (per molti anni lavorò saltuariamente
in locali di quart'ordine e addirittura non lavorò per nulla dal
1951 al 1957
perché privato della cabaret card [4]
dalla polizia), ma in realtà era estremamente lucido e sensibile, cosa che venne
riconosciuta col passare degli anni, quando le sue composizioni e la sua musica
vennero accettate e studiate come apporto fondamentale al jazz. Era misterioso
però, come il titolo di una sua composizione, ed era misterioso anche il suo rapporto
con le persone che aveva accanto (la moglie Nellie, il produttore Teo
Macero, la baronessa Nica, il sassofonista Charlie Rouse), come
lasciano intendere queste stesse persone nelle interviste in Straight no Chaser.
Nelle immagini dei fratelli Blackwood, quelle che mi interessa approfondire,
sono riprese molte performance di Monk con il suo quartetto prima
e ottetto poi, ma a differenza di quello che avviene nella documentazione dell'evento
jazzistico di cui abbiamo parlato prima, qui non sembra che i due registi siano
attenti alle relazioni tra i musicisti e a quello che avviene sul palco durante
il concerto, quanto al personaggio Monk: è lui costantemente al centro delle
riprese, è lui il soggetto che si vuole indagare. Penso infatti che lo scopo dei
Blackwood fosse proprio quello di indagare il mistero e la "stranezza" del
pianista, la sua lucida follia, che solo l'occhio attento di una macchina da presa
può narrare. Mi vengono in mente, per esempio, le numerose volte che vediamo
Monk girare su se stesso, in qualsiasi luogo, quasi un balletto irrinunciabile
di cui sente il bisogno e per cui prova piacere, cosa che fa sorridere molti ma
che nello stesso tempo può essere interpretato come segno di coerenza con se stesso
e la sua musica, come conferma Giorgio Gaslini quando scrive che questo girotondo,
questa figura, si ritrova nelle sue composizioni, caratterizzate da "un costrutto
armonico circolare che tende a collegare le armonie in rapporto di quinte concentriche"
[5]. Ancora, a dimostrazione della sua sensibilità,
mi affascina prendere ad esempio la risposta data a Teo Macero, il suo produttore,
il quale, passato molto tempo dall'ultimo incontro, disse che lo aveva trovato ringiovanito:
"E' bello che tu dica questo, io ora ti sto sentendo, t'ho sentito prima che
lo dicessi". Inoltre Monk era imprevedibile anche nei movimenti: si racconta
nel documentario che poteva rimanere sveglio anche per tre o quattro giorni di fila
e andare su e giù senza fermarsi mai. Si può così capire quanto potesse essere difficile
documentare un personaggio del genere e non a caso anche Stern e Smight
hanno avuto a che fare con il "problema Monk": in Jazz on a Summer's Day,
mentre gli altri musicisti vengono inquadrati più a lungo, vediamo suonare Monk
solo pochi secondi all'inizio del brano e poi l'inquadratura lo abbandona completamente
fino alla fine del pezzo, evitando così il problema; in The Sound of Jazz,
il regista decise di far sedere Count Basie davanti a Monk per renderlo,
come dice Gabbard, "meno bizzarro perché vicino ad una tra le figure più
amate della storia del jazz" [6], fatto
confermato proprio in Straight no Chaser dal manager di Monk, che
racconta di quanto il pianista fosse infuriato per il fatto che Count Basie
l'avesse fissato tutto il tempo con aria compiaciuta. Ma questi sono due espedienti
che non risolvono il problema, anzi, nemmeno lo affrontano. A mio avviso, invece,
il metodo scelto dai fratelli Blackwood è quello più appropriato: sfruttando
l'attrezzatura leggera, la macchina da presa pedina letteralmente il pianista e
lo accompagna con lunghi piani-sequenza in qualsiasi momento e luogo, pubblico o
privato, durante i concerti o nelle camere d'albergo, per la strada o con la moglie,
superando il "problema Monk" semplicemente mantenendolo sempre al centro dell'inquadratura,
avendolo come riferimento costante. In questo tipo di documentari, quando cioè il
documentarista segue un personaggio e ne racconta la storia, è inevitabile che ciò
che si documenta non può essere tanto la sua vita, quello che fa durante la giornata,
quanto la sedimentazione della relazione tra un'istanza che vuole rappresentare
e una che si lascia rappresentare, cioè quella tra il regista che filma e il personaggio
che sa di essere filmato e che sta interpretando se stesso, o meglio l'immagine
che di se stesso vuole dare. In questo caso però, proprio per il comportamento di
Monk ed il suo quasi totale distacco dalla realtà (forse troppo devoto alla
sua musica per occuparsi del resto), il ragionamento appena fatto sembra non reggere
più e quello che Bill Nichols chiama "modo di rappresentazione osservativo"
[7], cioè quello che, pur nella consapevolezza
dell'impossibilità di una trasparenza assoluta, cerca di mostrare la realtà per
come essa appare, senza alcun tipo di intervento da parte del documentarista (adottato
qui dai fratelli Blackwood), in Straight no Chaser acquista ancora
di più forza e credibilità, tanto da proiettare lo spettatore lì, alle spalle di
Monk, e permettergli di danzare con lui quella figura che è la sua musica
ed il suo secondo nome: Sphere.
Notes From a Jazz Survivor
L'opera prima di Don McGlynn, il quale si rivelò col passare degli
anni un vero e proprio specialista di documentari musicali
[8], ottenne unanimi consensi da giornalisti, musicologi e ammiratori
in molte delle rassegne in cui fu presentata, come ad esempio al Berlin Film
Festival del 1983. Mai come in questo caso
il titolo è stato esemplificativo del contenuto del film e del metodo portato avanti
dal regista. La lunga intervista/confessione che Art Pepper, accompagnato
dalla moglie, concede a McGlynn è alternata con sequenze di concerti eseguiti
con il suo ultimo quartetto. Gli stacchi tra il concerto e l'intervista non sono
quasi mai netti: le parole cedono lentamente il posto alla musica (e viceversa)
attraverso una dissolvenza che è solo tecnica, sembra quasi, infatti, che Pepper
continui ad esprimere e a raccontare se stesso con la musica, soffiando nel suo
sax. Una "confessione" continua, quindi, anche se i passaggi dall'intervista al
concerto sembrano spezzarne la continuità, dando il senso di racconto improvvisato,
che procede in maniera disordinata, come se stesse seguendo degli "appunti" sparsi
(le "notes" del titolo). Appunti che delineano, nei cinquanta minuti del documentario,
il ritratto di un sopravvissuto, definizione che il sassofonista dà di se stesso
alla fine del film, quasi a riassumere in una parola la sua condizione ed il senso
della sua vita. Nato artisticamente nell'ambiente del cool californiano,
esempio più ovattato e in apparenza meno problematico dell'intera parabola jazzistica,
bello e proteso verso un grande successo, è costretto invece ad abbandonare la scena
per circa vent'anni a causa della dipendenza dall'eroina e di un lungo arresto per
rapina a mano armata. Spartiacque tra il prima e il dopo, la conoscenza della moglie
Laurie, che lo ha salvato dagli stupefacenti e che lo ha aiutato a riprendere
la carriera jazzistica diventando la sua manager. Solo la musica sembra poterlo
riscattare. E' il ritratto triste, fatto a pochi mesi dalla morte, di una persona
che ama la vita e che è nel pieno della sua rinascita creativa. Il modo di documentare
il jazz che stiamo affrontando in questo paragrafo trova forse il suo esempio più
essenziale e definitivo in Notes from a Jazz Survivor: a differenza di
Straight no Chaser dove Monk, personaggio misterioso, era raccontato dai suoi
collaboratori, o di Let's Get Lost dove Baker, come vedremo, sarà anche lui
a suo modo indecifrabile, qui la possibilità di comprendere la vita e quindi l'esperienza
del jazzman, linfa della sua musica, è offerta direttamente dall'interessato e senza
altre mediazioni se non quella della macchina da presa. Inoltre il montaggio, che
affianca l'intervista alla performance, rende ancora più esplicito questo
rapporto tra vita e musica, sua diretta conseguenza, come quando, per esempio, dopo
le parole di Art Pepper sull'incontro e la nuova vita con la moglie Laurie,
McGlynn ci fa sentire il brano scritto per lei, che così possiamo apprezzare
a pieno. Le parole si confondono con le note, il momento del ricordo con i silenzi
dello strumento, la dolcezza con la rabbia; nel rievocare le esperienze, le sofferenze
e le solitudini, divenute ora parte integrante della sua espressione, quelle stesse
parole colpiscono come gli assoli guizzanti del suo sax.
Let's Get Lost

|
Quando, alla fine del documentario, Bruce Weber domanda a
Chet Baker
se rivedrà con piacere il film, lui a fatica risponde: "Come potrebbe essere
diversamente Bruce. Santa Monica, quella scena nell'albergo, il bar, l'autoscontro,
lo studio, la spiaggia: era tutto così bello, era un sogno. Cose del genere non
succedono, o solo a pochissimi".
Chet Baker
muore poco dopo le riprese e non potrà rivedere quelle immagini, ma quell'atmosfera
di sogno annunciata dalle sue parole scorre per tutto il documentario come quei
fiumi in parte sopra e in parte sotto terra. Si può dire infatti che Let's Get
Lost agisca su due livelli: uno è quello dell'inchiesta e della memoria, portato
avanti dalle immagini di repertorio, dalle numerosissime fotografie e dalle varie
interviste alle mogli, ai figli, ai suoi collaboratori e amici e a
Baker
stesso; l'altro, più profondo, è appunto quello del sogno, della messa in scena:
le riprese sulla spiaggia di quattro giovani che ballano e parlano di musica (che
poi scopriremo essere i figli di
Baker),
il leitmotiv del primo piano di
Baker,
con al fianco due ragazze, sulla spider in corsa nella notte (quasi a riassumere
la sua vita "spericolata", circondato da numerosissime donne, ma sempre all'ombra
della droga), gli incontri al bar, la permanenza a Cannes durante il Festival del
Cinema del 1987.
Due livelli che si intrecciano continuamente e che pare rispecchino i
due volti di Baker: il volto della sua immagine stereotipata, quando era al culmine
del successo e bello come un divo del cinema (era considerato il James Dean del
jazz), che il regista ci mostra con lunghe carrellate sulle sequenze fotografiche
delle sale d'incisione, delle copertine dei dischi, delle riviste, e il volto rovinato
dall'eroina che viene analizzato ruga per ruga nei molti primi piani che Weber gli
concede. Un ritratto di Dorian Gray al contrario, come suggerisce Marco Vecchi
[9], dove il "vero"
Baker,
anche artisticamente parlando, sembra essere quello giovane e bello. Bruce Weber
non segue un filo narrativo ma gioca con questi due livelli attraverso un montaggio
più frammentato che alternato, dividendo il documentario in tanti tasselli di un
mosaico che lo spettatore dovrà mettere insieme e ricomporre se vuole comprendere
a pieno il personaggio, anche se il regista ci invita già dal titolo a non provarci
neanche, consigliandoci al contrario di "perderci" e lasciarci trasportare dalle
sensazioni, ancor più che dai fatti raccontati. Mi spiego in questo modo ad esempio
la particolare presenza della musica di
Baker
nel film: anche se la performance è messa in secondo piano rispetto ai suoi
guai, alle sue relazioni, la musica è sempre presente sullo sfondo, quasi a distogliere
lo spettatore da ciò che dicono gli intervistati e dargli così la possibilità di
potersi abbandonare a quelle note/parole, forse più sincere e vere.
Il metodo delle interviste, capace di mettere in luce aspetti e punti
di vista differenti di una stessa storia, oltre che di dare la possibilità all'intervistatore
di interagire col soggetto intervistato portando il discorso dove ritiene più opportuno,
in Let's Get Lost è ben articolato (basti pensare allo scontro a distanza
tra l'ultima moglie di
Chet Baker,
Carol, e la sua ex amante Ruth). Abbiamo accennato nel paragrafo su
Straight no Chaser alla relazione che si stabilisce tra chi sa di essere
filmato e chi sta filmando. In questo caso
Chet Baker,
a differenza di Monk, interagisce con il regista, il quale lo interpella
e gli fa domande anche provocatorie (quando si fa raccontare di come ha perso i
denti, o quando gli chiede che tipo di droga preferisce); spesso poi le risposte
di Baker sono smentite dagli altri intervistati (soprattutto dalle sue donne)
e questo non fa che alimentare il dubbio che nel caso di Thelonious Monk
era sparito, cioè quello della possibilità che il protagonista interpreti l'immagine
che vuole dare di sé. Questo viene ancora di più enfatizzato dalla presenza della
messa in scena, del livello del sogno di cui abbiamo parlato. Di conseguenza
Chet Baker
diventa attore e interprete di se stesso e procura nello spettatore un senso di
ambiguità e di dubbio difficile da eliminare. A questo mi riferivo quando nel paragrafo
precedente ho accennato all'indecifrabilità di
Baker:
chi è veramente, quello che raccontano le sue donne e i suoi figli, o quello che
da lui è interpretato? Sta allo spettatore scegliere. La sua ultima compagna, Diane,
raccontando il loro rapporto dice: "Non puoi fidarti di lui, solo se lo sai puoi
sopportarlo". Per concludere vorrei citare le poche parole con cui il dizionario
dei film Morandini descrive Let's Get Lost: "E' la storia di
Chet Baker,
trombettista jazz, bianco, tre mogli, quattro figli, un numero incalcolabile di
donne, amici, ammiratori. Sleale, infedele, mentitore, affascinante, ebbe rapporto
costante solo con la musica e con l'eroina" [10].
Questo è Chet
Baker, almeno quello che viene fuori dal film. Sono d'accordo anche
con Marco Vecchi quando dice che "Weber non ha troppi riguardi per un personaggio
che dichiara d'amare ma che in realtà distrugge, come uomo"
[11]. Mi viene in mente allora una domanda
che una ragazza rivolge a
Chet Baker
mentre si trovano in quella spider in corsa, che per ben otto volte ritorna nell'arco
del film, come ad indicare il viaggio sia fisico che interiore del protagonista:
"Credi che la vita può essere una nota Chet?" e lui: "A volte può esserlo,
per molta gente può esserlo veramente", a cui possiamo aggiungere: "e il
resto non conta".
Gli anni ottanta sono stati il periodo della memoria e della rivalutazione
del jazz e dei suoi musicisti. Questi tre documentari, tutti appartenenti a quel
decennio, cercano così di addentrarsi e capire meglio questo mondo attraverso i
suoi protagonisti. Simili tra loro per motivazioni, sono però diversi per approccio:
tutti e tre giocano e interagiscono con la realtà che hanno di fronte, seppure in
maniera differente. Straight no Chaser lascia che Monk si racconti
da solo, con i movimenti del suo corpo, le sue frasi quasi incomprensibili, il suo
modo di relazionarsi con gli altri, e questo è permesso grazie ad un vero e proprio
pedinamento della macchina da presa. Le interviste quindi assumono un ruolo marginale
ma nello stesso tempo decisivo per comprendere il contesto in cui agiva Monk e spiegare
certe sue "stranezze". Notes from a Jazz Survivor ha una struttura semplice:
l'intervista qui è fondamentale, è l'unico mezzo attraverso il quale apprendiamo
e comprendiamo il personaggio, unico nostro punto di riferimento. La bravura del
regista è stata quella di riuscire a confondere l'intervista con la performance
e portare avanti il racconto di Art Pepper senza pause, come in flusso di
coscienza che cambia forma (la musica e le parole) ma non il contenuto. Let's
Get Lost, infine, è quello più complesso, perché complesso è lo stesso
Chet Baker.
La maniera attraverso cui Weber tratta la realtà che ha di fronte, frammentandola,
ricreandola, lasciando spazio a punti di vista molteplici, rispecchia infatti la
personalità dello stesso musicista, che tra sogno e realtà, non si lascia afferrare.
E' questo, secondo me, il modo migliore con cui il documentario si avvicina
al jazz, se non altro perché quando riascolteremo la musica di uno di questi jazzisti,
non solo ci abbandoneremo alle nostre emozioni, ma forse potremo partecipare anche
delle loro.
[1] "Per darsi come tale, si potrebbe dire, il documentario
deve autodichiararsi attraverso il processo di produzione significante che lo istituisce,
proclamare il più chiaramente possibile per immagini la propria intenzionalità di
essere documentario. Il documentario è trasparente al processo di produzione, non
per qualche tipo di innocenza, ma perché la trasparenza, qui, ha a che vedere con
l'enunciazione". NEPOTI, Roberto, op. cit., p. 145.
[2] GRIERSON, John, Documentario e realtà, Bianco e Nero, Roma s.a., p. 43.
[3] Cfr. WILLIAMS, Martin, cit. in POLILLO, Arrigo, op. cit., p. 635.
[4] La cabaret card era una tessera concessa dalla polizia a chi voleva essere impiegato
nei locali di New York muniti di licenza per la vendita di alcolici.
[5] GASLINI, Giorgio, Thelonious Monk, la logica del genio, la solitudine dell'eroe,
Nuovi Equilibri, Viterbo 1994, p. 46.
[6] GABBARD, Krin, Saving it twice: preserving jazz in documentaries, compilation
films and short subjects, in LA POLLA, Franco (a cura di), op. cit., p.111.
[7] Bill Nichols individua quattro modi attraverso i quali può agire il documentario:
modo espositivo, riflessivo, osservativo e interattivo. Quello osservativo tende
a farlo coincidere con i Cinéma Vérité e il Direct Cinema. Cfr. NICHOLS, Bill, Representing
Reality: Issues and Concepts in Documentary, Indiana University, Bloomington 1991,
pp. 38-43.
[8] Tra gli altri: The Soundies (1986), The Mills Brothers Story (1986), Glenn Miller:
America's musical hero (1992), Dexter Gordon: More than You Know (1996), Charles
Mingus: Triumph of the Underdog (1997) e The Legend of Teddy Edwards (2001).
[9] Cfr. VECCHI, Marco, Let's Get Lost, in "Cineforum", n. 293, 1990. Riportato
in www.municipio.re.it
[10] MORANDINI, Morando, il Morandini, dizionario dei film 2002, Zanichelli, Bologna
2001, p. 725.
[11] VECCHI, Marco, Let's Get Lost, op. cit.
| 04/05/2008 | 1 marzo 1984: ricordo di Chet Baker al Naima Club di Forlì: "La sua voce sottile, delicata, sofferta, a volte infantile, mi è rimasta dentro il cuore per molto tempo, così come mi si sono rimaste impresse nella memoria le rughe del suo viso, profonde ed antiche, come se solcate da fiumi impetuosi di dolore, ma che nello stesso tempo mi sembravano rifugi, anse, porti, dove la sua anima poteva trovare pace e tranquillità. La pace del genio, la pace del mito, al riparo delle tragedie che incombevano sulla sua vita." (Michele Minisci) |
|
Inserisci un commento
© 2006, 2007 - Jazzitalia.net - Paolo Ricciardi
- Tutti i diritti riservati
|
© 2000 - 2026 Tutto il materiale pubblicato su Jazzitalia è di esclusiva proprietà dell'autore ed è coperto da Copyright internazionale, pertanto non è consentito alcun utilizzo che non sia preventivamente concordato con chi ne detiene i diritti.
|
Questa pagina è stata visitata 8.543 volte
Data pubblicazione: 01/11/2007

|
|

