A quanti di noi è capitato almeno una volta di vedere un documentario
e pensare che quello che stavamo vedendo fosse preparato, già studiato in precedenza?
Non posso non ricordare, per esempio,
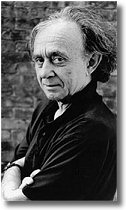 quando
in Welfare, di Frederick Wiseman, un
uomo racconta in un monologo, con estrema lucidità e spontaneità, la sua situazione
di disoccupato e di indigente: la prima cosa che mi sono chiesto fu se quella scena
fosse stata ricostruita e recitata da un attore professionista, ma non era così.
A mio parere sono questi i momenti in cui il documentario si può dire veramente
riuscito: quando riesce a superare la fiction più studiata, quando il regista,
senza saperlo in precedenza, si trova a cogliere dei momenti così intensi e particolari,
così unici che nessuna prova e nessuna scrittura previa può ottenere. quando
in Welfare, di Frederick Wiseman, un
uomo racconta in un monologo, con estrema lucidità e spontaneità, la sua situazione
di disoccupato e di indigente: la prima cosa che mi sono chiesto fu se quella scena
fosse stata ricostruita e recitata da un attore professionista, ma non era così.
A mio parere sono questi i momenti in cui il documentario si può dire veramente
riuscito: quando riesce a superare la fiction più studiata, quando il regista,
senza saperlo in precedenza, si trova a cogliere dei momenti così intensi e particolari,
così unici che nessuna prova e nessuna scrittura previa può ottenere.
Il merito del documentarista è quindi trovarsi nel posto giusto al momento
giusto, ma questo di certo non ha a che fare con la casualità, quanto con la sua
organizzazione. "Organizzare il caso", quindi, come fanno i musicisti di
jazz. E' proprio in questo che vedo una forte affinità tra questa musica e il documentario:
nel loro approccio. La labilità della distinzione tra fiction e documentario
è ormai acquisita, ma ogni qualvolta si sia tentato di dare una definizione di documentario
il critico ha fatto sempre riferimento alle loro diverse modalità di approccio con
la realtà.
Roberto Nepoti, cercando di riassumere questo concetto, dice: "Una
prima condizione postula dunque che il documentario riveli sotto il testo la presenza
di un avantesto, conservi la traccia di uno spazio della realtà la cui esistenza
profilmica è solo contingente e provvisoria. […] Si constaterà [così] una prima
differenza di base con il film di finzione romanzesca: mentre quest'ultimo lavora
solo ai fini del testo,
 il
documentario lavora, anche ove in esso vi sia messa in scena, contemporaneamente
il testo e l'avantesto. […] L'ambizione suprema della fiction, creazione dell'immaginazione,
è darsi come realtà; l'ambizione del documentario, testimonianza sulla realtà, non
può essere che mostrarsi mentre si fa" [1]. il
documentario lavora, anche ove in esso vi sia messa in scena, contemporaneamente
il testo e l'avantesto. […] L'ambizione suprema della fiction, creazione dell'immaginazione,
è darsi come realtà; l'ambizione del documentario, testimonianza sulla realtà, non
può essere che mostrarsi mentre si fa" [1].
Mostrarsi quindi nella sua interazione con una porzione di realtà che,
anche se parzialmente controllabile e organizzabile, continua ancora ad essere dotata
e ricca di un'ambiguità ed una variabilità notevoli, capace quindi di lasciare il
regista con nulla di fatto o con momenti intensi e imprevedibili come quello sopra
citato. Questa caratteristica del documentario, aperto ad ogni possibilità ed eventualità,
è presente nel jazz (soprattutto in quello più improvvisato), musica che più di
tutte nasce dalle emozioni dei musicisti, dalla loro capacità di interazione, dai
loro pensieri e da moltissime altre variabili che dovranno, nel momento della
performance, essere organizzate e conciliate in un flusso continuo che, come
il documentario, si fa ascoltare nel momento della sua creazione. Lo spettatore
non deve far altro che ascoltare e lasciarsi trasportare da questa incertezza continua.
Nel migliore dei casi succederà quello che dice Art Pepper in
Notes from a jazz survivor (1982),
di Don McGlynn: la parte criminale del jazzista, sempre pronta a prendere
il sopravvento, uscirà fuori e, armata del suo strumento, rapirà l'anima dello spettatore
con il flusso delle emozioni.
[1] NEPOTI, Roberto, Storia del documentario, Pàtron, Bologna
1988, p.144.
Inserisci un commento
© 2006 - Jazzitalia.net - Paolo Ricciardi
- Tutti i diritti riservati
|
© 2000 - 2026 Tutto il materiale pubblicato su Jazzitalia è di esclusiva proprietà dell'autore ed è coperto da Copyright internazionale, pertanto non è consentito alcun utilizzo che non sia preventivamente concordato con chi ne detiene i diritti.
|
Questa pagina è stata visitata 6.017 volte
Data pubblicazione: 08/12/2006

|
|

