Jerome Harris: basso, chitarra,
banjo
John
Patitucci: contrabbasso
Danilo
Perez: pianoforte
Jack Dejohnette: batteria

 Per
l'indiscutibile talento, l'originalità, la versatilità, le ormai innumerevoli collaborazioni,
quando è di scena Jack Dejohnette, è difficile sapere cosa aspettarsi. Inoltre,
è da circa un anno che
Per
l'indiscutibile talento, l'originalità, la versatilità, le ormai innumerevoli collaborazioni,
quando è di scena Jack Dejohnette, è difficile sapere cosa aspettarsi. Inoltre,
è da circa un anno che
 DeJohnette
ha fondato una propria etichetta, la Kindred Rhythm/Golden Beams, che
ha già al suo attivo due registrazioni a suo nome: Music from the Hearts of the
Masters con il percussionista africano Foday Musa Suso e Music in
the Key of Om dalle atmosfere ambient, e una prossima, molto attesa,
in duo con Bill Frisell, The Elephant Sleeps But Still Remembers.
Ebbene, nonostante la sua recente produzione "di confine", stasera all'Auditorium
di Roma, in Quartetto, DeJohnette ha offerto una performance che ha
entusiasmato soprattutto gli amanti del jazz, coloro che riconoscono in DeJohnette
un batterista che ha segnato gli ultimi quarant'anni di storia del jazz. Del
resto, i nomi dei componenti del suo Quartetto non lasciavano dubbi in tal senso:
Danilo Perez
al piano e
John Patitucci al contrabbasso, che hanno contribuito non poco
al recente rilancio in grande stile di
Wayne Shorter, e Jerome Harris al basso elettrico, chitarra e
banjo, già con DeJohnette nel suo ultimo lavoro con la Ecm (Oneness,
1997).
DeJohnette
ha fondato una propria etichetta, la Kindred Rhythm/Golden Beams, che
ha già al suo attivo due registrazioni a suo nome: Music from the Hearts of the
Masters con il percussionista africano Foday Musa Suso e Music in
the Key of Om dalle atmosfere ambient, e una prossima, molto attesa,
in duo con Bill Frisell, The Elephant Sleeps But Still Remembers.
Ebbene, nonostante la sua recente produzione "di confine", stasera all'Auditorium
di Roma, in Quartetto, DeJohnette ha offerto una performance che ha
entusiasmato soprattutto gli amanti del jazz, coloro che riconoscono in DeJohnette
un batterista che ha segnato gli ultimi quarant'anni di storia del jazz. Del
resto, i nomi dei componenti del suo Quartetto non lasciavano dubbi in tal senso:
Danilo Perez
al piano e
John Patitucci al contrabbasso, che hanno contribuito non poco
al recente rilancio in grande stile di
Wayne Shorter, e Jerome Harris al basso elettrico, chitarra e
banjo, già con DeJohnette nel suo ultimo lavoro con la Ecm (Oneness,
1997).
 Il
concerto si è diviso in due parti, composte ognuna da una lunga suite di tre brani,
di cui soltanto una metà a firma DeJohnette. Inutile sarebbe rimarcare l'inimitabile
stile di DeJohnette, in piena forma, che, senza monopolizzare la scena con lunghi
e vigorosi assolo a margine dell'esecuzione di gruppo, si è piuttosto lasciato ispirare
dalle intuizioni ritmiche dei suoi compagni per suonarvi,
Il
concerto si è diviso in due parti, composte ognuna da una lunga suite di tre brani,
di cui soltanto una metà a firma DeJohnette. Inutile sarebbe rimarcare l'inimitabile
stile di DeJohnette, in piena forma, che, senza monopolizzare la scena con lunghi
e vigorosi assolo a margine dell'esecuzione di gruppo, si è piuttosto lasciato ispirare
dalle intuizioni ritmiche dei suoi compagni per suonarvi,
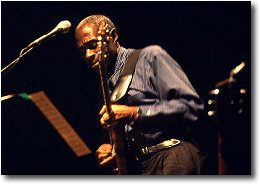 con
sottile sensibilità, fuori se non proprio contro, in modo tale da
tener sempre viva una certa tensione; soprattutto, però, c'interessa evidenziare
la grande sinergia del Quartetto, in cui anche piano e chitarra contribuivano alla
ritmica, come spesso accade quando il leader della formazione è il batterista. Certo,
l'affiatamento tra
Perez
e Patitucci,
rodato dai numerosi concerti con
Shorter, era evidente, tanto che forse proprio Harris è sembrato
a volte un po' a margine delle lunghe e trascinanti improvvisazioni, anche se sempre
puntuale nei suoi interventi dentro il brano.
con
sottile sensibilità, fuori se non proprio contro, in modo tale da
tener sempre viva una certa tensione; soprattutto, però, c'interessa evidenziare
la grande sinergia del Quartetto, in cui anche piano e chitarra contribuivano alla
ritmica, come spesso accade quando il leader della formazione è il batterista. Certo,
l'affiatamento tra
Perez
e Patitucci,
rodato dai numerosi concerti con
Shorter, era evidente, tanto che forse proprio Harris è sembrato
a volte un po' a margine delle lunghe e trascinanti improvvisazioni, anche se sempre
puntuale nei suoi interventi dentro il brano.
La natura e l'ispirazione dei brani è stata varia, volendo attraversare
il più possibile la diversa sensibilità dei musicisti e di DeJohnette in
primis: non è certo mancato swing, come in
One Finger Snap di Hancock,
e nemmeno una classica ballad, ma la presenza al piano di
Perez
ha di certo contribuito a che in più di un brano emergessero atmosfere e sonorità
latine. Fino all'ultimo brano,
African Wave, una composizione proprio di
Perez,
che, con il suo tema semplice e immediato, accompagnato dai vocalizzi di Harris,
con la sua sonorità solare e festosa, ha entusiasmato il pubblico, che, ancora in
piedi, ha atteso il bis. Come spesso capita nei concerti di DeJohnette, che
non manca occasione per dichiarare le sue convinzioni pacifiste, il bis era un inno
alla pace, Song for Peace.
Un brano senza ricercatezza compositiva, senza grande fantasia improvvisativa, senza
virtuosismi, soltanto una sorta di suggestivo spiritual che progressivamente
prendeva corpo nel canto di Harris.

