|
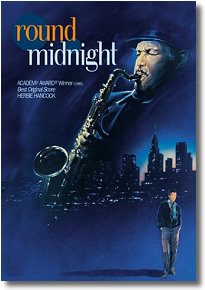
'Round Midnight
(A mezzanotte circa, Bertrand Tavernier, 1986)
Visualizza il Trailer
La scheda completa del film
Ricorrendo ancora una volta al vocabolario della lingua italiana, osserviamo
che la prima frase che appare alla voce "mosaico" dice così: «Tecnica
pittorica fondata sull'impiego di elementi (tessere) giustapposti o applicati ad
una superficie».
Il film di Tavernier
(Lione, 25 apr 1941), indiscutibile
omaggio al jazz, è un particolare mosaico dove migliaia di tessere si fondono sullo
schermo per donarci in una totale visione d'insieme la storia immaginaria di un
jazzista nero americano degli anni Cinquanta.
Ma chi è costui? Chi è Dale Turner se non la combinazione, la fusione
di più elementi estrapolati dalla vita dei più grandi e maledetti rivoluzionari
del jazz di quegli anni?
Magistralmente interpretato da Dexter Gordon, il tenor-sassofonista
per la prima volta sullo schermo in veste di attore, Dale con il suo sax e le sue
sbronze, ci accompagna in un viaggio attraverso il jazz, ma guidati questa volta
dagli occhi di una generazione europea che forse come nessun'altra è riuscita a
stabilire una comunicazione così totale da far mettere, a questa musica e ai suoi
protagonisti, radici profonde nella vecchia Europa. Gli occhi di questa generazione
sono quelli di Francis, un giovane grafico parigino che ha ascoltato per
la prima volta Dale all'età di tredici anni. Ora, quindici anni dopo, capisce che
del jazz e di Turner non né può più fare a meno.
Schermo nero. Sulle note di
'Round Midnight
( ),
il brano di Thelonious Monk che dà il titolo al film, partono i titoli di
testa. Ma non è una vera tromba quella che intona il brano. La scelta dell'esecuzione
è stata affidata alla voce di Bob
McFerrin che, evocando perfettamente il suono di questo strumento, apre
poeticamente l'opera. Una voce nuda, la sua, come quella del nero schiavo delle
origini. Il nero schiavo delle origini non possiede nulla. Il nero schiavo delle
origini canta il suo dolore e non possiede uno strumento per accompagnare il suo
canto. Non esiste uno schiavo nero che sorridendo spensierato strimpella il suo
banjo seduto su una balla di cotone. Questa è solo una creazione romantica, non
è la realtà. Solo col tempo gli strumenti sono entrati nella vita del nero e, anche
quando molto più tardi il jazz era solo quasi esclusivamente strumentale, il suono
che ne usciva era assai simile alla voce umana. Una voce che evoca, quella di
Bob McFerrin, evoca su un tappeto
di suoni vellutati. ),
il brano di Thelonious Monk che dà il titolo al film, partono i titoli di
testa. Ma non è una vera tromba quella che intona il brano. La scelta dell'esecuzione
è stata affidata alla voce di Bob
McFerrin che, evocando perfettamente il suono di questo strumento, apre
poeticamente l'opera. Una voce nuda, la sua, come quella del nero schiavo delle
origini. Il nero schiavo delle origini non possiede nulla. Il nero schiavo delle
origini canta il suo dolore e non possiede uno strumento per accompagnare il suo
canto. Non esiste uno schiavo nero che sorridendo spensierato strimpella il suo
banjo seduto su una balla di cotone. Questa è solo una creazione romantica, non
è la realtà. Solo col tempo gli strumenti sono entrati nella vita del nero e, anche
quando molto più tardi il jazz era solo quasi esclusivamente strumentale, il suono
che ne usciva era assai simile alla voce umana. Una voce che evoca, quella di
Bob McFerrin, evoca su un tappeto
di suoni vellutati.
Il film è un mosaico, uno dei due protagonisti è un disegnatore e la prima
inquadratura del film, dopo i titoli di testa, rimanda ad un quadro di Magritte.
Dale Turner, ripreso dalla macchina da presa (m.d.p.) di spalle, ci
riporta a quel particolare quadro, che ritraeva nella stessa posizione un uomo di
spalle con cappello e giacca nera. Solo che quello del dipinto aveva in più, disegnato
sulle spalle, un pentagramma e una cascata di note. Ma è lo stesso. Turner
vive per la musica: «sono stanco di tutto, tranne della musica» dirà
più volte nel film, Turner è la musica.
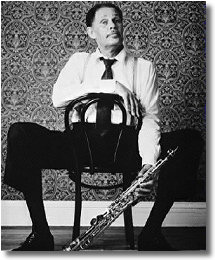 Poi
voltandosi si offrirà a noi in piano americano. La m.d.p. si sofferma per qualche
istante per poi abbandonarlo e partire con una panoramica che riprenderà una squallida
stanza d'albergo. Ci accompagna poi per l'ambiente che gradualmente cambierà il
suo spazio temporale: il luogo è lo stesso ma siamo tornati indietro nel tempo,
esattamente al momento prima della partenza per Parigi. Nella stanza ci sono lui
e un altro musicista nero, un amico, forse uno di quelli veri. Le condizioni di
quest'ultimo sono gravi, le motivazioni sono probabilmente le stesse che hanno distrutto
la vita della maggior parte degli uomini che hanno inventato il jazz: alcool, droga,
ospedali psichiatrici. La vista di questo accelererà la decisione di partire, ma
probabilmente non per fuggire alla sorte che è toccata agli altri, ma forse solo
e semplicemente così per partire senza altra spiegazione apparente. E se ne va percorrendo,
seguito dalla m.d.p. che lo inquadra di spalle, un angusto corridoio d'albergo pieno
di porte. Un ultimo sguardo alla sua New York da uno dei tanti ponti che l'attraversano
e poi Paris. Poi
voltandosi si offrirà a noi in piano americano. La m.d.p. si sofferma per qualche
istante per poi abbandonarlo e partire con una panoramica che riprenderà una squallida
stanza d'albergo. Ci accompagna poi per l'ambiente che gradualmente cambierà il
suo spazio temporale: il luogo è lo stesso ma siamo tornati indietro nel tempo,
esattamente al momento prima della partenza per Parigi. Nella stanza ci sono lui
e un altro musicista nero, un amico, forse uno di quelli veri. Le condizioni di
quest'ultimo sono gravi, le motivazioni sono probabilmente le stesse che hanno distrutto
la vita della maggior parte degli uomini che hanno inventato il jazz: alcool, droga,
ospedali psichiatrici. La vista di questo accelererà la decisione di partire, ma
probabilmente non per fuggire alla sorte che è toccata agli altri, ma forse solo
e semplicemente così per partire senza altra spiegazione apparente. E se ne va percorrendo,
seguito dalla m.d.p. che lo inquadra di spalle, un angusto corridoio d'albergo pieno
di porte. Un ultimo sguardo alla sua New York da uno dei tanti ponti che l'attraversano
e poi Paris.
Voilà, Paris. 1959.
Una manciata di dettagli riempie lo schermo, quasi nature morte. Di vivo
c'e solo lo spostamento della m.d.p. che ci offre una panoramica. Oggetti del quotidiano
in una cucina disordinata, piatti sporchi, ortaggi e ancora piatti sporchi. Ed ecco
apparire uno dei primi personaggi minori del film, l'inquilino della stanza "natura
morta" da poco inquadrata è un nero, è vestito con un'elegante vestaglia di
seta grigio perla, piuttosto in disaccordo con l'ambiente disordinato, ed è alle
prese con i fornelli. La m.d.p. si muove sapientemente e, quasi ad eliminare la
quarta parete, attraversa lo spazio accompagnandoci su un altro corridoio, ugualmente
stretto, ugualmente angusto con un'illuminazione che ricorda la stessa dell'altro
albergo, quello newyorchese. E' interessante questa scelta di Tavernier,
quasi a voler sottolineare come certe realtà di vita di passaggio e in questo caso
quelle di questi magnifici balordi musicisti, consumate negli alberghi, siano sempre
uguali ovunque ci si trovi. Che sia nella vecchia Europa o aldilà dell'oceano, le
cose sembrano non cambiare. Per questi suoi abitanti nomadi, le stanze si assomigliano
tutte, i corridoi si assomigliano tutti, le porte si assomigliano tutte. Nella loro
diversa percezione spazio temporale sembra che il tempo abbia un valore altro, scandito
da un ritmo altro, un ritmo in quattro quarti forse, dove conta solo quella melodia
che gli vive dentro e dove tutto quello che accade fuori ha poca importanza. Allora
va tutto bene, non importa se si consuma la propria esistenza in squallidi alberghi
senza nome, non importa se piove o fa bel tempo, quello che importa è improvvisare
a suon di musica la propria esistenza, coccolandola magari con quei gesti e quelle
manie quotidiane che ci accompagnano ovunque ci si trovi. E allora un altro albergo,
un altro corridoio, altre porte, un'altra camera, simile se non identica alla precedente,
esattamente come se non ci si fosse mai mossi da dove si era partiti. Si muove solo
quel mondo interiore inevitabilmente legato alla creazione. Così le stesse abitudini,
gli stessi gesti anche per l'inquilino in vestaglia argentata, che scopriremo anche
lui musicista e che esce solo la notte per andare a suonare dall'altra parte del
fiume per poi rientrare all'alba e reinfilarsi la sua magnifica vestaglia e ricominciare
a cucinare una delle sue bizzarre ricette, con quegli ingredienti esotici che porta
sempre con sé nei luoghi senza tempo delle camere d'albergo. Il refrain della
loro vita è sempre lo stesso, ma le modulazioni sono continuamente diverse. Una
vita improvvisata senza nulla di fisso, senza fissa dimora. Del resto prerogativa
del jazzista è l'improvvisazione, quello che sta facendo ora non si ripeterà mai
più. Ora e solo ora. Improvvisare suonando ha creato arte. Improvvisare vivendo
ha spesso creato morte. Questi grandi improvvisatori che con i loro strumenti sono
riusciti a stravolgere il mondo della musica, hanno allo stesso tempo stravolto
la loro vita.
Ma torniamo ai nostri personaggi. Il nero in vestaglia d'argento con una
profumata tazza di minestra accoglie a Parigi il nostro protagonista, saranno vicini
di camera. Dale attraversa con la sua camminata lenta il corridoio "gemello"
di quello newyorkese, ma con la m.d.p. di fronte questa volta. Ed ecco apparire
una tesserina del mosaico che va a posizionarsi delicatamente. Lo sentiremo spesso
chiamare le cose e le persone con l'appellativo Lady: Lady Ace,
Lady Hersh, Lady Francio, Lady "altro"…e il suo sassofono, l'amore
della sua vita, sarà Sweet Lady. Una tesserina estrapolata dal linguaggio
reale di uno degli uomini al quale il film è ispirato, Lester Young il musicista
dal suono più dolce che il jazz avesse conosciuto fino a quel momento. Lester
Young, tenor-sassofonista e Bud Powell, pianista, sono infatti, i due
personaggi del mondo del Jazz a cui Bertrand Tavernier e David Rayfiel,[7]
si sono maggiormente ispirati nella creazione di questo personaggio. Dale Turner
condensa in qualche modo in sé, le figure di questi esponenti maledetti, che tra
genio, follia e malattia hanno lasciato nella storia della musica un solco profondo.
Ma Tavernier aggiunge qualcosa in più, non solo Dale riassume tutto questo,
ma anche quello che lo circonda viene chiamato con dei particolari curiosi che ricordano
all'intenditore gli elementi di quel dato momento storico. Per esempio alla figlia
di Turner viene dato il nome Chan, ispirato forse al nome della moglie
di Charlie Parker, oppure la scelta dell'abito e dell'acconciatura con un'orchidea
bianca tra i capelli dell'amica cantante che arriva da New York, sono gli stessi
che abbiamo tante volte visto nelle foto che ritraevano la cantante di jazz Billie
Holiday. Un divertissement stilistico quasi, dove tesserina dopo tesserina
il mosaico si amplia.
Ma ritorniamo a Dale, Dale a Parigi, Dale nella sua nuova stanza d'albergo,
Dale attaccato a una bottiglia. La m.d.p. lo riprende complice nell'atto di mandare
giù un sorso di qualcosa di forte, e ancora complice lo riprende nel successivo
gesto di nascondere la bottiglia, dandoci il segno filmico che è qualcosa di proibito.
Ed ecco partito il primo segnale che denuncia la tragicità del personaggio. Turner
è naturalmente un alcolizzato e probabilmente anche tossicomane: le ultime scene,
infatti, ce lo racconteranno attraverso la figura ambigua di uno spacciatore che
gli circola intorno. Non ci saranno mai momenti espliciti durante l'arco del film,
ma Tavernier ci accompagnerà con naturalezza alla comprensione del tutto.
Da ora in poi, come anelli di una catena, si susseguiranno gli elementi che ci racconteranno
la condizione di vita-non vita del musicista e la necessità di preservarlo dalla
caduta nel baratro da parte di una serie di personaggi che gli circolano intorno.
Sembra però che coloro che gli sono a fianco e che lo controllano in continuazione,
lo facciano più per egoismo che per amore. La sua grassa e volgare compagna nera
che è anche la sua amministratrice, lo chiude a chiave in camera ogni qualvolta
ha il sentore che possa mettersi nei guai, i suoi datori di lavoro, due personaggi
tipici degli ambienti parigini di quegli anni, disegnati quasi macchiettisticamente,
non gli concedono mai neanche un goccio del tanto desiderato vin rouge per
paura che l'uomo non assolva al proprio compito. I musicisti della sua band
gli tolgono dalle vicinanze tutto quello che può assomigliare a qualcosa di alcolico,
non tanto per la sua salute quanto probabilmente per paura che, ubriacandosi, faccia
loro saltare la scrittura. Insomma tutti lo controllano, tutti lo giudicano, carcerieri
senza carcere attenti a non fargli saltare l'immaginario muro di cinta che possa
farlo evadere da questa prigione senza limiti. Tutti, ognuno con le proprie ragioni,
attratti da lui, ma lui non attratto da nessuno. Sembra non esserci scambio reale
nella vita di Turner, tutto quello che gli circola intorno sembra non avere
senso, sembra non interessarlo. La sola cosa che lo attrae è la musica, ma la musica
è gia dentro di lui. Allora solo scambi non-scambi, rapporti unilaterali, una vita
come di candela che sta annegando in sé stessa.
Ma ecco che qualcosa accade, e accade sotto la pioggia. Una panoramica
in esterno/notte, ci ritrae un vicolo parigino. Siamo fuori dal Blue Note
il locale dove Dale si sta esibendo. Piove, piove a dirotto e sotto questo prorompente
temporale argentato, la m.d.p. va a scovare un omino quasi raggomitolato in sé stesso,
che attaccato ad una di quelle finestrine altezza marciapiede, che più che portare
luce e aria portano polvere e cattivi odori, ascolta estasiato la musica che ne
sta uscendo. Un primo piano di profilo ce lo rimanda completamente bagnato, al freddo,
ma a lui sembra non importare, l'unica cosa che conta è la musica che esce da quel
finestrino. E' lì per Turner, solo per lui. E' ritratto subito dopo in una
scena quasi violenta. Un uomo, di quelli della notte, una specie di clochard,
gli domanda dei soldi, la sua reazione è sproposita per due motivi: uno perché viene
distolto dalla sua estasi, due perché se avesse avuto il denaro sarebbe entrato
nel locale. Due segni che in una frazione di secondo ci raccontano Francis:
ama a tal punto quella musica d'ascoltarla anche in pessime condizioni e non ha
un soldo. Il girato esterno si alterna con quello dell'interno del locale, regalando
a noi, fortunati spettatori rispetto a Francis, la possibilità di seguire come ad
un concerto dal vivo l'opera di Dale e della sua band. In rapporto ad altri
film sull'argomento, che preferivano l'intreccio ai momenti squisitamente musicali,
notiamo la scelta di Tavernier: egli ci concede di ascoltare le parti suonate
piuttosto a lungo, quasi a volerci mostrare, non con semplici dettagli di passaggio,
ma con lunghi momenti di ascolto, il senso più profondo di questa musica. E così
ci mischia ai suoi spettatori attenti, a questi ragazzi francesi degli anni Cinquanta
assidui frequentatori dei tavolini dei bistrot che ne hanno saputo comprendere
il significato riuscendo a farci amare ancora oggi questa forma d'arte così viva
e particolare. E' stata, infatti, questa gente ed altri europei prima di loro, a
dare un senso socialmente diverso a quell'importante rapporto di reciprocità tra
spettatore e jazzman, superando i confini della problematica razziale e partecipando
estasiati all'opera di questi geni. L'accoglienza europea ricevuta ha colpito molto
il musicista di colore in genere di quegli anni. I neri che già prima di loro avevano
avuto, per via della guerra, la possibilità di oltrepassare l'oceano, si resero
conto che esisteva una società bianca organizzata proprio come negli Stati Uniti,
ma allo stesso tempo così diversa da quella bianca americana. Da un tale confronto,
nacque un profondo risentimento per le restrizioni razziali alla quale il nero americano
era sottoposto e iniziarono una serie di disordini senza precedenti. La guerra permise
ai neri di considerare oggettivamente la loro triste condizione non più come dettata
da un immutabile destino, ma come un male.
 In
Europa era diverso, ed è anche per tale motivo che questi jazzman hanno sempre
accolto con entusiasmo l'idea di soggiornare per lunghi periodi fuori da quella
dimensione aspra che rappresentava l'America, terra che ormai erano costretti a
definire la loro. Interessante a questo proposito la descrizione che dà verso la
fine del film Martin Scorsese sulla vita di New York: questa volta non lo
incontriamo nei panni del grande regista che conosciamo ma in un cammeo che lo ritrae
in quelli d'attore e, interpretando il ruolo di un nevrotico manager, rivolgendosi
a Francis dirà: In
Europa era diverso, ed è anche per tale motivo che questi jazzman hanno sempre
accolto con entusiasmo l'idea di soggiornare per lunghi periodi fuori da quella
dimensione aspra che rappresentava l'America, terra che ormai erano costretti a
definire la loro. Interessante a questo proposito la descrizione che dà verso la
fine del film Martin Scorsese sulla vita di New York: questa volta non lo
incontriamo nei panni del grande regista che conosciamo ma in un cammeo che lo ritrae
in quelli d'attore e, interpretando il ruolo di un nevrotico manager, rivolgendosi
a Francis dirà:
Io conosco Parigi, l'ho liberata io Parigi, si ma ho lasciato che c'entrasse
De Gaulle per primo, in fondo era casa sua, se lo meritava! Parigi per me,
Parigi è un bellissimo posto […] ma io preferisco New York, per me è meglio New
York, New York per me…anche la musica è meglio perché è più dura. Qui la vita è
più tosta e sai perché? Perché la gente è più tosta qui, si non è da tutti New York…
In Occidente la vita dell'artista ha svariate connotazioni sociali e storiche.
In Europa, l'artista o il bohémien non solo viene tollerato, ma in molti
casi visto come una persona di capacità pregevoli anche se misteriose; in America
non esiste questa ammirazione e neppure tolleranza. L'artista e il suo compagno
di strada, il bohémien, sono di solito considerati degli inutili ciarlatani.
Come tali sono trattati da nemici. Esiste, nella società media americana, un completo
predominio di ciò che Brooks Adams chiamò «la sensibilità economica»,
che scoraggia ogni significativa partecipazione della sensibilità fantastica alla
vita politica ed economica della società e che è responsabile dell'astio dell'americano
medio verso l'artista. Questo fenomeno ha causato l'estraniamento dell'artista dalla
società, rendendo la cultura ufficiale americana, tanto anemica quanto incompetente
e lontana dalla realtà, e ha fatto sì che fosse definita «arte estraniata»
l'arte seria. Dovrebbe essere evidente a questo punto l'analogia con la vita del
nero in America e con la sua produzione artistica, connessa com'è con la natura
e al significato della sua estraniazione. Il giovane intellettuale o artista o
bohémien degli anni Quaranta e Cinquanta stabilì una sorta di identificazione
con il nero, cercando con vario successo, di trarre qualche arricchimento emotivo
dalla somiglianza delle due posizioni nella società. Per molti aspetti, questo tentativo
riuscì assai naturale, perché la musica nera degli anni Quaranta era stata la forma
d'arte più espressiva sorta in America ed era sostanzialmente improntata a posizioni
estetiche uguali a quelle dell'arte seria dello stesso periodo.
E così questa Parigi, mostrataci con la minuziosa cura della ricostruzione
di un'epoca, in un clima quasi quietamente malinconico, accoglie il rappresentante
di una realtà tanto difficile quanto affascinante come quella del jazz. Forse lo
accoglie con i suoi toni più estremi quello delle cave, dei jazz-club e della
sua popolazione, forse l'accoglie nel rapporto esasperato di una storia di affinità
elettive, di un'attrazione fatale, ma l'accoglie. E quando ad un certo punto
Dale uscirà dal locale dove si sta esibendo e dopo che gli si è ancora una volta
rifiutato il suo carburante emotivo -quel tanto desiderato verre de vin rouge-
troverà ad accoglierlo fuori un timido ed estasiato ammiratore che, nonostante si
ritrovi senza soldi in tasca, riuscirà a racimolare il denaro per pagare una birra
all'uomo che più di tutto ha cambiato il senso della sua vita. Piccole cose ci offrono
queste inquadrature, ma gigantesche dal punto di vista emotivo: i due uomini che
si guardano per qualche istante in silenzio, sono due uomini in preda al desiderio
assoluto di trovare un senso. Uno lo cerca nella disperata caccia ad un bicchiere
di qualcosa che bruci lo stomaco, l'altro lo cerca nell'uomo che con la sua musica
dà significato alle cose. E lo intravedono forse in quello sguardo, quello che cercano.
Ed ecco che scatta qualcosa, ed ecco che la storia diventa bipolare, ed ecco che
i rapporti perdono quel senso di vuoto, quell'unilateralità che niente, neanche
gli affetti più sinceri, riesce a colmare. Francis ha una bambina che ama
e vive con lui, ha una famiglia cara ed una moglie che se ne è andata perché forse
più di tutti aveva compreso che nulla riusciva a colmare quel vuoto insanabile che
il suo uomo si portava dentro. Solo con Dale e la sua musica si compirà il miracolo,
solo con lui le cose forse arriveranno ad essere chiamate con il loro nome. Sì,
paradossalmente proprio questo maledetto, quest'uomo senza contorni e senza interessi,
quest'autolesionista con una dedizione assoluta all'arte quasi da rasentare l'autoannullamento,
riuscirà a far gridare un metaforico Alleluja alla vita dello squattrinato
Francis che improvvisamente riuscirà ad essere stimato nel suo lavoro di designer
e nei suoi rapporti più intimi. Ma lo scambio sarà reciproco, anche i colori della
vita di Turner assumeranno toni più brillanti. Francis riesce a strapparlo
dalle grinfie dei suoi carcerieri restituendogli quella dignità umana che sembrava
definitivamente persa. Porgendosi a lui con amore stima e fiducia gli mostra che
la vita può prendere una strada diversa. Le sue notturne corse folli alla ricerca
dell'amico tra stazioni di polizia e ospedali, non gli faranno mai perdere la forza
di aiutarlo ad andare avanti. E così Dale riesce a compiere il grande passo quello
che non aveva mai fatto per nessuno, quello di smettere di bere. E lo fa per Francis,
finalmente qualcosa per qualcun altro. E' una reciproca salvezza dalla rovina, dove
l'unione di due drammi riesce a sfociare in almeno un periodo di profonda serenità.
Ma come tutte le storie anche questa deve volgere al termine. Ed è durante una passeggiata
in riva al fiume, che Dale comunica a Francis l'esigenza di tornare a casa. Ma casa
questa volta non vuol dire quella che divide con lui e la bambina, ormai da qualche
tempo, ma vuol dire New York. La m.d.p. inquadra in un p.p. (primo piano) l'uomo
francese, la notizia lo lascia impietrito, solo gli occhi ad un certo punto si muoveranno
confusi da una parte all'altra. Poi una inquadratura dal basso verso l'alto, che
parte dal mare per scoprire un gigantesco ponte, ci fa capire che siamo a New York.
I due uomini sono ancora insieme anche se per poco, presto "Lady Francis",
come lo chiamava Dale, tornerà in Francia. Dopo un breve soggiorno all'Alvin
Hotel, esattamente quello delle prime inquadrature del film -albergo famoso
per aver ospitato un numero di musicisti consistente, molti dei quali l'avevano
eletto a dimora stabile tanto da averci consumato gli ultimi giorni della loro esistenza-
il francese deve tornare a casa. La speranza di ripartire insieme all'amico non
è ancora andata perduta, fino a quando non si rende conto che all'appuntamento all'aeroporto,
Dale non si presenterà. Da allora non si vedranno più. Di lì a breve Francis riceverà
un telegramma che gli porterà la terribile notizia, che il suo amato amico Dale,
l'uomo che aveva dato un senso alla sua vita, è morto.
Nonostante il marchio Warner Bros, un produttore e uno sceneggiatore
americani, Tavernier artista al pari dei personaggi che riesce a raccontare,
non ha confezionato un film della tradizione del cinema americano di soggetto musicale
e di una tipica struttura del genere biografico. Una certa poesia, l'accuratezza
e la suggestione delle immagini raccontataci attraverso le sfumature, le tonalità
bluastre degli interni e di una Parigi notturna, il contrasto dei bianchi di una
luminosità rarefatta dei pochi scorci in esterno/giorno o la combinazione dei due
colori come quella delle pittorica scena al mare, sono dipinte da una mano assolutamente
europea e significativamente aurorale. Scelte registiche interessanti, come quella
del cinema nel cinema quando ad esempio Francis arriva nel locale e comincia ad
utilizzare una cinepresa che filmerà Turner. Le immagini selezionate, rigorosamente
in bianco e nero, verranno alternate da Tavernier nel montaggio, proprio
per sottolineare il ricordo di Francis dopo la morte del grande amico. Ogni qualvolta
nell'arco della pellicola vediamo Turner filmato in bianco e nero, capiamo
che sono le immagini riprese da Francis quand'erano insieme. Arrivano senza avvertirci,
amalgamandosi discretamente al resto del girato. Film nel film, per coinvolgerci
nel ricordo dell'amico francese e avere come lui, per qualche istante, l'illusione
che Dale Turner sia ancora lì.
Poi verso la fine del film, dopo la scena del telegramma, un girato dalle
immagini a noi più vicine, dove i colori, gli abiti e le sfumature in generale,
ce ne fanno riconoscere la contemporaneità, differenziandosi dalle riprese che abbiamo
avuto davanti agli occhi fino a qualche istante prima, ci fanno capire che il tempo
è passato. In un totale di un palco gigantesco e migliaia di persone che aspettano
l'inizio di un concerto, riconosciamo, nella figura dell'uomo che apre la serata,
il pianista che suonava con Turner.
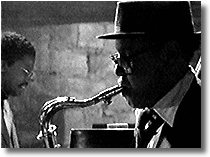 Tra
l'altro l'uomo, che non abbiamo ancora presentato, è
Herbie Hancock, il noto musicista che è anche il curatore delle
musiche del film.
Hancock
ha scelto quasi sempre standard di quel periodo ma ha composto ex-novo
anche una serie di brani che completano la colonna sonora. A suonarli si sono impegnati
una fitta schiera di maestri del jazz a cominciare dal protagonista Dexter Gordon
per passare ad altri mostri, come
Chet Baker,
Pierre Michelot,
Cedar Walton
fino ad arrivare a coloro che hanno debuttato all'epoca del film come, gli ormai
noti
Wayne Shorter o Billy Higgins o John Mclaughlin,
in un risultato di raffinatissimo soundtrack che sposa perfettamente le immagini
dell'intero film. Tra
l'altro l'uomo, che non abbiamo ancora presentato, è
Herbie Hancock, il noto musicista che è anche il curatore delle
musiche del film.
Hancock
ha scelto quasi sempre standard di quel periodo ma ha composto ex-novo
anche una serie di brani che completano la colonna sonora. A suonarli si sono impegnati
una fitta schiera di maestri del jazz a cominciare dal protagonista Dexter Gordon
per passare ad altri mostri, come
Chet Baker,
Pierre Michelot,
Cedar Walton
fino ad arrivare a coloro che hanno debuttato all'epoca del film come, gli ormai
noti
Wayne Shorter o Billy Higgins o John Mclaughlin,
in un risultato di raffinatissimo soundtrack che sposa perfettamente le immagini
dell'intero film.
Hancock prima di iniziare con parole di stima omaggerà l'uomo a cui
è dedicato il concerto.
E' strano, il Dale Tarner del film di Tavernier sembra un
personaggio realmente vissuto, come se da un certo punto in poi non riuscissimo
a vederlo come una figura immaginaria. Questo accade spesso in cinema, affezionandoci
ai protagonisti condividiamo le vicende con loro come se fossero figure effettivamente
reali. Nel caso di Turner però le cose sono un po' diverse. Se ripensiamo a quella
sintesi operata dal regista, che ha riassunto nel personaggio la vita di due mostri
del jazz, allora forse capiamo perché lui ci appare così reale. Sintetizzando nell'immaginario
sassofonista un po' di
Powell,
un po' di Young e un po' di Gordon stesso, questa biografia acquisterà
dei contorni più veri. Sul p.p. sorridente di Dale in bianco e nero delle ultime
immagini del film e ascoltando la sua voce over, salutiamo anche noi insieme a Francis
l'uomo che ha riassunto in sé un pezzetto di jazz e della sua storia.
Io spero, Lady Francis, che vivremo abbastanza a lungo per vedere un viale
che porta il nome di Charlie Parker, un parco Lester Young, una piazza
Duke Ellington e perfino una strada con il nome di…Dale Turner.[8]
[7] Per la costruzione del personaggio
il regista e il co-sceneggiatore hanno seguito le indicazioni filologiche di Francis
Paudras e del suo romanzo La danza degli infedeli.
[8] Dall'ultima scena del film.
| 27/08/2011 | Umbria Jazz 2011: "I jazzisti italiani hanno reso omaggio alla celebrazione dei 150 anni dall'Unità di Italia eseguendo e reinterpretando l'Inno di Mameli che a seconda dei musicisti è stato reso malinconico e intenso, inconsueto, giocoso, dissacrante, swingante con armonizzazione libera, in "crescendo" drammatico, in forma iniziale d'intensa "ballad", in fascinosa progressione dinamica da "sospesa" a frenetica e swingante, jazzistico allo stato puro, destrutturato...Speriamo che questi "Inni nazionali in Jazz" siano pubblicati e non rimangano celati perchè vale davvero la pena ascoltarli e riascoltarli." (di Daniela Floris, foto di Daniela Crevena) |
|
Inserisci un commento
© 2006 Jazzitalia.net
- Cinzia Villari - Tutti i diritti riservati
|
© 2000 - 2026 Tutto il materiale pubblicato su Jazzitalia è di esclusiva proprietà dell'autore ed è coperto da Copyright internazionale, pertanto non è consentito alcun utilizzo che non sia preventivamente concordato con chi ne detiene i diritti.
|
Questa pagina è stata visitata 14.511 volte
Data pubblicazione: 27/08/2006

|
|

