|

Miles Davis
The Complete Columbia Album Collection
Dopo averne sezionato la carriera con una serie di box tematici, la Sony
ha deciso di rimontare il puzzle, allineando in un lussuoso cofanetto di 70 cd in
mini replica cartonata e un dvd, l'intero output discografico (52 titoli) del divino
Miles. nei suoi anni Columbia, ovvero quelli più sfavillanti e sempre presi a paragone.
Davis ha rappresentato un caso a parte nella storia del jazz, per quel coacervo
di intuito, genio e carisma che nel corso di una carriera davvero incomparabile,
gli ha consentito almeno tre rivoluzioni, passando dal bop al modale fino alle contaminazioni
con il rock e l'elettronica, salvo provare la stessa ammirazione per figure estreme
come Charlie Parker, Jimi Hendrix e addirittura Michael Jackson.
Cambiando uomini e coordinate, il mercuriale
trombettista ha celebrato l'epifanìa del suo mito, conquistando una fama planetaria
e una ricchezza da vera superstar, come mai nessuno avrebbe più fatto. Il limpido
fraseggio della suo prezioso strumento, poggiato su imperscrutabili linee melodiche
di verso ascendente che scolpivano lo spazio sonoro, l'indiscussa capacità nel motivare
i suoi uomini di pregio, spesso leader di altrettanti gruppi che con lui davano
sempre il massimo, la capacità di leggere il suo tempo e di anticipare le tendenze,
lo pongono come un iconoclasta assoluto, mai pago di allori e consensi. In questo
caso la saga parte dal 1956, con alcuni incontri fondamentali ormai alle spalle,
compresa la registrazione del seminale "The Birth Of The Cool", il primo
capolavoro registrato per la Capitol: Miles aveva formato un primo grande quintetto
con l'ancora acerbo
John Coltrane,
il gruppo comunque possedeva tiro e capacità, dividendosi le attenzioni insieme
agli altrettanto imprescindibili Jazz Messengers, quelli guidati da Art Blakey.
Liquidato alla svelta un primo soddisfacente impegno discografico con la Prestige,
il trombettista entrò in studio per incidere il suo rutilante debutto per la Columbia
che gli fece i ponti d'oro persino nella promozione, circostanza praticamente mai
avvenuta prima nel jazz: "Round About Midnight", raccoglie una manciata di
standards interpretati allo stato dell'arte con l'ausilio di una ritmica efficacissima
composta Red Garland (piano), Paul Chambers (contrabbasso) e Philly
Joe Jon (batteria). In particolare il celeberrimo tema monkiano rilascia uno
stato di eccitante tensione emotiva, tale da consegnarne la sua magnificenza assoluta
per l'eternità. Problemi legati alla dipendenza da stupefacenti vari che imprigionavano
quegli uomini così talentuosi ma fragili, costrinsero Davis a scioglierne repentinamente
le fila, salvo legarsi quasi subito alla geometrica perfezione di Gil Evans,
un arrangiatore supremo che gli confezionò addosso lo stupendo "Miles Ahead"
(1957), un lavoro per tromba e orchestra di ottoni. Era una suite raffinatissima
che per una parte della critica era un tentativo di ascesa all'estasi, un work in
progress capace di un ulteriore sviluppo in altri due album pensati bene e suonati
con qualche umana imperfezione, sopratutto per la necessità di contenere il budget
gravato dalle costose ore di registrazione.
"Porgy & Bess" (poggiato sul capolavoro Gershwiniano) e il complicato
"Sketches Of Spain", un affresco etnico in cui blues e flamenco si inseguono
nella magistrale scrittura di Evans abbinata allo stato di grazia raggiunto da Davis,
avrebbero potuto accontentare chiunque, non il nostro uomo, che poco dopo riforma
un piccolo organico per registrare "Milestones", prova generale della svolta
modale sublimata da "Kind Of Blue" (1959), il disco perfetto sul quale è
già stato scritto un fiume d'inchiostro. Qui vale la pena ricordare l'apporto fondamentale
di un altro Evans, il pianista Bill e l'assunto alla base di questa teoria, che
liberava la musica dalle gabbie forzose del bop, con la possibilità di improvvisare
sulle scale in luogo degli accordi. Impossibile fare meglio, se si fosse ritirato
già a questo punto, Davis sarebbe comunque rimasto a capo dell'olimpo jazzistico
che da quel momento in avanti avrebbe comunque governato a suo piacimento. Se qualcuno
dei musicisti entrava nel suo giro, allora voleva dire che la consacrazione personale
sarebbe stata imminente e lui sapeva scegliere come nessun altro. Dopo tanto clamoroso
successo seguì un periodo di stasi legato soprattutto alla riscoperta dei prediletti
standards affrontati con il solito magistero, in più bisognava registrare qualche
grave per quanto inevitabile defezione, (era ormai impossibile limitare Coltrane
al ruolo di gregario, sia pur di estremo lusso), o fare i conti con l'ascesa di
nuove fulminanti idee (da Eric Dolphy a
Ornette
Coleman che sembrava persino aver influenzato, con la sua totale libertà
di pensiero, l'atteso rientro sulle scene di
Sonny Rollins
dopo il suo clamoroso ritiro) che scossero il mondo del jazz, ma non Miles che proseguiva
imperterrito sulla sua strada. Con lui per qualche tempo rimasero il fine pianista
Wynton Kelly, l'antico sodale Chambers e il batterista Jimmy Cobb.
Il vuoto lasciato da Coltrane fu marginalmente soddisfatto dalla meteora Sonny
Stitt e dal più continuo Hank Mobley. Ma si sarebbe trattato di schermaglie.
Dopo aver cercato un'ultima (sfuocata) collaborazione con Gil Evans (1962)
sulle melodie zuccherose di Antonio Carlos Jobim, Davis era ormai pronto
a nuova svolta, per la quale risultò fondamentale la fiducia concessa a due musicisti
poco più che adolescenti: insieme al pianista
Herbie Hancock segnalatogli dal trombettista Donald Byrd, arrivò
il giovane fenomeno della batteria Tony Williams (non ancora maggiorenne)
destinato a diventare il perno inamovibile di tutta la straordinaria musica che
sarebbe arrivata da lì a poco. In uno stato di conclamata euforia, il "divino" formò
il suo secondo grande quintetto completato da Ron Carter (contrabbasso) e
George Coleman (sax), destinato presto a cedere il posto a
Wayne Shorter, un altro enfant-prodige influenzato da Coltrane che proveniva
dai Messengers di Blakey, dove aveva evidenziato un grande talento anche sul fronte
compositivo. Il suo ingresso si rivelò fondamentale per innalzare qualità e livello
e in tre anni (1963/1967), vennero così realizzati un discreto numero di album ("E.S.P","Miles
Smiles", "Sorcerer", "Nefertiti", "Miles In The Sky"),
che ribadirono quell'estetica scintillante e vertiginosa, lodata come riferimento
assoluto di quel periodo storico. Davis ribadì il suo definitivo affrancamento dagli
accordi nella magniloquenza di un fraseggio che si era fatto ancora più sfrangiato,
nei guizzi repentini che balenavano da quelle note allungate di proposito.
La spinta del bop per Davis sembrava ormai esaurita: suonare ancora pagine
di una bellezza ormai vetusta, non lo poteva certo soddisfare, e così improvvisando
su schegge tematiche e appoggiandosi anche all'elettronica che cominciava a fare
passi da gigante, (uno scandalo per l'ala purista e conservatrice del jazz), il
"divino" riunì una nuova formazione di otto elementi che comprendeva anche il chitarrista
John Mclaughlin,
Chick Corea
al piano elettrico e Joe Zawinul all'organo, aprendosi a una musica che per
certi versi richiamava quella del precedente quintetto, schiudendo però l'orizzonte
verso nuove contaminazioni con certe forme del pop e rock, di matrice essenzialmente
nera. Una musica eccitante, sviluppata intorno a una più che mai rinnovata e totale
fiducia concessa ai suoi uomini, in particolare sul fonte ritmico e armonico: a
lui era riservata una funzione di regia più o meno occulta, con un ulteriore frammentazione
delle linee melodiche, che sembravano originarsi come svanire nel nulla. E se "In
A Silent Way" (1969), è un etereo, concettuale e splendido aggiornamento di
"Kind Of Blue" (i musicisti convocati in studio non ebbero altro che poche
indicazioni su quello che Davis voleva fare, ma dietro sua indicazione i magnetofoni
vennero azionati immediatamente registrando ogni sospiro), tutto quello che si poteva
intuire in quei solchi si tramuta in vivida realtà per "Bitches Brew", un
doppio album il cui titolo è astutamente passibile di censura, ma fiammante nell'energia
selvaggia che lo pervade, con altri nuovi innesti (menzione d'onore per
Jack De
Johnette a Larry Young), in cui è ancora Davis ad emergere come
supremo deus ex machina, capace di ordinare ogni cosa con interventi pregni
di turbine e pathos, illuminando le già fascinose atmosfere in cui è Shorter
(soprattutto al sax soprano), ad assumere un ruolo fondamentale negli spigoli fascinosi
del suo personalissimo stile. L'album scosse e divise, ma vendette clamorosamente
bene. Miles si era ancora una volta proiettato verso aree dal confine incerto e
(anche) per questo straordinariamente affascinanti. In un battito di ciglia divenne
l'idolo di gran parte dei giovani che ascoltavano il rock, restando un testo sacro
per tutti quelli che si sarebbero avventurati nei dintorni di queste perigliose
coordinate: di sicuro "Bitches Brew" è anche il suo ultimo capolavoro in
casa Columbia, cui è riservato qualche altro bagliore ("On The Corner", 1972),
prima del provvisorio ritiro che avvenne nel 1975, in seguito a problemi di salute
abbinati a una più o meno latente crisi artistica. Quando rientrò con regolarità
solo 5 anni dopo, il nostro sembrava aver smarrito il suo immarcabile furore creativo:
da quel mucchio meritano il live "We Want Miles", l'ottimo gruppo che lo
seguì in studio per realizzare "Decoy" (1984) e la suite "Aura", commissionatagli
in Danimarca e rimasta a lungo inedita.
Si tirano così le somme di un operazione monumentale, proposta però a
un prezzo competitivo, sigillata da un bel libro di 250 pagine che ne cesella minuziosamente
altri dettagli. Nel dvd a corredo una performance rimasta inedita ripresa tra la
Svezia e la Germania nel 1967, con Shorter nel ruolo di co-leader. Altre
bonus track di medio interesse si abbinano alla performance (audio) integrale registrata
al mega raduno dell'isola di Wight nel 1970 con
Keith
Jarrett sul palco e Jimi Hendrix in prima fila: insieme avrebbero
dovuto tornare a Londra per definire i dettagli di un disco da fare in comunione
assoluta. Sappiamo poi come è finita, ma la quasi totalità di una saga ai confini
della leggenda è qui. Tutta da (ri) scoprire.
Vittorio Pio per Jazzitalia
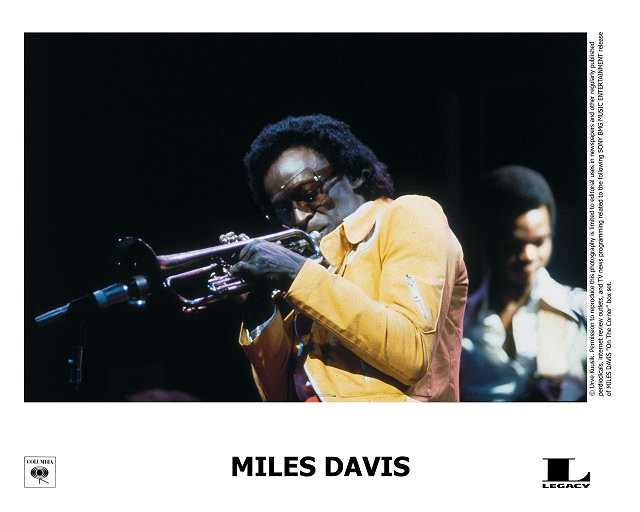
| 25/03/2010 | Hal McKusick si racconta. Il jazz degli anni '40-'50 visti da un protagonista forse non così noto, ma presente e determinante come pochi. "Pochi altosassofonisti viventi hanno vissuto e suonato tanto jazz quanto Hal Mckusick. Il suo primo impiego retribuito risale al 1939 all'età di 15 anni. Poi, a partire dal 1943, ha suonato in diverse tra le più interessanti orchestre dell'epoca: Les Brown, Woody Herman, Boyd Reaburn, Claude Thornill e Elliot Lawrence. Ha suonato praticamente con tutti i grandi jazzisti tra i quali Art Farmer, Al Cohn, Bill Evans, Eddie Costa, Paul Chambers, Connie Kay, Barry Galbraith e John Coltrane." (Marc Myers) |
|
Inserisci un commento
Questa pagina è stata visitata 5.514 volte
Data pubblicazione: 13/12/2009

|
|

