|
Intervista con Pino Minafra
febbraio 2012
di Vincenzo Fugaldi

photo by Agostino Mela
Dalla
tua famiglia, una famiglia di musicisti, è giunto sulle scene tuo figlio
Livio. È complicato il ruolo di genitore
quando un figlio intraprende la sua medesima carriera?
Assolutamente no, se questo avviene su basi di onestà, di bellezza,
di un gioco complesso e profondo. Se avviene su un terreno di arricchimento, non
solo nel porgere il tuo pensiero alla nuova staffetta, ma di completarlo,
inseguendo entrambi la stessa visione. Per secoli si è sempre fatto così, i
genitori tramandavano ai propri figli la propria vocazione, la propria passione.
Quando questo viene vissuto in maniera paritaria, rispettosa, senza un ruolo
autoritario, è possibile suonare, lavorare, sognare, lottare insieme, e quindi
non occorre arrivare a ciò che avveniva spesso nelle nostre generazioni, il
troncare con i genitori per cercare una propria realizzazione individuale. Con
Livio si è stabilito questo continuum, in maniera non stridente, e
nemmeno competitiva. Il punto d’arrivo è la bellezza, mettere a disposizione
tutto il proprio bagaglio per inseguire un’idea di bellezza. Questo è il
rapporto tra me e Livio, ma anche tra Livio e Margherita, la mamma, anche lei
musicista, clavicembalista. Recentemente è anche nato tra loro un duo,
pianoforte e clavicembalo. Il segreto è non forzare, non appesantire determinate
situazioni, ed è legato alla sensibilità del genitore di non entrare più di
tanto nella sfera dei figli, per non distruggerne l’autonomia di pensiero e
l’approccio alle cose. Io sono il primo di otto figli. Sono nato musicalmente in
banda. Gran parte degli organici che ho sono grandi, La Banda è di quaranta
persone, la Instabile è di diciassette, la MinAfric è di dodici-tredici, il Sud
Ensemble è di sette, per cui da sempre vivo insieme agli altri. Questo mi ha
temprato ed educato a rispettarne le individualità, impegno faticoso, ma
necessario per il bene comune. Se c’è qualcosa che sovrasta l’io, se riusciamo a
far diventare l’io noi, il problema è risolto.
Non
hai avuto mai alcuna incertezza per il futuro di tuo figlio, vista la precarietà
che talvolta interessa la vita dei musicisti?
A dire la verità no, mai. La cosa che mi inquieta un po’ è sapere che
Livio ha un’anima sensibile, perché è nato in un contesto di sensibilità ed
educato al bello, ed è vulnerabile rispetto alle violenze del mondo. Poi sono il
responsabile pieno della sua scelta musicale, perché ho intuito da subito le sue
capacità creative e compositive, e l’ho forzatamente indotto a compiere quel
percorso. Credo che sia il ruolo più delicato per un genitore, in un momento in
cui i figli non hanno capacità proprie, intervenire anche in maniera forzata,
assumendosi dei rischi. E non solo non mi pento, ma credo di avergli regalato un
mondo eccezionale di bellezza, di creatività, che certo comporta anche fatica,
rischio, come tutte le cose, però è impagabile, perché la musica è un po’ come
una messa, un rito magico, misterioso, che ti ricarica delle sofferenze di quel
quotidiano che distrugge milioni di persone in una routine spesso sterile e
senza prospettive e slanci, quando invece in ognuno di noi c’è un tesoro, un
Buddha, qualcosa che rende unici.
Facciamo ora un salto indietro nel tempo, per conoscere il modo in cui ti sei
innamorato della musica, e del jazz in particolare.
Ho sessant’anni, e quand’ero bambino a Ruvo non c’erano occasioni per
conoscere il jazz. L’ho conosciuto per mezzo di una radiolina, dove ogni volta
che sentivo un suono di tromba, anche nella musica leggera, ne ero colpito. Poi
ho visto in televisione l’immagine in bianco e nero di un trombettista europeo
tutto assorto, chiuso in sé stesso, che però raccontava la sua storia. A scuola,
al Conservatorio, imponevano di suonare musica scritta da un compositore. Avevi
davanti un percorso obbligato: piano, pianissimo, legato, staccato, lento,
veloce… Invece il jazz mi ha fatto capire che potevo raccontare la mia storia,
consentendomi di entrare in una modalità espressiva personale, che ritengo
sacra, perché ogni individuo ha un’unicità di pensiero, di valore, di azione.
Questo è stato il mio modo di entrare nel mood, in un cammino che è anche
iniziatico, perché è un modo diverso di vedere la vita, la musica. Il difficile
è restare fedele a questa idea, non diventare “professore”, “maestro”, restare
umile e al servizio di questo mistero, di questa componente, che per quanto mi
riguarda è anche mistica.
Ti sei
diplomato al Conservatorio di Bari durante la direzione di un grandissimo
artista, Nino Rota. Vuoi ricordare la sua figura?
Era una persona eccezionale, colta - laureato in lettere antiche -,
sensibilissima, ed era il musicista per antonomasia in quel momento, avendo
composto le musiche per i film di Fellini. Ma per me era soprattutto una persona
presente in Conservatorio, in tutti gli aspetti: conosceva gli alunni e i
docenti, che sceglieva personalmente. Spesso entrava in classe all’improvviso e
sentiva le lezioni di tutti, controllava - nel senso paterno e bello del termine
- gli alunni, aiutava quelli che non potevano comprarsi gli strumenti
acquistandoglieli, e a fine anno organizzava i saggi, mettendo in moto tutte le
forze presenti nel Conservatorio. A me ha consentito delle cose uniche: un
giorno andai a chiedergli se era possibile fare un saggio di jazz all’interno
del Conservatorio (stiamo parlando di quarant’anni fa, quindi molto prima del
Conservatorio di Santa Cecilia), e acconsentì, alla sola condizione che le cose
fossero fatte per bene. Con la nascente Jazz Studio Orchestra di Bari eseguimmo
un brano di Dizzy Gillespie, One Bass Hit, per tromba e
orchestra, e credo fosse la prima volta in Italia che si teneva un saggio di
jazz in un Conservatorio. A Rota chiesi pure qualcosa sulla questione degli
arrangiamenti, perché all’epoca non arrivavano informazioni sul jazz, sulle
tecniche, sugli accordi, sulla composizione, e mi disse onestamente che certi
arrangiamenti jazzistici delle sue colonne sonore non erano dovuti a lui, ma a
Carlo Savino. L’altro contatto molto importante con Rota è dovuto al
fatto che in quel periodo oltre al jazz suonavo musica antica, e lui aveva
scritto un brano molto bello per organo, due trombe e due tromboni, che siamo
andati ad eseguire al festival internazionale di Loreto. E poi ricordo che
l’anno in cui mi sono diplomato, il 1974, abbiamo eseguito un brano per tromba e
pianoforte, la Rhapsody in Blue, con il mio insegnante che suonava
nell’orchestra del San Carlo di Napoli. Dopo una cadenza di improvvisazione,
alla fine del pezzo, denunciai la povertà dell’istituzione Conservatorio, il
fatto che non c’era l’insegnamento della batteria, del sassofono, del jazz,
della musica leggera, della fisarmonica, della musica elettronica… C’era insomma
una visione veramente ridotta dell’universo musicale. E Rota approvò il mio
discorso, che aveva creato un po’ di imbarazzo nei docenti, mi chiamò in
disparte e disse che avevo perfettamente ragione, anche se quello che mancava al
riconoscimento della contemporaneità mancava anche nei confronti della musica
antica. Poi mi disse, letteralmente: “Se hai polvere, spara.”
Sei
stato leader di svariate formazioni: Praxis, Pino Minafra Quintet, Sud Ensemble,
Meridiana Multijazz Orchestra, Canto General, MinAfric Orchestra. Quali sono le
qualità che ricerchi in chi suona con te?
Grande generosità nel suonare, nell’improvvisare. Grande duttilità.
Saper leggere, saper sporcare, saper pulire la musica, ma soprattutto avere un
sacro fuoco ed essere disposto a leggere più segmenti, non solo jazz, etnico o
pop, ma un po’ di tutto, proprio per un’idea originaria che appartiene al mio
percorso. Avendo conosciuto tanti segmenti, e non rinunciando a nessuno di
questi perché fanno parte della mia visione, cerco musicisti in grado di dare
corpo a questa molteplicità sonora. È importante avere un pensiero compositivo,
ma non è affatto semplice e scontato trovare i compagni di viaggio che diano un
suono a quell’idea. È un po’ come una squadra di calcio: devi avere la capacità
di individuare la difesa, l’attacco, il portiere. Penso a Ellington, a Basie,
che avevano un suono fatto di grandi personalità all’interno dell’orchestra.
La
lista delle tue collaborazioni è corposa e densa di nomi prestigiosi. Vuoi
ricordarne qualcuna in particolare?
Misha Mengelberg, Han Bennink, la scena olandese,
Willem Breuker. Quando conobbi il loro modo di essere nella musica, mi sono
immediatamente identificato, perché ho scoperto che in me c’erano le stesse
frequenze: teatralità, ironia, il jazz tradizionale con quel modo di fare swing
unico, irripetibile. Non è stato casuale, per esempio, il fatto che per un
progetto ambiziosissimo con l’Orchestra sinfonica di Bari ebbi la possibilità di
chiamare Mengelberg, Bennink, e il grande trombonista Michele Lomuto,
collaboratore di Scelsi e Berio. Un’esperienza rivoluzionaria, Bennink veniva
dal Giappone con una serie di giocattoli… l’orchestra era impazzita, così come
il pubblico, perché era un happening. Breuker mi voleva invitare a
far parte del suo Kollektief, dato che per la prima volta mi aveva visto
applicare la tecnica della respirazione circolare alla tromba, ed era rimasto
colpito da questo fatto atipico, per me molto naturale, perché Minafra significa
“dall’Africa”. Sono nato africano, mi risulta facile suonare in maniera non
ortodossa, non occidentale, utilizzare certi suoni, i microtoni, una modalità
tutta africana che si trova anche in altre culture. Un fratello è stato Enrico Rava,
che mi ha aiutato anche a conoscere i Nexus, gruppo molto importante con cui ho
collaborato per molti anni; poi mi ha coinvolto in altri progetti, siamo stati
ad esempio insieme a Berlino in un grande festival. Con lui c’è stato un bel
confronto sull’idea di musica, di tromba, di lirismo, e certi punti ci hanno
accomunati. Voglio citare anche il rigore di Franco D’Andrea, un grande
musicista, che ha chiamato me, Trovesi, Furio Di Castri e Gianni Cazzola
per realizzare un excursus sulle grandi tematiche del jazz. È un musicista e una
persona che ammiro tantissimo per la profondità e la complessità del suo
pensiero. E poi Gianluigi Trovesi, con cui abbiamo lavorato oltre dieci anni,
grazie alle cose che ci accomunano: la banda, il jazz. Lui evidenzia un mondo di
fate, di gnomi, di magia, di leggerezza, io - ahimè - la pesantezza, perché il
terrone è pesante, almeno io lo sono… Poi Ornette Coleman,
che ho conosciuto a Parigi, alla Cité de la Musique, dove la Instabile ha
suonato. Speravo di farlo incontrare con l’orchestra, perché è stato il padre di
questa avventura, e sulla copertina del disco «Skies of Europe» (Ecm) ha
scritto poche parole ma estremamente importanti. Ha determinato una svolta nel
modo di vedere il jazz, e l’ha riportato al suo spirito originario: il jazz è
libertà.
Dell'Italian
Instabile Orchestra hai parlato lungamente anche in altre interviste, ma forse
potresti raccontare con maggiori dettagli l'esperienza con Cecil Taylor.
Credo che per me sia stata l’esperienza più alta in assoluto che
l’orchestra ha vissuto, perché Cecil non è solo un grandissimo musicista,
ma anche una persona colta, sensibile, fuori dall’ordinario. In tutti i sensi:
potergli parlare, stargli vicino, ascoltarlo è un esperienza mistica, perché è
uno sciamano, ha in sé un fuoco interiore. Lo manifesta quando suona con una
incredibile energia. Ha preso questi diciassette musicisti e li ha violentati,
disorientati, spaventati, perché non si è presentato con uno spartito normale,
ma con dei segni, dei geroglifici da interpretare. Molti dei componenti erano
disorientati, non volevano suonare più. Ma la tensione accumulata in quei tre
giorni è sfociata in un’energia unica ed irripetibile, si è consumato un rito
antico, primordiale, che ha portato i musicisti a cantare, danzare e suonare con
grande libertà controllata: apparentemente c’era del caos, ma era un caos
organizzato. È un’alchimia misteriosa, che solo pochi riescono a determinare. È
stata l’esperienza più alta, per quanto mi riguarda ancora più che con
Braxton, un grande intellettuale, che a Bolzano ci ha fatto compiere un
percorso nelle musiche del Novecento. Ma con Taylor siamo andati oltre. Lo
ritengo magico, misterico, sciamanico, esoterico, iniziatico.
Ci sono
ragionevoli speranze di poter riascoltare l'Italian Instabile Orchestra dal vivo
e su Cd?
Negli ultimi anni abbiamo pubblicato due dischi per Rai Trade, «Totally
Gone», registrato a Roma durante una trasmissione di Radiotre condotta da
Pino Saulo e «Creative Orchestra (Bolzano) 2007», che riguardava
l’incontro con Braxton - fiero di questo incontro al punto da intitolare il
disco Creative Orchestra, rifacendosi a un suo gruppo storico. Oggi, in questo
momento di grave decadenza politica e sociale che l’Italia sta attraversando,
l’orchestra sta pagando con il silenzio, perché questo grande laboratorio non è
mai stato protetto e accettato come necessario dalle istituzioni, come avviene
ad esempio in Francia per l’Orchestre National de Jazz.
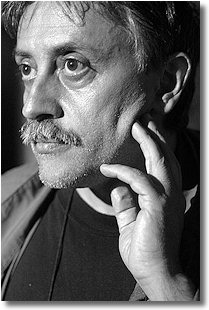 Dalla
tua produzione si apprende una lezione fondamentale: non esistono confini netti
tra le musiche, e la vera arte, quella che rimane, che lascia un segno, è
mescolata, meticcia, ibrida. Dalla
tua produzione si apprende una lezione fondamentale: non esistono confini netti
tra le musiche, e la vera arte, quella che rimane, che lascia un segno, è
mescolata, meticcia, ibrida.
Sì, credo che lo sforzo più grande sia quello di accettare la
diversità. La diversità è ricchezza, ma è anche sofferenza. Chi è dotato di
sensibilità, creatività, fantasia, è disponibile a volersi “sporcare”
incontrando l’altro. Con zone d’ombra e di luce, è chiaro. La musica, poi, è il
linguaggio universale per eccellenza. È quindi del tutto naturale che io, nato a
Ruvo di Puglia, emuli il suono del didgeridoo, strumento australiano, che in
fondo è una tromba preistorica, perché si suona facendo vibrare le labbra con
l’uso della respirazione circolare. A un “africano del nord” come me è venuto
naturale adoperare questa tecnica, o gridare in un megafono, simbolo della
precarietà, della protesta.
A quali
altri progetti stai lavorando, Pino?
Ho in corso due progetti: uno con Livio, la MinAfric Orchestra,
pensata per assecondare grandi progettualità, come nel caso del lavoro che
abbiamo fatto con Keith e Julie Tippett e Louis Moholo,
dedicato agli esuli sudafricani che arrivati in Europa hanno apportato una
ricchezza enorme alla nostra musica. Questo progetto ha girato i più importanti
festival europei, Parigi, la Slovenia, abbiamo fatto un disco per la Ogun, un
lavoro formidabile dove il grido che sconcerta, destabilizza e imbarazza è
sinonimo di bellezza. Sono concetti che possono essere accettati o meno, ma non
bisogna necessariamente piacere a tutti. L’altro progetto è Terronia: la
MinAfric con un gruppo vocale, le Faraualla, che legge i suoni del
Mediterraneo, di questo sud ricco, della Puglia che è in una posizione
geografica e politica strategica e grazie anche al lavoro di Nichi Vendola è un
laboratorio di eccellenza su vari fronti. Prossimamente la MinAfric lavorerà su
composizioni di Livio e mie. Poi ho un quintetto con cui siamo stati
recentemente in Marocco, a Rabat, e abbiamo incontrato il grande Mahmoud Guinea,
figlio di schiavi. Il quintetto consente di interagire con la musica in maniera
molto più fluida, a differenza dei grandi gruppi che implicano maggiori
difficoltà compositive e organizzative. Inoltre sto dando di nuovo visibilità
alla Banda di Ruvo e alla Instabile, nel rinato Talos Festival, che si
terrà dal 9 al 16 settembre 2012, con un’appendice dedicata alla Instabile per
intervento dell’European Jazz Network, spero con la presenza di un grande ospite
americano o europeo. La tematica del Talos sarà interamente dedicata alla banda
nella sua accezione più ampia, perché è il trait d’union che da sempre
accomuna la Puglia, il sud, l’Italia, ma la si liquida spesso pensando che sia
adatta solo alle feste patronali o alle parate militari o religiose. Invece è un
laboratorio musicale tutto da esplorare, e l’esperienza della Banda di Ruvo nei
festival più importanti d’Europa come Londra, Parigi, Saalfelden, Le Mans, il
Teatro dell’Opera di Lille o l’Auditorium di Roma dimostra che il suono della
banda è non solo vivo e attuale, ma conserva ancora quel calore che ne ha
determinato la scelta da parte di Matthias Winckelmann per festeggiare il
quarantesimo anniversario della Enja, una delle più importanti etichette
europee, proprio perché nella banda c’è quel calore, quella energia che un certo
jazz conserva ancora. Presenteremo bande che sposano delle precise progettualità
come la Kočani Orkestar, la Municipale Balcanica, Bandervish,
La Banda di Ruvo, insieme a grandi artisti come Bregović o
Marković, con la partecipazione di solisti quali Trovesi, Coscia,
Carlo Rizzo, Renaud Garcia-Fons. Nella fascia pomeridiana ci sarà
un convegno, cui spero di far intervenire anche Riccardo Muti, che da
sempre difende la banda nella sua essenza, perché sostiene che chi riesce a
stare in banda riesce a stare nella società, e Gianfranco Salvatore,
docente al DAMS di Lecce. Nelle bande i ragazzi si aggregano imparando a
rispettarsi, e nelle piccole realtà rappresentano l’unica possibilità per
mettere insieme i giovani e acculturarli. E poi le bande hanno in sé una
freschezza ancora tutta da esplorare. È una battaglia politico-culturale, in una
regione dove si è inondati dalla taranta, fenomeno dilagante perché semplice,
che arriva da una terra che per anni è stata isolata ed emarginata come il
Salento. Le bande invece hanno portato la grande musica a milioni di contadini,
arrivando sino alle realtà più isolate. Con l’idea di emulare la musica lirica
con trombe, tromboni e flicorni, abbiamo creato un suono unico. Nessuna banda al
mondo fa quello che facciamo noi, che abbiamo sostituito le voci con gli
strumenti. Credo che sia stata un’operazione culturale di grande portata: i
nostri nonni hanno scoperto Verdi, Wagner, Rossini, Mussorgsky attraverso la
banda, a differenza dei nostri ragazzi, che oggi subiscono una pessima qualità
di informazione musicale. Il festival sarà possibile grazie anche all’aiuto di
Puglia Sound, un’esperienza unica in Italia che sostiene le produzioni pugliesi,
e che nel momento di grave disagio, sconforto, tragedia che la cultura italiana
sta vivendo, rappresenta uno spazio pubblico unico di osservazione e sostegno.
| 15/08/2010 | Südtirol Jazz Festival Altoadige: "Il festival altoatesino prosegue nella sua tendenza all'ampliamento territoriale e quest'anno, oltre al capoluogo Bolzano, ha portato le note del jazz in rifugi e cantine, nelle banche, a Bressanone, Brunico, Merano e in Val Venosta. Uno dei maggiori pregi di questa mastodontica iniziativa, che coinvolge in dieci intense giornate centinaia di artisti, è quello, importantissimo, di far conoscere in Italia nuovi talenti europei. La posizione di frontiera e il bilinguismo rendono l'Altoadige il luogo ideale per svolgere questo fondamentale servizio..." (Vincenzo Fugaldi) |
|
Inserisci un commento
|
© 2000 - 2026 Tutto il materiale pubblicato su Jazzitalia è di esclusiva proprietà dell'autore ed è coperto da Copyright internazionale, pertanto non è consentito alcun utilizzo che non sia preventivamente concordato con chi ne detiene i diritti.
|
Questa pagina è stata visitata 2.469 volte
Data pubblicazione: 25/03/2012

|
|

