|
Il RITMO (e il tempo) si dà come per acquisito naturalmente
anche perché nelle passate età era l'elemento dominante: esso governava la musica
giacché la melodia e l'armonia (e la timbrica sonica) erano in una fase embrionale.
Il ritmo è comunemente avvertito come un elemento musicale inferiore e oltrepassato
in maniera decisiva sin dalla "civilizzata" epoca rinascimentale.
Sarà magari anche per questo e quindi per conseguente presunzione e superficialità
che a tutt'oggi c'è una scarsa consapevolezza e conoscenza (anche tra gli specialisti).
Lo scorrere del tempo (scansione, pulsazione, battiti)
in musica è dato dai valori assoluti delle durate assegnati agli eventi che si susseguono
periodicamente. L'organizzazione degli eventi in unità di durata (con multipli e
sottomultipli) con accentuazioni che ne caratterizzano ulteriormente l'andamento,
spesso raggruppati pure in schemi regolari, crea il ritmo: dopo la numerazione e
la misurazione appunto delle sue ricorrenze qualitative, esso ci fornirà i metri
convenzionali del brano (3/4, 12/8 ecc.) e quindi sarà funzionalmente contenuto
in formali misure quantitative (battute).
La durata e l'interazione tra gli eventi concretano perciò il parametro fondamentale
musicale che è il ritmo in una biunivoca relazione con il TEMPO.
In musica tutto è ritmo e l'evento ritmico materializza, organizzandolo, il tempo;
quindi il ritmo articolando il tempo assoluto ordinario, crea il tempo musicale,
al quale tutto è connesso e pertanto tutti si riferiscono connettendosi necessariamente.
Abbiamo pertanto l'opportunità di concretare esperienze straordinarie: il tempo
musicale è il frutto di una manipolazione del tempo assoluto perciò è una manifestazione
di una realtà trascendente.
Dunque la musica è un modello per l'esplorazione della conoscenza del tempo: un
laboratorio per conseguire modalità temporali non agibili nell'esperienza quotidiana.
La peculiare conducibilità temporale della musica offre delle dimensioni che altrimenti
sarebbero inaccessibili: possiamo realizzare una bolla temporale nella quale entrare
e permanere a nostra volontà.
Il materiale ritmabile di una musica è fornito dalla variazione periodica di una
serie qualsiasi di parametri sonici: sia percussivi/melodici/armonici sia le eventuali
curve dinamiche/timbriche applicate nel micro (singolo suono) e nel macro (cambio
di registro, di strumento, di tonalità).
La musica è scienza delle proporzioni applicate ai suoni; ALTEZZA (acutezza o gravità)
e DURATA sono grandezze in base alle quali si può produrre musica eseguendo delle
scelte dopo averle numerate e misurate: il compositore, per realizzare un'opera,
le mette in relazioni reciproche, coordinandole come su di un diagramma bidimensionale
(spazio e tempo).
Dunque la profonda comprensione di strutture complesse dell'organizzazione musicale
passa attraverso le due operazioni fondamentali della procedura del proporzionare:
numerazione e misurazione. Cogliere le proporzioni mediante l'immaginazione, ordinando
gli eventi passati e anticipando quelli futuri, ci permette di penetrare il senso
totale della musica: dal singolo suono che insieme con altri in successione si costituisce
in ritmo e quindi ricorsivamente in metri e battute, e che dopo diventeranno frasi,
periodi, sezioni (intro, A, B ecc.), e infine appunto il brano nella sua interezza.
Quindi per eseguire correttamente una musica (seppur scritta), c'è bisogno di qualcosa
o qualcuno che ne coordini temporalmente i rapporti: per un'orchestra c'è il direttore,
al quale tutti i musicisti si riferiscono. Per i piccoli gruppi moderni di solito
il compito di tenere "incollati" tutti alle misure musicali (battute) è demandato
al batterista (o in alternativa al bassista), il quale spesso a sua volta ha una
cuffia con un metronomo (il "click") e/o intere sequenze programmate di musica alle
quali riferirsi.
I musicisti sono come fluidi congegni degli orologi: però non misurano il trascorrere
tempo, lo creano. E realizzano così la musica: il mutante cronometro nel quale "immergersi"
poi tutti.
I generi musicali più diffusi come il Pop, il Rock e il Funk-Dance, hanno delle
forme strutturali semplici, brevi e ripetute.
Ci sono alcune condizioni che agevolano il riscontro temporale che consente ai musicisti
(e agli ascoltatori) non solo di procedere insieme con gli altri sincronizzati verticalmente,
ma anche di non smarrire il dispiegarsi del fluire orizzontale che dà il profilo
qualitativo alla struttura.
Infatti, nella stragrande maggioranza dei casi il ritmo è breve, ripetuto e simmetrico:
si ottiene così una specie di CRONOMETRO musicale che orienta e conforta il movimento
in avanti, percependolo pertanto come UNA delle possibili modalità del fluire asettico
e indifferenziato del tempo assoluto. In questa maniera però la peculiarità musicale
di trascendere IL tempo assoluto (ordinario) è in gran parte neutralizzata.
Effettivamente i generi musicali più diffusi come il Pop, il Rock e il Funk-Dance,
hanno delle forme strutturali semplici (brevi e ripetute), all'interno delle quali
ci sono anche delle certezze inequivocabili date da semplici e marcate ricorrenze
di allineamento temporale a cui riferirsi per il controllo della musica che scorre
per eseguirla correttamente.
In questi casi la suddivisione in battute erigerà un simulacro dell'omogeneo divenire
temporale ordinario, all'interno del quale far eventualmente scorrere e dislocare
in parallelo alcune occasioni di singolarità temporali (pertanto non allineate al
resto) procurate da semplici ma sincopate figurazioni ritmiche.
Per la musica New Age è invece invalsa la prassi di non marcare il tempo (similarmente
all'antica musica sacra gregoriana), per non suscitare naturali movimenti indotti
da energia impulsiva ritmica (il contrario di tutte le profane popolari musiche
da ballo*), quindi riferimenti fisici sensuali spontanei che distraggono la concentrazione
per l'elevazione spirituale che consente l'armonia perfetta con il tutto. Questa
staticità temporale insieme con i pochi eventi di connessioni melodici/armonici
rende la musica più spaziale e non costruente "congegni", ma appunto con quei minimi
suoni che si dispiegano, quasi immateriale e fluida: così dovrebbe permettere un'astrazione
e una sublimazione dal bassamente vivere umano, senza pulsazioni e pulsioni.
Ma ci sono brani che troviamo spesso in generi come il Jazz**, il Progressive ecc.,
che sfruttano la peculiarità temporale-ritmica della musica, attenendosi a prassi
sia compositive sia esecutive per conseguire un sostanziale senso di contrazione/dilatazione
e disallineamento temporale tra i vari elementi e derivante iper stratificazione
poliritmica (e talvolta polimetrica).
Questo determina una sospensione del normale fluire o comunque una non definizione
univoca: l'ambiguità è sfruttata per far fluttuare la percezione temporale dell'ascoltatore
che, ritrovandosi senza punti di appoggio, non può far altro che abbandonarsi alla
deriva dell'ondeggiare tumultuoso del mare ritmico. Dunque, all'inverso delle musiche
dei generi più popolari (Pop, Rock e Funk-Dance) ce ne sono invece di programmaticamente
complicate: come per la New Age (e la musica sacra) anche qui c'è una sorta di volontà
di elevazione, ma al contrario della passività qui c'è il desiderio (mediante "eroica"
attività) di superare le enormi difficoltà date dal proporsi di dominare sia intellettualmente
sia operativamente delle "forze" (il tempo) che sono al limite delle possibilità
concesse all'uomo. Questo è un impegno quasi sovrumano per liberarsi dall'influsso
massificante del tempo cronometrico. Che sia quello indifferenziato o che sia ciclico,
la procedura è quella di annullare appunto il tempo facilmente preconizzabile mediante
ritmiche e metriche più complesse e/o stratificate, andando a concretare di solito
delle realtà temporali multiple sovrapposte. A volte addirittura si vogliono esprimere
delle tensioni mediante dissonanze ritmiche. Il rischio è che nello sforzo di intricare
si realizzino talvolta musiche un po' pretestuose: in ogni caso sono sempre da prendere
in considerazione perché si fa comunque della ricerca e sviluppo di una disciplina.
Come per tutte le avanguardie, anche ammesso che l'opera in sé non sia del tutto
valida e creativa (o, con opinabilissimo giudizio, bella), si potrà dopo approfittare
di quest'apertura di sentiero per comporre cose migliori.
Due bravi chitarristi rockfusion illuminati, Brett Garsed e T.J.Helmerich,
hanno pubblicato negli anni '90 due dischi di
musica rock-fusion senza troppe pretese: durante gli assoli scorrazzavano molto
velocemente ma con gusto lungo le loro tastiere "infiammate". Nel
1999 hanno pubblicato l'apprezzabile "Under
the Lash of Gravity": è un disco diverso, più di ricerca perciò ambizioso. In particolare
i brani "Galactic Waterhole" e "State of the Art" sono moderni prototipi di formidabili
complicanze di stratificazioni ritmiche-metriche: il primo più orizzontale, il secondo
più verticale (quindi più dissonante per causa di contemporanei contrasti temporali).
Anche solo come addestramento vale la pena cimentarcisi per aumentare la propria
sensibilità, pertanto conoscenza, tramite esperienza. (A volte l'analisi è più ardua
della sintesi perciò è utilissima.) Sovvertendo tutte le naturali aspettative, non
permettono predizioni e contrastano sia il normale fluire assoluto sia quello relativo
ciclico: nel presente il passato non è memorizzabile e il futuro non è predicibile
per causa di complicatissimi rapporti sonici sia simultanei (verticali) sia in successione
(orizzontali). Il consiglio è di ascoltare i brani senza guardare e seguire la mappa;
ma dopo fatelo!
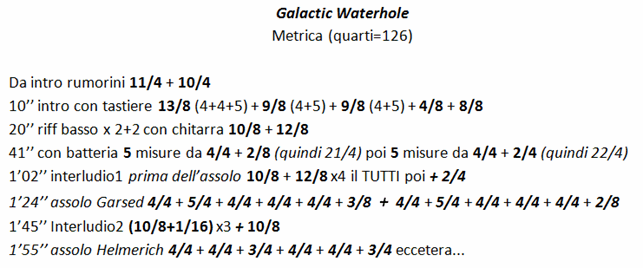
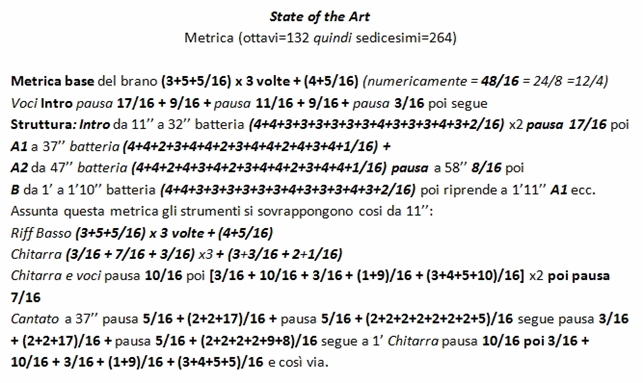
* Caso a sé è la musica afrocubana (malamente detta SALSA), che seppur molto percussiva
e ritmicamente marcata, è caratterizzata dall'ambiguità percettiva dell'UNO delle
misure (inizio), infatti, anche in musiche da ballo commerciali non è facilmente
individuabile, figuriamoci in quelle più creative.
** Il Jazz di solito non ha forme e metri complicati (AABA e 4/4), tuttavia la cosa
più facile è proprio smarrirsi nello scorrere del brano nel tempo; ciò è determinato
dal fattore programmatico di questo genere che è quello di non avere le scansioni
ritmiche regolari per opera di tutti i suoi musicisti fatto salvo il bassista. In
particolare spesso il Jazz ha una base ritmica data dalla batteria non marcata e
non regolare, sostenuta solo da un veloce percotimento di un piatto chiamato ride
(dagli anni quaranta in poi), fraseggi sul rullante e qualche "botta" di grancassa;
il basso va in 4 (walkin' bass). C'è anche la libera e occasionale addizione e sottrazione
degli interventi musicali per opera dei singoli musicisti che forniscono pure dislocazioni
di accenti sincopati alle loro azioni. Insomma, la difficoltà non è data da ritmi
e metri complessi né da strutture lunghe e intricate, ma da sapienti interventi
improvvisati dei musicisti. La bolla di tempo concretata dalla riproduzione dell'intero
brano, è il campo di azione nel quale operare occasionali e transitori e penetranti
interventi di dinamica temporale da parte di solisti che s'immergono e nuotano in
quel fluido divenire: questa è l'ulteriore magia di quelle musiche che sono permeate
dalle improvvisazioni solistiche.
Però il paradosso è che la maggior parte dei solisti (in tutti i generi musicali)
si appoggia sin troppo alla scansione metronomica, anche se non è esplicita (che
aiuta comunque a sincronizzare i musicisti), così si stabiliscono due lati svantaggiosi:
non si sfrutta questa possibilità per elevare il grado di soggettiva stratificazione
temporale, ed è parzialmente neutralizzato anche l'effetto della bolla di tempo.
Si possono imparare sui libri tutte le non semplici nozioni melodiche e armoniche
necessarie per essere in grado di suonare (anche in modo ortodosso) il Jazz, ma
salire su quelle giostre veloci e prive di appigli è per molti una difficoltà insuperabile:
spesso non si riesce di comprendere nemmeno dove sta l'UNO della misura e si cade
rovinosamente dopo poche battute.
Talvolta qualcuno si è divertito di realizzare qualche brano programmaticamente
più complicato: ad esempio "Five" di
Bill Evans
(del ‘56) ha delle metriche e suddivisioni interne non semplici (guarda caso il
disco che lo contiene lo ha chiamato "New Jazz Conceptions"). Nel
1996 è stato pubblicato un intero libro di trascrizioni
di suoi brani (Bill
Evans Fake Book) contenente una scorretta partitura di "Five": l'autore
(Pascal Wetzel) non ha capito dove era posto l'UNO iniziale, da qui tutta una serie
di errori formali...
Per approfondimenti, il libro è disponibile anche presso
www.amazon.it
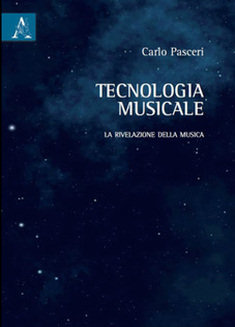
Inserisci un commento
© 2013-2014 Jazzitalia.net - Carlo Pasceri -
Tutti i diritti riservati
|
© 2000 - 2026 Tutto il materiale pubblicato su Jazzitalia è di esclusiva proprietà dell'autore ed è coperto da Copyright internazionale, pertanto non è consentito alcun utilizzo che non sia preventivamente concordato con chi ne detiene i diritti.
|
Questa pagina è stata visitata 2.714 volte
Data pubblicazione: 14/04/2014

|
|

