Il
sassofono è uno strumento cosiddetto ad ancia in quanto deve l'emissione
del suono alla vibrazione di una linguetta recante tale nome posta
sull'imboccatura.
L'ancia, vibrando, mette in movimento la colonna d'aria presente
nello strumento la quale viene variata in lunghezza e portata dal
musicista che agisce sui tasti e sulle chiavi.
Questa si comporta come
una corda di chitarra, ovvero se la colonna d'aria sarà corta (quindi
molti fori aperti) la nota risultante sarà acuta, viceversa se sarà lunga
(quindi molti fori chiusi) la nota risultante sarà grave.
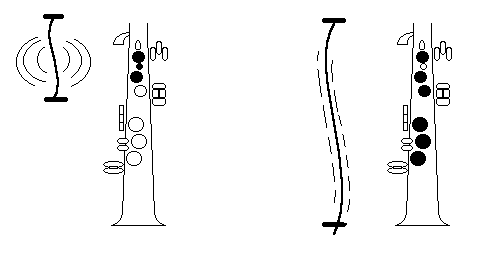
Nota
acuta
Nota grave
Figura 1
Il sassofono è composto da
più componenti assemblati come in figura:

Figura
2
La famiglia dei
sassofoni era composta originariamente da due gruppi di sette strumenti
ognuno di dimensioni diverse.
Uno di questi, ovvero quello che fu concepito da Adolphe
Sax per l'uso in
orchestra era composto da strumenti tagliati nelle tonalità di FA e DO ed
è ormai caduto in disuso.
L'altro gruppo fu creato dall'inventore per l'utilizzo nelle bande
ed è quello che si è affermato fino ai giorni nostri.
I sette sassofoni che lo compongono sono tagliati in MIb e SIb
secondo lo schema sottostante:
| Sopranino |
MIb |
| Soprano |
SIb |
| Alto |
MIb |
| Tenore |
SIb |
| Baritono |
MIb |
| Basso |
SIb |
| Contrabbasso |
MIb |
Dire che i sassofoni Sopranino, Alto, Baritono e Contrabbasso sono
tagliati in Mib significa che suonando la posizione chiamata DO sullo
strumento in realtà noi otterremo una nota che corrisponde in realtà,
per l’appunto, ad un Mib.
Allo stesso modo se suoniamo DO sul Soprano, sul Tenore o sul Basso
otterremo, in realtà, un Sib.
Per cui distinguiamo note "reali", che sono quelle, per
così dire "vere", (nelle quali c’è coerenza tra nome ed
altezza del suono e sono suonate su tutti gli strumenti in DO) dalle
note "d’effetto", che sono quelle suonate sugli strumenti
traspositori, nelle quali non c’è coerenza tra nome e altezza del suono
percepito.
Ad esempio per suonare con un sax Alto un Do "reale" del
Pianoforte, dovremo suonare sul nostro strumento un LA, che si dice quindi
"d’effetto".
Ma allora perché non chiamare le note col loro vero nome?
Fino a un decennio fa c’era una scuola di pensiero, in auge
soprattutto tra i saxofonisti di musica leggera di vecchia scuola (quelli
che io chiamo con grande rispetto "mestieranti"), che
voleva appunto che le note venissero chiamate col loro nome reale, per cui
un LA era un LA anche sul saxofono.
Questo dava dei vantaggi indiscutibili se pensiamo a come si
svolgeva il mestiere del musicista nel dopoguerra, quando ci si trovava a
suonare standards internazionali nei locali, sulle navi o nei grandi
alberghi, in formazioni diverse, cambiando spesso repertorio.
Con questo sistema infatti avendo ogni nota lo stesso nome per
tutti, tutti potevano leggere lo stesso spartito, semplificando molto il
lavoro.
Per fare questo con il sistema traspositore invece bisognava
riscrivere le parti trasponendole debitamente o leggere la parte, ad
esempio, del pianoforte, in chiave di soprano per gli strumenti in Mib o
di contralto per gli strumenti in Sib.
Lo svantaggio di quel sistema era, però, che ci si doveva imparare
praticamente due diteggiature diverse, una per i saxofoni in Mib ed una
per quelli in Sib.
Alcuni musicisti
aggirarono il problema utilizzando il Tenore
in DO, detto anche
C Melody, il quale permetteva di leggere le parti pianistiche mantenendo
la diteggiatura degli altri sassofoni.
In realtà, sin dalle origini, tutti i saxofoni leggono in chiave di
violino, con la stessa diteggiatura, dal Sopranino al Contrabbasso.
E’ chiaro però che se la posizione "DO" d’effetto
sul Tenore è uguale a quella del Soprano o del Basso (avendo tutti e tre
lo stesso taglio di intonazione) la nota risultante sarà sì la stessa ma
posta ad ottave diverse, in virtù della differente dimensione degli
strumenti.
Abbiamo
detto che l’estensione del saxofono nella notazione d’effetto è uguale per
tutti e sette i tagli, ovvero va dal Sib sotto il primo taglio inferiore
al FA# sopra i tre tagli superiori tranne che per il Basso ed il
Contrabbasso che arrivano al FA o in strumenti più vecchi che non hanno la
chiave del FA# acuto.
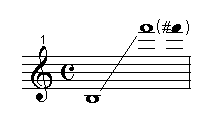 Lo schema sottostante
mostra la relazione esistente tra l’estensione dei sette saxofoni e la
tastiera del pianoforte.
Lo schema sottostante
mostra la relazione esistente tra l’estensione dei sette saxofoni e la
tastiera del pianoforte.
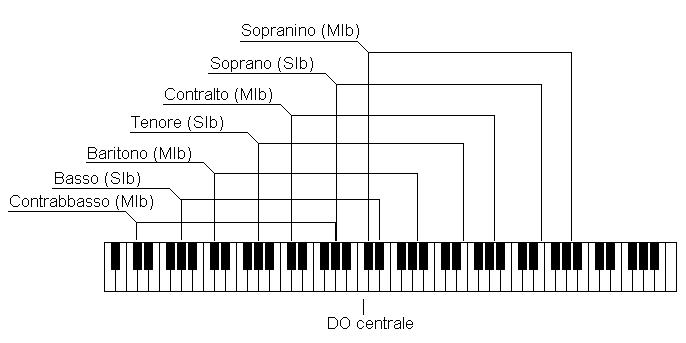
Volendo
semplificare il discorso possiamo dire che, prescindendo dall’altezza
dei suoni, i saxofoni tagliati in Mib per suonare la stessa nota del
pianoforte debbono suonare una sesta sopra o una terza minore sotto (1
tono e ½) (se prescindiamo dall’altezza la nota risultante è la
stessa).
I saxofoni tagliati in Sib debbono invece suonare una seconda
maggiore sopra.
La forma è quella classica, per così dire, "a pipa",
con delle varianti per quanto riguarda il collo, la campana e, ovviamente,
le dimensioni a seconda del taglio di intonazione.
Solamente il sopranino ed il soprano hanno forma diritta, anche se
quest'ultimo viene prodotto da alcune ditte con la forma ricurva dei
fratelli maggiori.
Tutti gli appartenenti alla famiglia hanno però in comune la
concezione costruttiva di base ed i materiali.
La forma è conica, ovvero il tubo aumenta di diametro man mano che
progredisce verso la campana, mentre il materiale costituente è una
lamina, di spessore variabile tra i vari produttori, composta da una lega
di ottone (quindi rame e zinco) con l’aggiunta di piccole parti,
nell'ordine dell' 1-2%, di alluminio, stagno o nichel allo scopo di
prevenire l’insorgenza di crepe.
Il tipo di lega, comunque, non riveste grande importanza nella
determinazione del timbro; a testimonianza di questo è il sax alto "Grafton
Plastic", costruito nel 1953 in Inghilterra ed il cui corpo è
costituito interamente di resina plastica; utilizzato da C.Parker ed
O.Coleman il suo suono è perfettamente allineato con quello dei
saxofoni tradizionali.
Evidentemente ha ragione A. Sax quando afferma, sulla base delle
sue sperimentazioni, che il timbro di uno strumento è determinato
dalle proporzioni della colonna d'aria in esso contenuta e che quindi
materiale e forma sono poco determinanti.
Nonostante ciò tutte le ditte produttrici hanno svolto ricerche
sui materiali , in particolare la statunitense King la quale
introduce sul modello Super 20, prodotto agli inizi degli anni '40, parti
in argento massiccio (il collo e a volte la campana), nel tentativo di
migliorarne il suono (peraltro già notevole).
A proposito del collo questo è oggetto di particolare attenzione
da parte dei progettisti.
Infatti una sua errata costruzione può influenzare pesantemente le
prestazioni dello strumento in termini di qualità del suono o
pregiudicare la facilità di emissione di alcune note.
La qualità della lega riveste invece un certa importanza sotto
l'aspetto costruttivo per cui l'ottone sembra essere il giusto compromesso
tra leggerezza, resistenza, facilità di lavorazione e costo di
produzione.
La finitura esterna varia di molto ma comunque non influenza il
timbro dello strumento.
Abbiamo quindi saxofoni laccati in oro o color oro, argentati,
nichelati, opachi, lucidi,in ottone grezzo (brass), laccati neri, rossi o
bianchi.
Quello che può alterare, seppur impercettibilmente il suono, è il
lucido che viene applicato per proteggere la laccatura, il quale, se
troppo spesso, frena le vibrazioni dello strumento (ma su questo argomento
le opinioni sono abbastanza controverse).
Un aspetto che invece sembra avere una certa influenza è lo
spessore della lamina, questo perché il metallo, in un certo senso, entra
in vibrazione con l'aria in esso contenuta, influenzando così il
contenuto in armoniche del suono prodotto, per cui uno strumento pesante
ha, in linea di massima, un suono più scuro e caldo di uno leggero, che
quindi suonerà più brillante.
Un altro aspetto, questo si veramente determinante, è la
costruzione interna dello strumento.
Parliamo, per esempio, della concezione dei fori : è un
particolare questo sul quale i produttori hanno lavorato molto.
Originariamente, infatti, l’anello sul quale va a chiudere il
tampone era saldato al corpo.
Questo sistema poteva generare imperfezioni o residui di saldatura
in presenza dei quali l’aria in deflusso dava vita a delle
microturbolenze (fig.3a) negative per il timbro e l’intonazione.
In seguito, grazie anche allo sviluppo di appositi utensili
meccanici, venne sviluppata una nuova tecnica per cui oggi i fori vengono
costruiti piegando verso l’esterno la lamina del corpo stesso (fig.3b), eliminando così ogni ostacolo e rendendo
più agevole il calcolo del cubaggio interno dello strumento (particolare
fondamentale riguardo all’intonazione).

A
B
Fig. 3
Parliamo poi dei
tamponi: oltre ad avere la funzione ovvia di chiudere i fori sono molto
importanti perché la loro distanza dai fori stessi, quando sono aperti,
regola il flusso dell’aria in uscita dallo strumento, influenzando così
intonazione e timbro in maniera molto decisa.
Proprio per questo motivo su di essi la Selmer, prima fra
tutte, appose dei dischi di metallo (in seguito di plastica) detti
risonatori che hanno il compito di riflettere il suono in uscita dal foro,
diffondendolo più efficacemente all'esterno.
In generale poi molto importante è il calcolo interno dello strumento,
ovvero il cubaggio e le proporzioni interne
Tutti questi fattori concorrono nel determinare la qualità, le
prestazioni ed il colore di un sassofono (ricordate le armoniche?).
Sul mercato esistono ormai decine di marche e modelli che coprono
un po’ tutte le esigenze stilistiche ed economiche.
Chiariamo subito che lo strumento perfetto non esiste.
Esistono strumenti che, a partire da prestazioni fondamentali che
tutti i musicisti ricercano quali l’intonazione, una certa fluidità
meccanica, l’omogeneità di emissione, offrono un timbro particolare
ovvero il suono ideale alla ricerca del quale tutti dedichiamo il nostro
tempo ed il nostro portafoglio.
Un suono però può essere ideale per me, non per altri : dipende
dal mio gusto, dal tipo di musica che faccio, da cosa voglio esprimere
sullo strumento.
 E’
evidente quindi (facendo una classificazione necessariamente grossolana)
che un musicista classico preferirà, ad esempio, un Buffett o un Buescher
rispetto ad altre marche perché questi gli offrono un suono più
rotondo, secondo lo stile classico, mentre un musicista di Jazz o Rock
probabilmente preferirà un Selmer o un King per i motivi
opposti. E’
evidente quindi (facendo una classificazione necessariamente grossolana)
che un musicista classico preferirà, ad esempio, un Buffett o un Buescher
rispetto ad altre marche perché questi gli offrono un suono più
rotondo, secondo lo stile classico, mentre un musicista di Jazz o Rock
probabilmente preferirà un Selmer o un King per i motivi
opposti.
Questo non è, ovviamente un dato assoluto, perché, come vedremo
in seguito, il timbro viene definito in buona parte dall’esecutore in
virtù del tipo di imboccatura, dell’ancia usata, del modo di imboccare
per cui non e impossibile ottenere un suono tondo da un Conn, per
esempio, usando l’imboccatura appropriata.
A tal proposito però c’è da considerare che è più facile
rendere scuro uno strumento brillante che il contrario.
Lo strumento che sembra essere più versatile da questo punto di
vista è il Selmer, in particolare il modello Mark VI, prodotto dal
1954 al 1973, tant’è vero che è il più diffuso tra i professionisti
di tutto il mondo per le sue qualità e, nonostante sia uscito
evidentemente fuori produzione, è tuttora molto ricercato e
commercializzato sul mercato dell’usato a cifre che spesso superano i 6.000.000
di lire.
Per quel che riguarda i modelli ancora in produzione ottimo il Selmer
Superaction, con notevoli pregi di elasticità e facilità di
emissione.
Notevole anche Yamaha che nel suo modello top ha raggiunto
un livello notevole di prestazioni mentre sui modelli da studio spicca un
buon rapporto qualità-prezzo.
Per il principiante ovviamente vi sono meno problemi.
Intorno al 1.500.000-1.700.000 si trovano strumenti
semiprofessionali con i quali si può studiare per lungo tempo prima che
si senta l’esigenza di qualcosa di veramente professionale.
Le marche principali sono la già citata Yamaha, Grassi, Borgani
(italiane queste due), Jupiter (Coreana).
Nel caso ci si rivolga all’usato attenzione: a prescindere
dal suono e dalla meccanica una cosa è fondamentale, e cioè che lo
strumento chiuda bene.
Se ciò non accade creerà grossi problemi all’allievo (e
al suo insegnante) per l’emissione, soprattutto delle note basse.
Adesso: considerando che questa parte dello strumento è già
problematica per chi comincia, appare evidente come il sommarsi dei due
problemi possa creare nello studente sfiducia nei propri mezzi e nelle
proprie possibilità.
|

