|
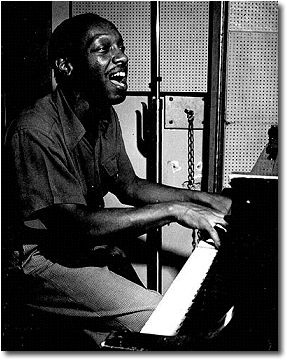 Salve
amici, come avrete intuito dal titolo di questa lezione vi parlerò dell'armonizzazione
a cinque parti reali, naturalmente immaginando che ad accompagnare la nostra
"sezione di sax" (sezione di sax di una Big Band) ci sia una batteria ed
un contrabbasso. Salve
amici, come avrete intuito dal titolo di questa lezione vi parlerò dell'armonizzazione
a cinque parti reali, naturalmente immaginando che ad accompagnare la nostra
"sezione di sax" (sezione di sax di una Big Band) ci sia una batteria ed
un contrabbasso.
Ci tengo innanzi tutto a precisare che purtroppo non tutte le melodie si
prestano a tale trattamento, probabilmente infatti molte tecniche di arrangiamento
sono nate proprio dall'esigenza di trovare soluzioni che di volta in volta facessero
al caso di quella melodia, di quelle armonie, di quella struttura ed altro ancora.
Comunque tornando alla nostra armonizzazione il brano che ho scelto è uno
standard famosissimo di Tadd Dameron:
Lady Bird ( ). ).
Realizzeremo l'armonizzazione di questo tema in modo molto chiaro e semplice
immaginando innanzi tutto di avere i nostri 5 sax (due contralti, due tenori, un
baritono):
- la prima voce (il canto) resterà ovviamente invariata ed affidata
al primo contralto
- la seconda sarà a distanza di terza discendente dalla prima,
la terza a distanza di terza discendente dalla seconda, e la
quarta a distanza di terza discendente dalla terza. Naturalmente
le terze saranno maggiori e minori a seconda dell'accordo di cui fanno parte.
Tra l'altro lo scopo principale di questa armonizzazione è proprio quello di
far stare le parti a distanza di terza tra di loro fatta eccezione per il
baritono che invece sarà sempre all'ottava con la melodia per almeno
tre buoni motivi:
- per dare maggiore forza, compattezza a tutto il blocco
- per marcare ulteriormente la melodia del brano
- per dare tensione poichè a seconda dei casi, come vedremo negli
esempi, viene sempre a trovarsi o a distanza di seconda maggiore o a distanza
di semitono dalla quarta voce (secondo tenore), creando appunto una efficacissima
e splendida tensione
ES. MUSICALE n. 1 (armonizzazione della cinque parti su un solo pentagramma)
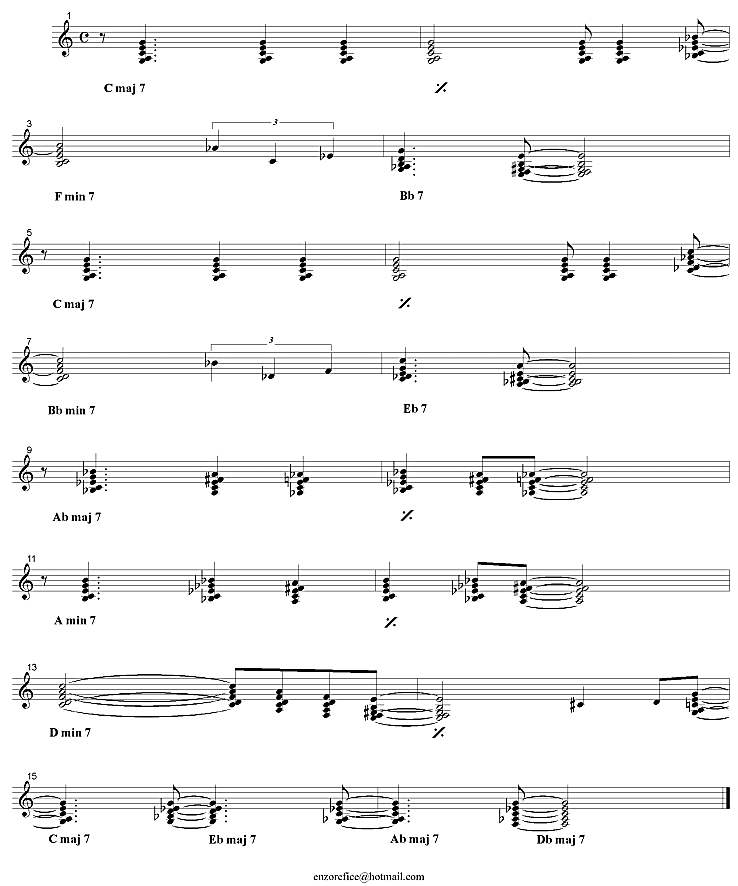
In questa armonizzazione dal punto di vista ritmico mi sono attenuto
fedelmente alla partitura originale tranne nella parte finale dove ho dato un leggero
movimento ritmico al "sol" semiminima legata, accenti marcati ulteriormente
dai quattro accordi finali del brano. Cosa molto importante è vedere come le tensioni
si verifichino, specie nella prima parte della nostra armonizzazione, tra la quarta
(secondo tenore) e la quinta (baritono) voce.
N.B.: nei casi di battute come la n. 3 la n. 7, in cui si legge
chiaramente una sola voce i sassofoni verranno distribuiti secondo lo schema che
segue:
| primo
alto, secondo alto, primo tenore: |
voce scritta |
| secondo
tenore e baritono: |
ottava sotto |
Analizziamo ora in modo più accurato come si è proceduto per l'armonizzazione
delle singole note della melodia e soffermiamoci sull'ES. MUSICALE n. 2 (cinque
diverse armonizzazioni per il nostro tema)
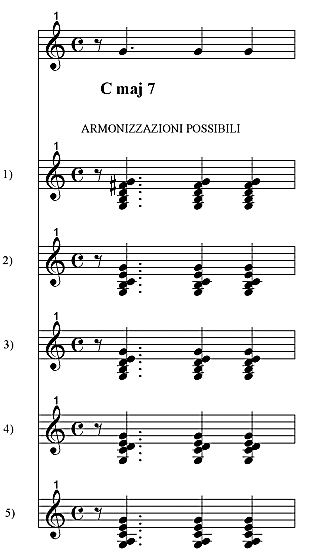
Non analizzerò l'armonizzazione di tutte le singole note del tema poichè
il tipo di armonizzazione è sempre uguale, mi limiterò a spiegare le eccezioni alla
nostra piccola regola di armonizzare un tema
Leggendo chiaramente gli esempi notiamo che tutte le voci sono sempre comprese
nell'ambito di un'ottava e che, a seconda dei casi, abbiamo sempre due voci che
si trovano o a distanza di semitono o a distanza di tono, poi osserviamo che:
- nell'esempio n. 2.1 la tensione (fa# - sol) si trova tra la prima e la seconda
voce. Ciò oltre ad essere poco efficace risulta anche piuttosto brutto al nostro
orecchio, in realtà ci sembra quasi stonato. Si consiglia di evitare sempre
dissonanze e tensioni tra la prime due voci, specie se la prima fa parte di
una linea melodica e tematica.
- nell'esempio n. 2.2 la tensione (si - do) si trova tra la terza e la quarta
voce. Questa armonizzazione non è male però funziona decisamente meglio su tempi
deboli, note di passaggio e via dicendo.
- nell'esempio n. 2.3 la tensione (re - mi) si trova tra la seconda e la terza
voce ma a differenza dell'esempio n. 1 è migliore, infatti la prima voce è a
distanza di terza dalla voce più vicina e non si avvertono stonature.
- nell' esempio n. 2.4 la tensione (do - re - mi) è doppia, abbiamo infatti
la seconda, la terza e la quarta voce a distanza di tono l'una dall'altra. Questa
soluzione è poco efficace in fase tematica ma può essere sfruttabile come effetto.
- nell'esempio n. 2.5 la tensione (sol - la) si trova tra la quarta e la quinta
voce. Questa è senza dubbio la migliore poichè innanzi tutto le altre quattro
voci sono a distanza di terza (vedi regola generale) e poi quando la tensione
è in basso (nel voicing generale dell'accordo) il tutto risulta estremamente
chiaro all'orecchio. Quest'ultima armonizzazione è quella che ho utilizzato
per la maggior parte della melodia di questo brano.
Andando avanti nell'analisi dell'armonizzazione del brano notiamo che:
(battuta 9 - secondo accordo; b. 11 - terzo accordo) le terze non sono più ordinate
secondo il nostro schema. Infatti troviamo prima un accordo dim. Questo accordo
(essendo disposto naturalmente per terze minori) è perfetto già di suo.
ES. MUSICALE n. 3 (accordo diminuito)

Questa armonizzazione è dettata dall'esigenza armonica della melodia. Trovarla
su un tempo forte non sarebbe stata gradevolissima ma sul tempo debole (dove la
troviamo) funziona bene.
Poi abbiamo un'armonizzazione in cui la dissonanza viene a trovarsi tra la
prima e la seconda voce (b. 9 - terzo accordo; b. 10 - terzo accordo).
ES. MUSICALE n. 4
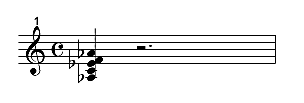
Questa armonizzazione è dettata dall'esigenza armonica della melodia. Su
un tempo forte non sarebbe stata gradevolissima ma sul tempo debole (dove la troviamo)
va magnificamente bene
Molti di voi si staranno chiedendo, come mai sull'armonia Amin7 (b. 12 -
terzo accordo) abbiamo un'armonizzazione con un accordo diminuito?
Beh in realtà tutto ciò è consentito dal fatto che la funzione armonica di
quell'accordo è di D7 (che naturalmente non modula ma diventa II° della tonalità
di DO) di conseguenza funziona bene.
Un'altra piccolissima eccezione la troviamo a (b. 13) infatti ciò che avviene
al primo voicing di Dmin7 non è altro che un drop (il drop è un po' come un rivolto
nella musica colta, vuol dire mettere all'ottava sotto, o sopra, la voce più alta
mantenendo le stesse note del voicing).
Infine altra piccola eccezione fanno i tre accordi finali dove la dissonanza
viene a trovarsi prima tra la seconda e la terza voce (b. 15 - secondo accordo),
poi tra la quarta e la quinta voce (b. 15 - terzo accordo). Ciò avviene per una
semplice volontà di voler usare un legame armonico tra questi accordi, infatti come
si può notare le parti si muovono ben poco. L'ultimo accordo invece (b. 16 - secondo
accordo) è un Dbmaj7 disposto integralmente in ordine di terze, mancante solo della
fondamentale (alla quale provvederà opportunamente il contrabbasso). Ciò al fine
di ottenere un ultimo accordo chiaro, ben definito e particolarmente ricco.
Chi volesse approfondire questo discorso può richiedermi dispense, esercizi
ed altro materiale di lavoro scrivendo al mio indirizzo di posta elettronica
info@enzorefice.it.
Beh ragazzi io spero di essere stato sufficientemente chiaro ed esauriente,
vi auguro un ottimo lavoro con le vostre armonizzazioni...alla prossima!!!
Inserisci un commento
© 2000 - 2001 Jazzitalia.net
- Enzo Orefice - Tutti i diritti riservati
|
© 2000 - 2026 Tutto il materiale pubblicato su Jazzitalia è di esclusiva proprietà dell'autore ed è coperto da Copyright internazionale, pertanto non è consentito alcun utilizzo che non sia preventivamente concordato con chi ne detiene i diritti.
|
Questa pagina è stata visitata 60.462 volte
Data pubblicazione: 10/03/2001

|
|

