|
 Nel
ritmo è insito il concetto di movimento, e ben sappiamo quanto questo sia
importante soprattutto nella musica etnica, basti pensare – allargando un po'
l'angolo visuale – al legame tra quest'ultima e la danza. Vediamo allora per
prima cosa come si "muove" il surdo nella musica brasiliana. Nel
ritmo è insito il concetto di movimento, e ben sappiamo quanto questo sia
importante soprattutto nella musica etnica, basti pensare – allargando un po'
l'angolo visuale – al legame tra quest'ultima e la danza. Vediamo allora per
prima cosa come si "muove" il surdo nella musica brasiliana.
 Gli
strumenti sono i mezzi attraverso i quali noi esprimiamo i suoni, i quali, a
loro volta, sono prodotti dalla vibrazione di corpi elastici e, per quanto ci
riguarda, essenzialmente da membrane. Il SURDO, nell'ambito della musica
percussiva brasiliana è un po' come le fondamenta di un grattacielo che si va
piano piano a costruire. Gli
strumenti sono i mezzi attraverso i quali noi esprimiamo i suoni, i quali, a
loro volta, sono prodotti dalla vibrazione di corpi elastici e, per quanto ci
riguarda, essenzialmente da membrane. Il SURDO, nell'ambito della musica
percussiva brasiliana è un po' come le fondamenta di un grattacielo che si va
piano piano a costruire.
Parlando del surdo indichiamo più precisamente una famiglia di tamburi
di diverse dimensioni e diversa accordatura, a seconda dei compiti che
vengono assegnati musicalmente a ciascuno di essi. Generalmente il surdo ha le
seguenti dimensioni: diametro 60 cm. il più grave come sonorità, 55 cm.
medio-grave, usato come risposta e 50 cm. il più piccolo, per il "groove".
 Il
surdo ha due pelli, una battente e una risonante, tenute da cerchi e
tiranti lunghi che assicurano l'assemblaggio dello strumento; viene sospeso
grazie a una cinghia che passa attorno al collo e al corpo e si suona con
un battente in una mano, mentre l'altra è libera. Il
surdo ha due pelli, una battente e una risonante, tenute da cerchi e
tiranti lunghi che assicurano l'assemblaggio dello strumento; viene sospeso
grazie a una cinghia che passa attorno al collo e al corpo e si suona con
un battente in una mano, mentre l'altra è libera.
 Musicalmente
dobbiamo pensare questi suoni bassi come se fossero dati in risposta a una
partenza: quindi il 1° esercizio che vi propongo serve solo a capire su
quali movimenti suona il tamburo più grave, cioè sul tempo forte che nel samba è
rappresentato dal II e IV movimento. Scriverò tutti gli esercizi
considerando una battuta di quattro movimenti, quindi in 4/4. A questo
proposito, molti allievi e colleghi mi chiedono spesso se il samba, ovvero il
ritmo più rappresentativo della musica brasiliana, è in 2 o 4 movimenti. Per ora
limitiamoci a ripetere che l'importante nella musica è avere le idee chiare, e
lasciamo a chi di dovere le disquisizioni teoriche: dalle combinazioni dei vari
strumenti, capiremo qual è il senso compiuto del ritmo. In fondo è importante
stabilire delle regole, delle convenzioni, ma soprattutto questo ci deve portare
a suonare!! Musicalmente
dobbiamo pensare questi suoni bassi come se fossero dati in risposta a una
partenza: quindi il 1° esercizio che vi propongo serve solo a capire su
quali movimenti suona il tamburo più grave, cioè sul tempo forte che nel samba è
rappresentato dal II e IV movimento. Scriverò tutti gli esercizi
considerando una battuta di quattro movimenti, quindi in 4/4. A questo
proposito, molti allievi e colleghi mi chiedono spesso se il samba, ovvero il
ritmo più rappresentativo della musica brasiliana, è in 2 o 4 movimenti. Per ora
limitiamoci a ripetere che l'importante nella musica è avere le idee chiare, e
lasciamo a chi di dovere le disquisizioni teoriche: dalle combinazioni dei vari
strumenti, capiremo qual è il senso compiuto del ritmo. In fondo è importante
stabilire delle regole, delle convenzioni, ma soprattutto questo ci deve portare
a suonare!!
Allora, con il segno
+
indicheremo un suono chiuso,
ottenuto con la mano battente che esercita una pressione sul tamburo, oppure una
sordina della mano sinistra (libera).
Con il segno o
indicheremo invece un suono aperto (open tone), ottenuto con la mano battente
colpendo e poi lasciando suonare il tamburo, oppure con la mano sinistra libera,
per aiutare la sonorità della mano battente. Eseguiamo ora anche l'esercizio
n. 2 usando solo la mano battente: quindi suono chiuso – aperto – chiuso –
aperto e così di seguito.
Fatta un po' di pratica con questi esercizi, passiamo al n. 3.
Iniziamo a coordinare entrambe le mani, la sinistra sul I e III
movimento, la destra sul II e sul IV. La figurazione con il punto
ci aiuta a dare conseguenza ritmica all'esercizio.
Così anche per l'esercizio n. 4, con la variante di una
figurazione un po' diversa sul IV movimento. Ripetete più volte questi
esercizi per prendere confidenza aritmicamente e con lo strumento.
L'esercizio n. 5 serve come figurazione per dare senso compiuto a
una frase ritmica. Ricordatevi di rispettare assolutamente il suono chiuso e
aperto del surdo, così come indicato nell'esercizio.
Nell'esercizio n. 6 finalmente arriviamo alla diteggiatura per
suonare lo strumento. Lo starter è preceduto da un suono sul levare del IV
movimento (anacrusi). Esercitatevi molto su questo esercizio e combinatelo
con quelli precedenti.
Voglio ora aggiungere due esercizi, il n. 7 e il n. 8, che
rappresentano una diteggiatura quasi solistica del tamburo; spero che questo
serva anche per divertirvi con lo strumento. Per eseguirli correttamente
dobbiamo aggiungere un altro colpo che indicheremo col segno
x,
eseguito con il dorso della bacchetta battente sull'estremità del cerchio della
pelle del surdo, ottenendo così una sonorità metallica.
Nell'esercizio n. 7 questo suono cade proprio sulla suddivisione
in levare di ogni movimento, che è un accento caratteristico anche di altri
strumenti; quindi per realizzarlo bisogna pensare a una divisione in ottavi
della mano destra.
Nel n. 8 bisogna invece pensare a una suddivisione in sedicesimi
della mano destra, poiché inseriamo due colpi sull'estremità del bordo della
pelle. Leggete attentamente l'esercizio come è scritto, ma soprattutto suonate
molto lentamente la coordinazione e l'esercizio vi risulterà facile e intuitivo.
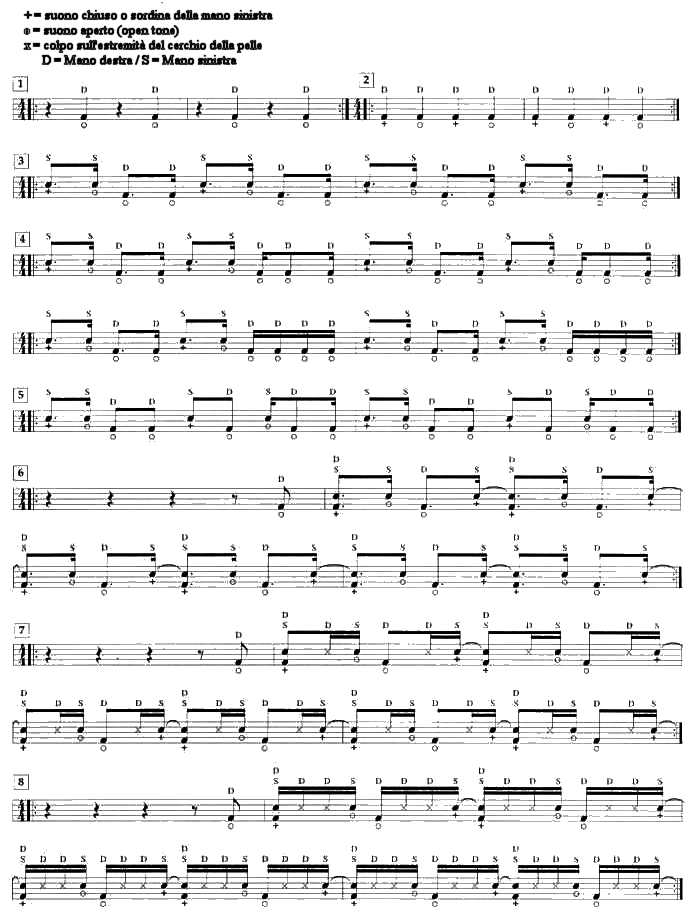
Per
completare questo iniziale approccio al surdo, bisogna aggiungere che i
surdi spesso si "muovono", ossia suonano anche sul I e III
movimento di una misura; ciò significa che è come se avessimo su ognuno dei 4
movimenti un suono aperto, ma di differente intonazione (determinata, come
dicevo prima, anche dalla diversa dimensione del surdo). La diteggiatura dello
strumento rimane quella spiegata negli esercizi base, ma ciascun surdo suonerà
sul movimento assegnatogli.
Salvo eccezioni, il suono più grave rimarrà sul II e IV
movimento. Tutto questo succede soprattutto quando molti tamburi suonano insieme
e si è in presenza di un vero e proprio ensemble percussivo: tutti i suoni
aperti, indipendentemente dalla loro altezza, servono per dare una pulsazione
più continua.
In questo insieme (Batucada) viene assegnato a un surdo il compito
di suonare in mezzo a questi suoni aperti, con una diversa altezza di suono e
con delle figurazioni molto sincopate.
Queste figurazioni vengono eseguite mantenendo i primi due surdi "fermi"
sui rispettivi movimenti. Ecco allora la combinazione, nella quale il III
suono viene inserito in mezzo ai primi due, ma è solo indicativo: in realtà è
importante che sia un suono diverso, talvolta più basso ancora e in alcuni casi
anche più acuto. Dipende molto dal gusto e dalle caratteristiche generali che si
vogliono dare all'insieme.
Quanto scritto in questa combinazione serve solo per analizzare in poco
spazio alcuni movimenti caratteristici che questi tamburi possono eseguire.
Naturalmente in una composizione il risultato è diverso. Come potete vedere,
nella III e IV misura il terzo surdo comincia ad "entrare"
fra gli altri due suoni e nella V e VI vengono utilizzate
figurazioni sincopate d'effetto, nella VII ancora figure di presenza
ritmica, e così di seguito vengono combinate tra loro. Torneremo a parlare dei
surdi, presentando il repinique (il più piccolo della famiglia dei surdi)
e analizzeremo ulteriormente il meraviglioso linguaggio di un insieme
percussivo.
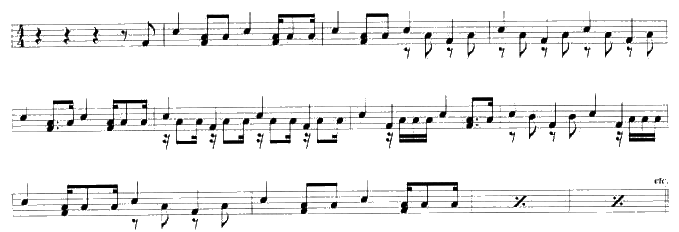

Stefano Rossini Batuque Percussion
il nuovo CD di Stefano
Rossini,
realizzato esclusivamente con l'ausilio delle percussioni

Inserisci un commento
©
2001, 2002 Jazzitalia.net - Stefano Rossini - Tutti i diritti riservati
|
© 2000 - 2026 Tutto il materiale pubblicato su Jazzitalia è di esclusiva proprietà dell'autore ed è coperto da Copyright internazionale, pertanto non è consentito alcun utilizzo che non sia preventivamente concordato con chi ne detiene i diritti.
|
Questa pagina è stata visitata 23.622 volte
Data pubblicazione: 31/03/2002

|
|

