|
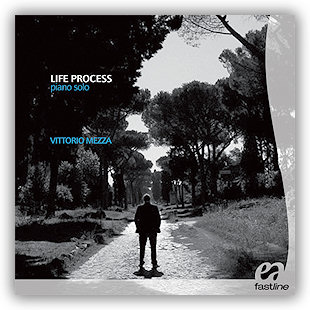
Quattro chiacchiere con Vittorio Mezza
A cura di Alceste Ayroldi

Caro Vittorio, sembra che dopo un po' sia d'obbligo per un pianista approdare
ad un lavoro in solitudine. Da quanto tempo aveva meditato questo importante passo?
Debbo dire che è stata una decisione piuttosto naturale, ho solo atteso che maturasse
il tempo giusto sia a livello artistico che come momento di pausa tra gli impegni
lavorativi poiché, quando si affronta la sfida del pianoforte solo, secondo me,
è necessario ritagliarsi un periodo per stare da soli il più possibile, prima con
se stessi e poi con lo strumento; periodo, il mio, piuttosto delicato - anche a
causa della gravissima situazione socio-economica generale con ripercussioni enormi
sul mondo artistico –, per cui Life Process rappresenta in fondo l'emblema
di una forte e necessaria reazione a tutto questo.
Si riferisce a questa scelta il titolo dell'album, Life Process?
Il titolo è legato alla musica come processo di vita: l'arte, la vita, in fondo
non sono la stessa cosa? Vi è una continua compenetrazione tra le due dimensioni
che, a certi livelli, è imprescindibile e forse irreversibile.
In fase di esecuzione (e, quindi, di registrazione) quanta libertà c'è e quanto
di preordinato?
Per quanto concerne i miei brani ho definito la melodia con, al di sotto, le sigle
internazionali degli accordi (come si fa di solito per gli standards). Non mi piace
scrivere tutto – il jazz è una musica audiotattile -, per cui è come se volessi
preservare il piacere sotteso che regala la verve iniziale di un nuovo flusso musicale;
preferisco piuttosto fissare delle ancore che tracciano un possibile percorso e
immaginare a priori il pensiero che lega ben saldo ogni singolo brano; in questo
senso c'è un che di preordinato. In alcuni punti, infatti, ho individuato dei passaggi
di connessione strutturali - armonici, melodici, ritmici o timbrici - un po' più
definiti, come avviene ad esempio per le code o gli intro o
per alcune sezioni. Come scrivo nel mio libro Nuovi Percorsi Improvvisativi –
Tecniche Avanzate Pentatoniche (Ed. Libreria Univeristaria.it), «gli accordi
sono solo il simbolo di una realtà nascosta», siamo noi poi a definirne i contorni
di senso più o meno sfumati.
Non ha di certo abbandonato il concetto di ritmo, visto che la sua mano sinistra
spesso appare percussiva o, come ne "I sorrisi delle donne", addirittura emulare
la linea di basso…
Infatti, mi piace molto usare la mano sinistra scambiandola ritmicamente,
armonicamente o melodicamente con la destra, affidandole delle linee che magari
normalmente sarebbero state appannaggio di un altro strumento. Inoltre, anche quando
non suono su un tempo piuttosto esplicito (regolare o rigido per intendersi) - mi
piace conferire una certa profondità del ritmo armonico, cercando un senso ritmico
relativo anche solo all'articolazione delle singole frasi.
Così come si ascoltano i suoi studi accademici classici e The Way After ne
sembra lo specchio…
Sì. Quando si è da soli col pianoforte, ci si trova davanti ad un'intera orchestra
da ben calibrare e sfruttare in un'infinita gamma di parametri e suoni che sono
lì a disposizione per essere dosati e strutturare la musica; non potendosi appoggiare
a nessun altro – si è come nudi -, tutto dipende solo ed esclusivamente da se stessi
ed è necessario il controllo e il dominio totale del suono, per cui viene fuori
l'esperienza e la parte più vera di ognuno per ‘piegare' lo strumento.
A tal proposito le è mai stato rimproverato (da qualche finto perbenista del
jazz) di avere un tocco troppo classico?
Credo di no. E' un problema che avverto poco poiché, quando si parla di improvvisazione,
ognuno cerca la massima sintesi delle proprie esperienze di studio e di vita, la
coerenza, la responsabilità e il ‘peso' giusto per ogni nota: il modo con cui questo
avviene è già la conferma di un tentativo di autenticità. Del resto oggi il jazz
si estende oltre ogni confine essendo aperto a tanti altri linguaggi e, seppur con
la necessità di mantenere una propria matrice per distinguersi, diventa una sorta
di global jazz.
Quale è il fil rouge del disco?
Sicuramente la libertà creativa e la ricerca insieme di un senso di unitarietà e
coerenza da una parte e di varietà e balance dall'altra, sia che si tratti
degli standards che di composizioni originali.
Cinque brani autografi e cinque omaggi: a Ellington con Caravan,
a Monk con Well You Needn't?, a Coltrane con Mr. P.C., ad uno standard immarcescibile
quale è On Green Dolphin Street e a Pino Daniele con Quando. Ora,
capisco perfettamente l'amore per i primi, ma mi sfugge il nesso con Pino Daniele:
qual è?
Quando è un brano a me caro poiché sin dal primo ascolto (legato al film
di Troisi del '91, Pensavo fosse amore..
invece era un calesse) mi ha profondamente affascinato e, inoltre, rimane tra
le composizioni più significative di Pino Daniele. Anche se non nasce come uno standard
nel senso stretto del termine, forse ne ho intravisto il percorso strumentale dell'autore
nella sua strutturazione generale. La sfida e la voglia poi, di riuscire ad interpretarlo
nella maniera più personale senza ‘sfilacciarlo' troppo – preservandone certamente
alcuni tratti somatici -, sono state per me di grande stimolo; quindi ho cercato
di trattarlo come un vera e propria song traendo spunto dalla sua nuda bellezza
armonica e melodica e cercando di coglierne e svilupparne la linea di senso originale,
e chissà che tutto questo non arrivi!
Chi è stato il suo mentore o, comunque, chi o cosa l'ha condotta verso la
musica e il jazz in particolare?
Forse non c'è un vero e proprio mentore, ma debbo dire di aver incontrato alcune
persone interessanti e preziose per il mio percorso formativo come
Dave Liebman,
Paolo Damiani,
Fabio Jegher, Stefano Battaglia con i corsi per trio jazz a Siena,
gli insegnanti ai corsi di Umbria Jazz,
Dino Massa
a Pomigliano, colgo l'occasione per ringraziarle.
Mi ha colpito nel leggere le sue note biografiche che ha svolto – e svolge
– per alcuni programmi televisivi di successo il ruolo di consulente musicale. In
pratica, di cosa si occupa? Cosa fa un consulente musicale televisivo?
Il lavoro è piuttosto flessibile, dipende ogni volta dal tipo di produzione che
si affronta e, a mio avviso - variabile quantomeno incalcolabile -, dalle persone
con cui si ha a che fare. Diciamo che di base riguarda: la scelta e i tagli delle
musiche e la cura del suono di un programma televisivo (diverso se c'è un'orchestra
dal vivo, se si tratta di un talk o di un gioco televisivo...); la parte burocratica
sulle competenze di ciò che è andato in onda e la cura della parte video di un programma,
quando cioè le telecamere sono strettamente associate alla musica (in special modo
per i concerti).
Ha pubblicato anche alcuni libri di didattica. Lei ritiene sia utile insegnare
il jazz, oppure è solo una perdita di tempo? E, nel caso in cui fosse utile, sono
ben strutturati i nostri Conservatori?
Credo che sia sicuramente utile e stimolante riuscire a trasmettere la propria esperienza,
le motivazioni, il proprio ‘senso‘ del jazz: una parte di questa jazz può essere
insegnata, soprattutto per quanto concerne gli elementi strutturali di un linguaggio
e il tipo di approccio iniziale, un'altra parte sarà appresa dall'ascolto dei dischi
e solo dai musicisti più bravi con i quali si interagisce; infine, da un certo momento
in poi si è come ‘a largo': soltanto il musicista potrà, attraverso le proprie scelte,
le motivazioni giuste, uno spiccato senso di responsabilità e credendo pienamente
nel proprio lavoro, trovare la forza per andare avanti ed evolversi, tracciando
la propria rotta.
Quale è l'approccio dei giovani verso il jazz? E quanto è cambiato il rapporto
con la musica nell'universo giovanile nel tempo?
Oggi, in ogni ambito, abbiamo un incremento notevole delle possibilità di accesso
alle informazioni con una velocità inimmaginabile un tempo ma, di contro, questa
vastità – come ho già accennato altre volte – può trasformarsi nella paradossale
perdita di ogni riferimento. Senz'altro comunque, l'approccio dei giovani è più
stimolante e globale rispetto al passato. Infine, va considerato il difficile contesto
storico che stiamo attraversando che, da una parte, può generare gli stimoli giusti
per proiettarci lontano da questa situazione attraverso la ricerca di strade artistiche
nuove mentre, dall'altra, può dar luogo ad una sorta di senso di solitudine antropologica
– a livello socio-istituzionale - in cui va ad articolarsi una parte cospicua della
sfera artistica.
Leggo nelle sue note biografiche anche un'ampia militanza – e di particolare
prestigio e interesse – all'estero. Ha mai pensato di abbandonare definitivamente
l'Italia?
Bella domanda. Sì, soprattutto negli ultimi due anni. Sono stato diverse volte all'estero,
ho visto realtà molto lontane dalle nostre - forse meno ‘lente' - e spesso migliori
- a livello di qualità della vita e dal punto di vista economico o dei servizi sociali
-, nonostante effettivamente la crisi globale non risparmi proprio nessuno. Ma vivere
stabilmente in un altro Paese sarebbe una scelta difficile per me poiché, per quanto
sia precario – caratteristica questa ontologica alla professione musica -, in fondo,
credo di aver costruito (e di continuare a farlo) un minimo di carriera. Le racconto
brevemente alcune sensazioni contrastanti che ho avuto, ad esempio, nel mio periodo
in Germania, l'anno scorso. Mi sono sentito molto italiano – forse troppo –, avvolto
nel fascino della bellezza grigia e multiculturale e cangiante di Berlino, riscontrando
sicuramente una realtà sociale molto più funzionante della nostra, a favore delle
reali esigenze del cittadino e dell'ambiente ma dove - che ironia! -, sembra che
i migliori prodotti continuino ad essere sempre quelli italiani: dalle automobili,
alla cucina, all'abbigliamento etc. etc. A mio avviso, attualmente, a meno che non
si creino presupposti tali da rendere inevitabile l'espatrio, trovo più plausibile
sfruttare le maggiori possibilità di collegamenti che abbiamo (soprattutto in Europa)
e magari trascorrere brevi periodi all'estero per concerti o aggiornamenti, piuttosto
che iniziare tutto completamente da capo.
E, altra menzione che mi intriga è che il suo precedente disco "Vittorio
Mezza Trio" (Abeat) sia stato selezionato tra i migliori dischi jazz per la
diffusione ad alta quota a bordo degli Airbus A320 Special della compagnia aerea
Alitalia: una bella soddisfazione, anche per il fatto che l'utenza non è di jazzofili.
Come è riuscito a convincere un pubblico, sostanzialmente, difficile?
Davvero non lo so, ma son contento. Forse questo testimonia la continua ricerca
di un senso di trasversalità che a volte riesco a rendere sia nelle mie composizioni
che nel linguaggio più in generale.
Qual è l'attuale playlist di Vittorio Mezza?
E' una domanda non facile perché per lavoro - alla Rai – sono quasi costretto ad
ascoltare quotidianamente le musiche più svariate, poi debbo dedicarmi all'insegnamento
e, nel tempo che rimane, cerco di studiare, oltre alle faccende della vita etc.
etc. Diciamo che sono aperto all'ascolto di qualsiasi musica purché sia di qualità
e mi stimoli per qualche sua caratteristica peculiare.
Cosa è scritto nell'agenda di Vittorio Mezza?
Alla fine del mese di Maggio finirò il programma di cui mi sto occupando alla Rai,
poi continuerò con le lezioni al Conservatorio di Reggio Calabria; a fine Giugno
dovrei iniziare un progetto con il saxofonista tedesco David Milzow e, dopo l'estate,
ci sarà un piccolo tour in Africa.
Inserisci un commento
|
© 2000 - 2026 Tutto il materiale pubblicato su Jazzitalia è di esclusiva proprietà dell'autore ed è coperto da Copyright internazionale, pertanto non è consentito alcun utilizzo che non sia preventivamente concordato con chi ne detiene i diritti.
|
Questa pagina è stata visitata 2.039 volte
Data pubblicazione: 27/05/2012

|
|

