|
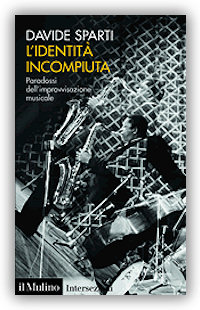
Davide Sparti
L'identità incompiuta. Paradossi dell'improvvisazione
musicale
Il Mulino, 2010
Proseguendo un lavoro iniziato qualche anno addietro con Suoni
inauditi. L'improvvisazione nel jazz e nella vita quotidiana (2005)
Davide Sparti, professore associato nella Facoltà di Lettere e filosofia
dell'Università di Siena, torna a occuparsi di jazz coniugando i termini di questo
affascinante mondo con le scienze sociali e la filosofia. Sparti aveva già affrontato
alcuni nodi legati alla pratica dell'improvvisazione nel libro sopra citato e nel
successivo Il corpo sonoro. Oralità e scrittura nel jazz (2007).
Ora la cartina tornasole utilizzata per studiare l'improvvisazione è quella, fortemente
innovativa in ambito jazz, dell'identità. Spunto iniziale di questa analisi un paradosso
sapientemente illustrato dallo scrittore Ralph Ellison, ripreso più volte
nel corso del saggio: "Esiste (…) una contraddizione crudele implicita nella
stessa forma artistica (il jazz): il jazzista deve perdere la sua identità
anche mentre la trova".
Il jazzista che improvvisa corre ben due rischi, ci avverte Sparti:
in primo luogo quello di fallire, di non trovare l'originalità, ma esiste anche
il pericolo di smarrirsi nel tentativo di esplorare territori incontaminati e di
non trovare il filo conduttore per tornare a casa dopo il solo.
Sono considerazioni iniziali di un testo tutto da scoprire che
sviscera questi "paradossi" dell'improvvisazione. Operazione non banale, poiché
come ci segnala l'autore: "Chi pratica l'improvvisazione non ha necessariamente
bisogno di elaborare un concetto di improvvisazione (perché dovrebbe, dato che tale
impresa concettuale non garantisce un guadagno estetico?)".
Se i musicisti possono permettersi una prassi senza una teoria (che non sia quella
musicale in senso stretto, ovviamente) è altrettanto evidente che un discorso su
questo tema presenta aspetti tanto fertili da interessare finalmente anche i filosofi,
i sociologi, i semiologi e tutti coloro che a vario titolo si sentono attrezzati
con i mezzi adatti a coniugare queste discipline al jazz.
Dopo questo denso preambolo il lavoro si dipana lungo i binari di una speculazione
scientifica sul tema del identità personale condotto adottando riferimenti alti
(Arendt, Pizzorno, Goffman) e facendoli interagire con esempi, prassi, affermazioni
tratte dal mondo del jazz. Proprio da questo primo capitolo è tratta una deliziosa
testimonianza di Miles Davis, quasi una programmatica dichiarazione d'intenti
artistica: "Talvolta devi suonare a lungo prima di riuscire a suonare come te
stesso".
Nel saggio sono tante le citazioni di jazzisti quali Joe Henderson,
Max Roach,
Charles
Mingus e di molti altri, scelte con cura a illustrare -con esempi presi,
per così dire, sul campo- quanto siano complessi i discorsi che si possono costruire
attorno all'improvvisazione e le riflessioni che ne scaturiscono. Questo perché
nell'improvvisazione si possono leggere spinte all'eccesso le tensioni che l'artista
deve affrontare, stretto fra la spinta a trasformarsi per essere originale e la
necessità di definirsi per essere riconoscibile al pubblico e forse anche a se stesso.
Le figure che secondo l'autore meglio si prestano a suffragare questa analisi sono
due: quella di
John Coltrane, che riceve una attenzione particolare e la Arkestra
di Sun Ra, paradigma dei problemi dell'identità relativi a un collettivo
musicale (e insieme esistenziale) rimasto insieme per decenni sotto la guida di
un leader carismatico.
Con il terzo capitolo, dedicato all'improvvisazione e al versante
filosofico del tema che riguarda l'identità, il libro tocca davvero questioni nuove.
I contributi intellettuali di Michel Foucault e Hannah Arendt sull'agire umano vengono
messi in relazione all'improvvisazione jazzistica. Particolarmente interessante
è l'uso di Foucault. Un autore, come ha scritto Rudy M. Leonelli presentando
gli atti di un convegno dedicato al rapporto Foucault-Marx, passato dall'ostracismo
durato fino agli anni Ottanta all'odierna assimilazione culturale "senza traumi".
Eppure, continua Leonelli, il tratto che possiamo individuare come distintivo della
sua opera si situa nella sospensione, la rottura delle nostre evidenze, il turbamento
e la trasformazione simultanea del modo in cui ci rapportiamo al "nostro" passato
e a questo presente [1]. Uno dei
concetti di Foucault che caratterizzano questa rottura delle evidenze di cui parla
Leonelli viene utilizzata da Sparti per interpretare alcuni degli aspetti meno indagati
del campo dell'improvvisazione e che pure ne costituiscono una specificità. Quale
rapporto si viene a creare tra l'improvvisatore che durante il solo si mette in
gioco, spesso in profondità, e la sua identità? Il sé per Foucault non rappresenterebbe
un nucleo sepolto da liberare ma un materiale da trasformare con la pratica.
L'altro concetto, collegato, prende in considerazioni quelle procedure attività
che l'uomo compie su stesso, sul proprio modo d'essere sulla propria condotta per
migliorarsi, per raggiungere un certo stato di purezza, saggezza o felicità (tecnologie
del sé). Molto opportunamente a questo proposito Sparti cita a più riprese l'esempio
e le parole di
Sonny Rollins, maestro riconosciuto dell'improvvisazione. Nel
corso di una performance prima fai le cose previste poi te ne dimentichi. Così
per Sonny
Rollins, con una affermazione che per Sparti riecheggia tesi riconducibili
a Nietzsche e riportano, in ambito squisitamente jazzistico, all'iniziale affermazione
di Ralph Ellison.
La collezione di tecniche adottate dagli improvvisatori per forzarsi
all'originalità durante la loro attività quotidiana viene rappresentata da un congruo
numero di citazioni che costituiscono un compendio di saggezza zen-jazz. Mi sono
tolto di mezzo, dice
Jim Hall
come ad intendere di fare un passo indietro e osservare l'assolo che si svolge quasi
da sé. Altri musicisti teorizzano l'uso di strumenti diversi da quelli usuali per
poter esprimere una voce diversa e non ristagnare nella memoria anche fisica e gestuale
che si attiva quando si imbraccia il proprio. Il caso emblematico è
Ornette
Coleman che posa il sax per imbracciare la tromba (e il violino, aggiungo
io) per ottenere effetti stranianti, ma anche innovativi e diversi da quelli considerati
"normali". Forse la miglior formulazione teorica di questa disposizione d'animo
verso l'improvvisazione l'ha pero concisamente fornita Sun Ra: suona le
cose che non sai!
Sviscerati questi aspetti dell'estetica jazz in rapporto all'improvvisazione
all'identità del musicista come singolo, il libro vira nuovamente verso gli aspetti
sociali. La conclusione mette quindi in luce come la faticosa pratica dell'improvvisazione
nel jazz sia un fenomenale dispositivo identitario, almeno per la comunità afroamericana.
L'improvvisazione è, appunto, la ripetizione simbolica di
un atto fondatore di una comunità che non rimanda ad un'origine ma è segnata dalla
perdita comune, di cui si fa esperienza e che ritorna in forma esteticamente sublimata.
Collegandosi in una visione quasi psicanalitica alla vicenda della diaspora
degli schiavi neri, trascinati a forza dalle coste dell'Africa al nuovo mondo, sfruttando
la potenzialità delle recenti teorie sull'importanza di un "Atlantico Nero", triplice
luogo geografico, storico e simbolico, Sparti ci fornisce una chiave filosofica
originale nel leggere questa musica. Verrebbe da dire, sfruttando titolo e leit-motifs
del saggio, che nel jazz l'improvvisazione rappresenta questa identità perduta;
identità che, proprio nella sua genetica incompiutezza, alla fine riesce a ritrovarsi.
Franco Bergoglio per Jazzitalia
[1] Foucault-Marx. Paralleli e paradossi, a cura di Rudy
M. Leonelli, Roma, Bulzoni editore, 2010, p. 9. Di questa recente pubblicazione
segnalo, tra gli interventi, oltre alla premessa citata e al saggio di Leonelli,
una bella intervista al filosofo étienne Balibar.
Inserisci un commento
Questa pagina è stata visitata 5.299 volte
Data pubblicazione: 25/07/2010

|
| 
